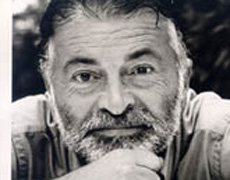 Si fa il possibile/ per questa gente”/ ti dicono di noi,/ “per farla stare meglio:/ da bere e da mangiare/ piu` che sufficiente,/ e sonno quanto basta,/ le loro messe, i libri,/ ore di svago e di riposo.”/ Ma e` un altro, il nostro,/ differente stato/ inerte e doloroso.
Si fa il possibile/ per questa gente”/ ti dicono di noi,/ “per farla stare meglio:/ da bere e da mangiare/ piu` che sufficiente,/ e sonno quanto basta,/ le loro messe, i libri,/ ore di svago e di riposo.”/ Ma e` un altro, il nostro,/ differente stato/ inerte e doloroso.
Con questi versi che introducono “Le stanze del cielo” Paolo Ruffilli conduce il lettore nel territorio di un’antichissima paura: l’ossessione della perdita della propria liberta`.
Un’esperienza “carceraria” totalizzante, estrema e drammatica attraversa lo sguardo del poeta: “Grate e cancelli da ogni/ parte, intorno, tetri cortili/ dalle altissime mura.” Uno spazio angoscioso e angosciante con il quale l’io entra in relazione svelando un mondo “interno” ed “esterno” dal quale il lettore sembra di non poter piu` uscire.
Sul mondo “Crollare in alto/ sul mondo steso/ laggiu` in basso,/ sugli altri/ esseri mortali…/ Ti sale dentro/ facendoti sdraiare/ sul velluto/ e via planare/ volante sul tappeto/ perdutamente solo/ tu gigante in cielo./ Lucida spada,/ che ti attraversi/ e ti trafigga,/ che tagli il filo/ portandoti via da tutto/ ma, da te stesso, mai.”
Le stanze del cielo, di Paolo Ruffilli, Marsilio (2008)
Intervista di Luigia Sorrentino
“Le stanze del cielo”, come nasce l’idea di questo suo nuovo libro di poesie che è già alla terza ristampa?
Nasce dietro all’ossessione della perdita della libertà. Io scrivo sempre e solo andando dietro alle mie ossessioni. E, questa della perdita della libertà, mi perseguita fin da piccolo, coltivata attraverso le favole e i racconti e poi la letteratura (i russi, in particolare, come Dostoevskij di “Delitto e castigo” o come Cechov dei racconti). Ho sempre sentito la perdita della libertà, per colpa propria o altrui, uno dei drammi più grandi. E non serve arrivare alle situazioni estreme della cella di un carcere o della tirannia della droga, per saperlo. Ciascuno di noi quotidianamente vive l’esperienza della perdità della libertà perché da solo si impone vincoli e catene, impedendosi di vivere liberamente. La letteratura, in ogni caso, è sempre metaforica (più in generale, lo stesso linguaggio): si dice una cosa per intenderne un’altra o molte altre.
Leggendo il libro si ha la sensazione che lei abbia conosciuto molto da vicino la realtà del carcere, ma non è così. So che lei non è mai entrato in un carcere. Insomma, la realtà che descrive che fondamento ha? Che io è il suo? E come fa a calarsi in una soggettività così diversa dalla sua?
Per me scrivere vuol dire usare l’immaginazione. Immaginazione, non nel senso del frainteso uso comune di facoltà arbitraria, ma nel senso che intendeva Einstein quando rimproverava i suoi colleghi che non la usavano per arrivare dove l’intelligenza non era ancora in grado di spiegare. L’immaginazione ha una sua logica ferrea. E’ forse l’unico modo per sapere qualcosa di più della così detta realtà. Non certo il realismo, come mera descrizione e registrazione di ciò che si vede e si tocca… Io non descrivo mai un luogo dove sono stato per così dire fisicamente, ma sempre un luogo dove andrò. Perciò non ho mai pensato di entrare in prigione ad intervistare i carcerati per poi trasformare le loro confidenze in poesia. In carcere sono entrato solo dopo l’uscita del mio libro, invitato a leggere le mie poesie da molte case circondariali e dai carcerati, che si sono ritrovati nelle mie parole. L’immaginazione è capace di far questo. Naturalmente, perché pesca in un serbatoio che neppure immaginiamo di avere, dove si sono depositate nel tempo infinite informazioni attraverso ciò che abbiamo visto, sentito, letto… Come diceva Jung.
C’è una relazione, secondo lei, tra il suo mondo “interno” e ciò che descrive, il mondo “esterno”?
La relazione è assoluta e proprio perché non “descrivo”, mai, ma do’ pronuncia alle parole come mi “ditta dentro” (Dante). La parola necessaria e sufficiente non è mai descrittiva. E’ la musica di una verità che viene dal profondo. La poesia, in particolare, è una pratica esoterica o, se si preferisce, una pratica magica. Perché è fatta di parole magiche, capaci di evocare la realtà, altrimenti indefinibile. E’ con le parole magiche che arriviamo dove, se no, non si arriva mai. Meno che mai con le parole del buon senso.
La sua poesia sembra “la poesia degli altri”. E’ come se il suo io venisse totalmente cancellato e messo al servizio della collettività. E’ così?
Ho sempre avuto una capacità, probabilmente innata, di rovesciarmi nelle vite degli altri. E rovesciarmi nelle vite degli altri è quello che faccio scrivendo, certo a partire dalla mia vita. Ma l’autobiografia, per me, non ha mai conseguenze autobiografiche. La mia vita, come scrittore, conta nel momento in cui riesce ad infilarsi nelle vite degli altri.
Qual era il suo obiettivo? cosa le interessava mettere in evidenza? La reclusione o l’essere reclusi?
Non c’era un obiettivo, almeno come intenzione consapevole. Sono andato dietro alla mia ossessione, che evidentemente aveva il suo obiettivo. Niente è più coerente di un’ossessione. Ho imparato col tempo a fidarmi delle mie ossessioni e ad andargli dietro. Da giovane, resistevo. La mia formazione illuministica e scientifica mi aveva messo i paraocchi e mi impediva di essere veramente libero. Ho impiegato più di trent’anni a liberarmi davvero e a lasciare agire, accanto all’esercizio dell’intelligenza (non per questo mai cessato), il buio luminoso che emerge dal profondo. E’ in quella luce che paradossalmente è prodotta dal buio che prendono corpo i veri obiettivi.
La sua è una poesia quasi narrativa e per niente lirica. Una cifra da lei scelta fin dagli anni Settanta… Qual è la ragione di questa scelta?
Non ho fatto nessuna scelta o, per lo meno, mi sono lasciato guidare dall’istinto. Del resto, era già inscritto nella mia indole… Sono stato un narratore orale precoce. Alle scuole elementari il maestro mi usava, quando era stanco, per intrattenere i miei compagni. Mi chiamava alla cattedra e io cominciavo a raccontare storie inventandole sul momento. Così, per me, tutto è sempre racconto. Anche in poesia, naturalmente. Né mi sono mai lasciato condizionare dalle mode o dalle indicazioni della critica. Le parole che scrivo sono quelle che mi dittano dentro, come dicevo. E la parola che ditta dentro esce come deve uscire. Con la sua musica unica e in condizionabile. Ed è la musica giusta. Perché, poi, in poesia la musica è tutto. Ma, non solo in poesia, in tutta la mia scrittura, ciò che mi interessa e che conta è la partitura musicale. Proprio perché le ossessioni sono sempre ossessioni musicali.
