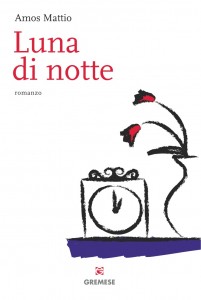 Luna di notte, di Amos Mattio ed. Gremese, 2012 (€ 12)
Luna di notte, di Amos Mattio ed. Gremese, 2012 (€ 12)
(Il romanzo è nella rosa dei dodici finalisti al Premio Strega 2012).
LUNA DI NOTTE: UN ROMANZO NEOALESSANDRINO
di Anna Savastano
E’ notte di luna piena il trenta di luglio in cui Giovanni, il protagonista del romanzo, è giunto a un crocevia della vita: ha trent’anni ed ha un conto in sospeso con la propria esistenza. Ma la luna, complice del suo solipsismo, ha in serbo molte sorprese, tra cui quella di scardinare i progetti immediati e quelli di lunga data suoi e di molti altri.
Così si avvia il romanzo d’esordio di Amos Mattio, le cui valenze sono molte, a seconda dell’approccio del lettore. I primi capitoli hanno i caratteri della letteratura poliziesca : siamo di fronte alla scena del crimine e lo sguardo dell’investigatore passa lentamente in rassegna i minuti particolari, attento all’atmosfera, alle relazioni fra gli oggetti, alle congruenze e alle incongruenze, ripercorrendo le presunte motivazioni del gesto. Il narratore onnisciente sa, perciò il campo visivo ora si restringe, ora si allarga, vaga e divaga, si concentra nell’ambiente chiuso, ma subito spazia all’esterno, dove una luna piena incombe su una città afosa e sonnolenta. Emergono particolari come tasselli disordinati, emozioni, ricordi, coincidenze astrali con esperienze personali in un silenzio irreale, sospeso su un rito che richiede di trattenere il fiato. Un lumicino che muore, una goccia che scende a ritmi regolari su una massa d’acqua che si rigonfia. La vittima sacrificale affonda gradualmente nel vuoto che si è fatto intorno, ma in un altro punto della città qualcuno veglia e, colto dall’inquietudine per un’assenza che non si sa spiegare fino in fondo, decide di agire. La scena si anima dei personaggi del dramma, personaggi che pensano, che parlano , o che l’autore sbozza per renderli subito riconoscibili al lettore, prima che l’azione ne definisca l’identità. Che talora è del tutto imprevedibile, come nel caso di Alfio, il coprotagonista della storia, o di Anna che si presenta come sbiadita moglie per poi rivelarsi torbida tessitrice d’inganni.
Ma ecco affacciarsi un altro registro nel romanzo, quello onirico – introspettivo. Giovanni, il protagonista, nel torpore delle forze che cedono, ha delle visioni che alternano deliri a scampoli di vita vissuta, frammenti di ricordi, spruzzi di colore, grovigli di natura, rimpianti di emozioni perdute. Puntuale, da questo momento, il sogno, o il delirio, caratterizzerà le figure dei protagonisti , personaggi che sotto le apparenze portano dentro conflitti non risolti, drammi accantonati, apparentemente rimossi. Traumi imprevisti fanno aggallare memorie sepolte e tramite la via del subconscio ricostruiscono momenti di esperienza fondamentali nella loro vita.
La narrazione assume ora, grazie all’espediente del sogno delirante, il carattere di un romanzo iniziatico. Viene alla mente La linea d’ombra, il romanzo di Conrad sull’esperienza di un giovane che vuole mettersi alla prova per far vedere quanto vale, per lottare contro un’immagine della vita che è ” calma piatta, grande specchio della mia disperazione”, come recita il verso di Baudelaire posto come epigrafe all’opera di Conrad. E’ la linea d’ombra quella che attrae e spaventa Giovanni, in questo caso un plenilunio che segna il confine della giovinezza. Scontento della sua calma piatta, nel tentativo di imprimere una svolta alla propria vita, rischia di soccombere e solo una discesa nel profondo può salvarlo. Qui, nel romanzo di Amos Mattio, il protagonista, che riconosce di non essere un eroe, capisce che per attraversare la sua linea d’ombra non può essere solo, che ha bisogno della risolutezza di altri, ancorché timorosa. Di Alfio, uomo ormai maturo, non sappiamo a quale consapevolezza giungerà dopo il delirio conseguente a un trauma fisico. Forse a giudicare con meno supponenza? Oppure ricadrà nelle malie di Anna, la moglie intrigante piccolo borghese?
L’intrigo è un altro elemento che caratterizza il romanzo di Mattio. Un intrigo che ricorda il romanzo alessandrino, un romanzo d’amore con separazioni sofferte, allontanamenti forzati che trovano soluzione in impreviste agnizioni, grazie a segni di riconoscimento casuali. La vita è un intrico di casualità, pare dirci Mattio, anche quando gli individui pensano di essere costruttori del proprio destino. Ma dietro a queste casualità c’è un disegno, una ragione che tiene le fila, le ordisce e dà un senso agli eventi. Il finale conferma il modello alessandrino, le cui radici sono evidenti già nell’ultimo Euripide, quello che si ribella alla Necessità tragica e senza riscatto. Qui, come tra gli antichi (ma non dimentichiamoci la fabula alessandrina de I promessi sposi!), è l’amore la leva della salvezza e della rinascita.
Un’attenzione particolare, infine – sebbene da subito evidente – è imposta dal tessuto della scrittura. La prosa ritmica, controllata, ora realista, ora visionaria, letteraria, gergale, ironica, ha il pregio di produrre nel lettore l’emozione del verso poetico assieme all’ansiosa curiosità di scoprire lo sviluppo della vicenda.
