 “Un’ora fa, più o meno, era vuoto il palcoscenico sul quale mi trovo, e vuoti tutti gli scanni che voi occupate. Tra un’ora saranno vuoti di nuovo. Questo posto rimane deserto, immagino, quasi tutto il giorno; il vuoto è il suo stato naturale. Se avesse avuto in dono una coscienza propria, giudicherebbe la nostra presenza una seccatura. E’ un modo come un altro per illustrare la rilevanza di un essere umano o, certamente, in ogni caso, la rilevanza di questa nostra riunione. Qualunque sia il motivo che ci porta qui, le cifre non giocano a nostro favore. Possiamo anche essere soddisfatti del nostro numero, ma in termini spaziali è un numero di importanza infinitesimale.
“Un’ora fa, più o meno, era vuoto il palcoscenico sul quale mi trovo, e vuoti tutti gli scanni che voi occupate. Tra un’ora saranno vuoti di nuovo. Questo posto rimane deserto, immagino, quasi tutto il giorno; il vuoto è il suo stato naturale. Se avesse avuto in dono una coscienza propria, giudicherebbe la nostra presenza una seccatura. E’ un modo come un altro per illustrare la rilevanza di un essere umano o, certamente, in ogni caso, la rilevanza di questa nostra riunione. Qualunque sia il motivo che ci porta qui, le cifre non giocano a nostro favore. Possiamo anche essere soddisfatti del nostro numero, ma in termini spaziali è un numero di importanza infinitesimale.
Questo vale, penso, per qualsiasi assemblea umana; ma quando c’è di mezzo la poesia tocca un tasto particolare. In primo luogo, la poesia, per chi la scrive come per chi la legge, è un’arte che comporta un’atomizzazione; è assai meno sociale della musica o della pittura. E poi la poesia ha una certa inclinazione per il vuoto, a cominciare, diciamo, da quello dell’infinito. Ma il dato principale, dal punto di vista storico, è che la proporzione fra il pubblico che si rivolge alla poesia e il resto della società non è certo entusiasmante. Così dovremmo congratularci tra noi, se non altro perché la nostra presenza qui, nonostante la sua apparente irrilevanza, è una continuazione di quella storia che, stando ad alcune voci circolanti intorno a questa città, sarebbe finita per sempre.
In ogni fase di quella che chiamiamo la storia documentata la poesia ha avuto un pubblico che non sembra mai aver superato l’un per cento dell’intera popolazione. La base per questa cifra non è qualche indagine specifica, bensì il clima mentale del mondo in cui viviamo. Anzi, hanno prevalso sempre condizioni metereologiche tali che la cifra suddetta sembra un tantino generosa. Né l’antichità greca né quella romana, né il glorioso Rinascimento né l’età dei Lumi destano in noi l’impressione che la poesia si tirasse dietro uno stuolo di fedeli – meno che mai legioni o battaglioni – o che avesse grandi schiere di lettori.
Non è mai successo. Quelli che chiamiamo i classici devono la loro reputazione ai posteri, non già ai lettori contemporanei. Ciò non significa che la posterità sia l’espressione quantitativa del loro valore: significa solo che essa procura, sia pure retroattivamente e con qualche fatica, un più ampio pubblico di lettori, quello al quale avevano diritto fin dall’inizio. Nella realtà la cerchia in cui erano conosciuti da vivi era in genere alquanto angusta corteggiavano i mecenati o facevano ressa alle corti più o meno come i poeti di oggi bazzicano le università. A spronarli, ovviamente, era la speranza di qualche munificenza, ma anche la ricerca di un pubblico. Poichè l’alfabetismo era privilegio di una minoranza, dove altro un poeta poteva trovare un orecchio sensibile o un occhio attento ai suoi versi? La sede del potere era spesso la sede della cultura; e lì il regime alimentare era più ricco, la compagnia meno monocroma e più umana che da altre parti, compreso il monastero.
Passarono i secoli. Le sedi del potere e le sedi della cultura si divisero, e per sempre, a quanto pare. E’ il prezzo, naturalmente, che si deve pagare, per la democrazia, per il governo del popolo, retto dal popolo e per il popolo, quel popolo di cui ancora oggi solo l’uno per cento legge poesia. Se c’è qualcosa che un poeta moderno ha in comune con alcuni suoi colleghi del Rinascimento, è in primo luogo la misera diffusione della sua opera. E’ un destino comune, con aspetti archetipici di cui, secondo il proprio temeperamento, ci si può anche compiacere: si può andar fieri di essere o trarre ancora un certo conforto dalla propria rassegnazione, visto che ha così illustri precedenti. Dal punto di vista psicologico, non c’è incoraggiamento migliore che stabilire un nesso tra sé e le glorie del passato, se non altro perché il passato è più articolato del presente (per non parlare del futuro).” [….] Continua in libreria
Da: “Dolore e ragione” di Iosif Brodskij, Adelphi Edizioni, 2003 (18 euro)
Traduz. di Gilberto Forti
Discorso tenuto nell’ottobre del 1991 alla Library of Congress di Washington che in quell’anno aveva designato Brodskij quale <<poeta laureato>>.
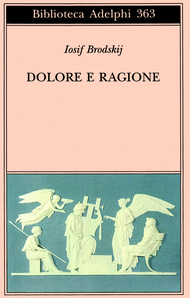 Dal risvolto di copertina
Dal risvolto di copertina
“Dolore e ragione” apparve a New York nel 1995, poche settimane prima della scomparsa dell’autore – e così offrendosi inevitabilmente come opera testamentaria. Di fatto, leggendo i tre grandi saggi su Frost, Hardy e Rilke che fanno da perno al libro, risulta difficile immaginare un grado ulteriore di comprensione: sono prove stupefacenti di come si possa leggere e illuminare un testo passo per passo, sillaba per sillaba, quasi aderendo alla tensione muscolare della mano del poeta che scrive. Accostando i saggi qui presentati a quelli su W.H. Auden, Marina Cvetaeva e Konstantinos Kavafis pubblicati in precedenza, vedremo delinearsi un paesaggio della poesia moderna nuovo e idiosincratico, ben più convincente di quelli offerti dalle varie scuole accademiche. Ma parlare di questi autori, per Brodskij, ha sempre significato parlare di tutto e del tutto, poiché per lui la poesia era «l’unica assicurazione disponibile contro la volgarità del cuore umano». Per questo non volle mai pubblicare un volume di saggi strettamente letterari e preferì vagare nel tempo, che è il vero medium del pensiero, unendo l’accidentalità autobiografica e l’evocazione delle ombre, che qui convergono nella memorabile Lettera a Orazio.
In copertina “L’apoteosi di Omero” terraglia diaspro realizzata dalla manifattura Etruria di Wedgwood su progetto di J. Flaxman (1778). British Museum, Londra

Pingback: un’arte che comporta un’atomizzazione RAINEWS24 « letture della diaria