 Julia Hartwig ha 86 anni. E’ nata a Lublino, in Polonia nel 1921. Insieme alla contemporanea Wislawa Szymborska, è considerata una delle maggiori poetesse del Novecento. Nel 2007 la prima antologia di poesie della Hartwig, dal titolo “Sotto quest’isola” , traduzione di Silvano De Fanti con una breve presentazione di Annalisa Comes, viene pubblicata dall’editore Donzelli. Esplode in Italia il fenomeno Hartwig. Alfonso Berardinelli, uno dei più importanti critici italiani, dopo aver letto la Hartwig scrive: “Ecco il ritmo che sa chiudere il mondo in una goccia d’acqua.” Il libro, presentato in prima assoluta al festival di RomaPoesia 2007, è stato l’occasione per incontrare la Hartwig e realizzare in esclusiva questa intervista, la prima in Italia della grande scrittrice polacca.
Julia Hartwig ha 86 anni. E’ nata a Lublino, in Polonia nel 1921. Insieme alla contemporanea Wislawa Szymborska, è considerata una delle maggiori poetesse del Novecento. Nel 2007 la prima antologia di poesie della Hartwig, dal titolo “Sotto quest’isola” , traduzione di Silvano De Fanti con una breve presentazione di Annalisa Comes, viene pubblicata dall’editore Donzelli. Esplode in Italia il fenomeno Hartwig. Alfonso Berardinelli, uno dei più importanti critici italiani, dopo aver letto la Hartwig scrive: “Ecco il ritmo che sa chiudere il mondo in una goccia d’acqua.” Il libro, presentato in prima assoluta al festival di RomaPoesia 2007, è stato l’occasione per incontrare la Hartwig e realizzare in esclusiva questa intervista, la prima in Italia della grande scrittrice polacca.
L’intervista di Luigia Sorrentino
Da quanti anni scrive poesie, Julia?
“Da molto tempo. Fin dal periodo della mia infanzia.”
Lei era già stata in Italia?
“Sono stata in Italia molte volte a partire dall’Università e poi più tardi sono tornata per conoscere meglio l’Italia. ”
Che effetto le fa venire nel nostro Paese in occasione dell’uscita della sua prima raccolta di poesie in lingua italiana?
“Sono molto contenta. Non mi aspettavo che una delle prime edizioni straniere venisse pubblicata proprio in Italia. In questo momento stanno preparando l’ edizione americana del mio libro, una raccolta di poesie presso l’editore Knoph. Ho questa duplice occasione e felicità di avere dei lettori da una parte e l’altra dell’oceano.”
Quanti libri di poesie ha scritto?
“Ho scritto una quindicina di raccolte di poesie ed alcune scelte di poesie.”
Nel 1943 lei ha 22 anni. In quell’anno i tedeschi rivelano l’esistenza delle fosse di Katyn dove vengono ritrovati i corpi di circa 4.500 ufficiali polacchi uccisi, secondo i tedeschi, dai russi, con un colpo alla nuca nel 1940. Erano quelli gli anni delle deportazioni, più di 380 mila polacchi furono deportati tra il 1940 e il 1943… Che cosa ricorda di quella orribile pagina di storia?
“E` stato un momento molto duro. I tedeschi si comportarono con i polacchi così come i russi si erano comportati con i polacchi. Noi ci trovavamo nella più totale disinformazione… non avendo fonti credibili, i russi dissero che erano stati i tedeschi a commettere le stragi di Katyn. Eravamo in una situazione tale che per noi potevano essere stati sia i tedeschi sia i russi… Solo successivamente, attraverso la comparazione di dati con nuovi dati storici, ci siamo resi conto che erano stati i sovietici. L’unica nostra fonte credibile era “Radio Europa Libera”, la sola a dare notizie che dal punto di vista storico si sono rivelate giuste. E “Radio Europa Libera” fin dal primo momento aveva detto che erano stati i sovietici.”
Lei è unanimemente riconosciuta come una delle massime voci della poesia polacca del Ventesimo secolo. Contemporanea di un’altra grande poetessa, Wislawa Szymborska e grande amica di Ryszard Kapuscinski, il giornalista che ha raccontato rivoluzioni, guerre, colpi di Stato… Qual è il suo rapporto con la Szymborska e che ricordo ha di Kapucscinski?
“La Szimborska è una mia collega di lavoro. Ci conosciamo molto bene. Sono stata molto felice quando ha vinto il premio Nobel. Kapuscinski, invece, era un mio amico carissimo… amico del cuore… Ci sentivamo spesso al telefono perchè lui non aveva tempo… era occupatissimo… Sono stata molto contenta quando ho visto che Kapuscinski negli ultimi anni è ritornato a scrivere poesie e che quindi si sentisse parte della famiglia dei poeti.”
Che cosa le manca di più di Kapuscinski?
“Da un lato mi manca ciò che noi possiamo considerare la sua parte pubblica, vale a dire, la sua capacità di vedere e raccontare quello che succedeva nel mondo. Dal punto di vista privato mi manca il suo rapporto nei confronti delle persone, la sua capacità di amare le persone, la sua capacità di ascoltare. Sotto quest’aspetto Kapuscinski era un essere umano assolutamente raro.”
Torniamo indietro di qualche anno… Siamo nel 1939. Forse in quegli anni viveva ancora a Lublino, dove era nata, nel 1921…. Nel 1939 Hitler reclamava l’annessione al Reich della libera città di Danzica ed esigeva speciali diritti di passaggio attraverso il territorio polacco… Julia, che cosa ricorda di quegli anni?
“Nel 1939 avevo 18 anni e mi stavo preparando all’esame di maturità, e quindi mi predisponevo ad affrontare un nuovo periodo della mia vita. Ci rendevamo tutti conto che si trattava dell’invasione del Terzo Reich alla Polonia, però non eravamo assolutamente in grado di vedere, di capire, quali sarebbero state le conseguenze di quell’aggressione. Nessuno poteva immaginare che sarebbero stati così crudeli.”
Come venivate informati di ciò che stava accadendo? Quali erano i mezzi di informazione di cui disponevate?
“E’ un’ ottima domanda… In effetti noi eravamo tagliati fuori da ogni informazione. Avevamo soltanto la cosiddetta ‘carta straccia’, cioè la propaganda, i giornali di propaganda, degli occupanti. Tutti gli apparecchi radio erano stati confiscati . Però alcuni di noi di nascosto ogni tanto riuscivano ad ascoltare la radio e soprattutto l’unica fonte accessibile, che era, come ho detto prima, Radio Europa Libera.”
Che cosa faceva il quel particolare momento della sua vita?
“In Polonia iniziò subito la cospirazione politica con la formazione di gruppi di partigiani che si rifugiavano nei boschi. Anche io feci parte di uno di questi gruppi. Facevo il corriere di informazione tra un gruppo e l’altro. Ma quello fu anche il periodo in cui iniziai a leggere moltissimo, perchè insieme alla cospirazione politica, all’attività partigiana, iniziai anche l’attività cospirativa intellettuale. Nacque la cosiddetta Università clandestina a Varsavia e io andai a Varsavia a seguire i corsi di Lingua e Letteratura Polacca presso questa università clandestina…”
Come faceva a frequentare un’università che era clandestina?
“Ero stata mandata da Lublino a Varsavia dalla mia professoressa di ginnasio. A Varsavia mi fu anche data una stanza dove alloggiare. In gruppi di cinque o sei studenti andavano a lezione a casa dei professori . Non era possibile frequentare l`università, si rischiava di essere fucilati. Un gruppo di studenti subì questa sorte proprio in quel periodo.”
Lei in quegli anni era già una giovane poetessa. Come svolgeva la sua attività di poeta?
“All`epoca, a Lublino, dove abitavo, c’era un gruppo di intellettuali più anziani che avevano soggiornato in Unione Sovietica e che poi si erano trasferiti a Lublino. Questi scrittori invitavano i giovani autori a far parte dell’Associazione degli scrittori…” E così le mie prime poesie uscirono in un’antologia, “I poeti di Lublino”. Fu la mia prima pubblicazione. Successivamente mi trasferii a Cracovia dove era stata trasferita l’università di Varsavia in quanto Varsavia era stata completamente distrutta. Poi da Cracovia mi trasferii a Uch, il centro relativamente più vicino a Varsavia, ricco di case editrici e tipografie dove era possibile svolgere un’attività di scrittura.”
Il suo primo libro di versi è del 1944. Che cosa scriveva Julia in quegli anni?
C’è qualche poesia di quegli anni in questa antologia pubblicata da Donzelli?
“Ironicamente posso dire che la mia evoluzione di poetessa è avvenuta molto tardi e ha prodotti risultati più positivi di quelli che avevo raggiunto da giovane… quindi, sarebbe stato assurdo per me inserire in una antologia contemporanea una vecchia poesia.”
Nel 1947 lei va a vivere in Francia, con una borsa di studio del governo polacco. Va a studiare la poesia francese del Diciannovesimo e Ventesimo secolo…. Una rinascita spirituale, dopo tanti orrori.
” E’ stato un periodo molto importante nella mia vita dal punto di vista formativo. Mi sono fermata in Francia per quattro anni. Ed è stato proprio il periodo trascorso a Parigi a dare l’indirizzo preciso a ciò che avrei fatto da grande. Fu un grande trauma culturale dopo gli orribili tempi dell’occupazione. Quei quattro anni li ho passati soprattutto per le strade di Parigi, nei musei e nella biblioteca nazionale. Così, il soggiorno in Francia, e soprattutto la conoscenza della poesia francese, è stato un elemento molto significativo per la mia formazione, per la mia immaginazione. Ho capito come avrebbe dovuto essere la mia poesia.”
In Francia ha incontrato suo marito, Artur Miedzyrzecki, poeta, saggista e narratore….
“Ho incontrato mio marito, Artur Miedzyrcecki, in Francia. Aveva partecipato alle operazioni militari della campagna d’Italia durante la seconda guerra mondiale e poi era andato a studiare in Francia.”
Dal 1970 al 1974, invece, lei ha risieduto negli Stati Uniti con suo marito che insegnava in numerose università americane… Come erano gli Stati Uniti in quegli anni? Che ricordo ne ha?
“Sono partita dalla Polonia con poca voglia di andare a vivere negli Stati Uniti… Mi sentivo europea e volevo restare in Europa. E invece, quando sono ritornata, sono stata molto contenta dell’ esperienza che avevo fatto negli Stati Uniti. La cosa più importante per me, dal punto di vista letterario, è accaduta proprio con il ritorno in Polonia, quando ho scritto “Diario americano”, un libro dedicato all’America. Un testo che è andato subito esaurito. In quel periodo i rapporti della Polonia con gli Stati Uniti non erano dei migliori… e invece, io avevo un’ atteggiamento molto favorevole nei confronti degli Stati Uniti. Poi, sempre in quegli anni, ho anche pubblicato un’antologia di poeti americani che partiva da Edgar Allan Poe e arrivava ai poeti degli anni Settanta. La terza cosa che è avvenuta dopo il soggiorno negli Stati uniti, è stata la pubblicazione di un libro di poesie, “Poesie americane”, in cui ho cercato di usare un linguaggio che fosse nello spirito della letteratura americana.”
Poi è tornata nella sua Polonia che attraversava anni molto difficili dal punto di vista politico, fino al 1978, quando la Polonia sembra ritrovare una fierezza nazionale con l’elezione del cardinale arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo Secondo, il primo Papa polacco nella storia del Cristianesimo. Lei conosceva Papa Giovanni?
“Io non lo conoscevo personalmente, ma ho avuto il piacere di incontrarlo in Vaticano grazie alla mediazione di padre Boniecki, di Cracovia, direttore di un giornale molto importante, cattolico. Quando il Papa è venuto a sapere che erano in visita da lui anche degli scrittori polacchi, si è avvicinato e ha parlato con noi. Quando siamo andati via ci ha pregato di portare il suo saluto agli altri scrittori polacchi in patria.”
Che cosa pensa di Carol Wojtyla? Crede che davvero abbia contribuito al cambiamento della storia del suo Paese?
“Carol Wojtyla ha avuto una grande importanza per il cambiamento della storia del nostro paese perchè riusciva a dare coraggio alle nostre azioni. Infatti, è successa una cosa straordinaria quando il Papa è arrivato in Polonia. E’ come se quella popolazione fosse diventata improvvisamente più tranquilla, più benvolente rispetto agli altri. Quando il Papa ha celebrato la messa nel centro di Varsavia c’era un ordine e una disciplina che solitamente sono abbastanza estranei alla nostra popolazione.”
Solidarnosc, Lech Walesa, il generale Jaruzelski, le leggi marziali del 1981… Tutto il potere nelle mani del Comitato Militare… Sospensione delle leggi costituzionali… Più di 6.000 attivisti e leader di Solidarnosc internati… Frontiere chiuse e… persecuzioni dei cristiani. Julia, lei, che è stata Membro del Comitato cittadino presso il presidente di Solidarnosc quali mansioni svolgeva?
“Ci oppupavamo soprattutto di cultura. Partecipavamo a riunioni semi-legali. C’era sempre il rischio di essere arrestati nel momento in cui tornavamo a casa. A me non è successo… Ma la cosa più grande e più importante di quel periodo sono state le persone di grandissima dignità con le quali io lavoravo nell’attività culturale di Solidarnosh. Il periodo delle leggi marziali lo ricordo con grandissimo orrore. In quel periodo, infatti, c’è stato il tentativo di stroncare il desiderio di un’andata veloce verso la libertà e il fatto negativo è che questo tentativo è riuscito perchè anche nel nuovo sistema democratico la popolazione non ha più ritrovato quello slancio che aveva avuto prima dell’ introduzione dello stato di guerra.”
Lei ha conosciuto il leader di Solidarnosh, Lech Walesa. Come lo ricorda?
“Era una persona che non ha mai voluto essere qualcun altro. Era sempre se stesso. Era davvero quello che si potrebbe definire oggi un proletario dal punto di vista dell’origine. Non cambiava mai il suo linguaggio, usava sempre la sua lingua che alle volte alle persone poteva sembrare anche buffa, comica, qualche volta… perchè usava espressioni che solitamente nel linguaggio comune non venivano usate… Era sempre se stesso e questa era la sua grande virtù.”
Com’è oggi la Polonia?
“E` difficile rispondere a questa domanda… Dal punto di vista economico si può dire che le cose vanno bene… siamo molto contenti di far parte dell’Unione Europea. Ma ho paura che l’elemento conservatore cominci ad avere un ruolo troppo importante nella vita pubblica. ”
In una delle sue poesie, “Il sogno”, lei dice: “Il sogno mi teneva in suo potere, come sotto chiave… Non permetteva il risveglio…” Con chi dialogava Julia, e cosa sognava?
“In questa poesia mi identifico non solo con me stessa, ma con l`essere umano per il quale ho commiserazione. E vivo in qualche modo la vergogna perchè i miei sentimenti sono troppo visibili… E d’altro canto io detesto me stessa perchè mi sono identificata con la folla che mi sta guardando… Ma alla fine vince l’idea di misericordia, l’idea di unirsi con quelli che hanno perso e che sono morti”.
Che cos’ è la poesia per lei?
“La poesia è la mia vita e anche la risposta alla mia vita.”
In un’altra sua poesia lei dice: “Non ho potere”. Che cosa è per lei il Potere?
“Tutto il mondo si svolge senza il mio influsso senza il mio permesso . La natura funziona secondo le sue leggi. Il figlio che ho fatto nascere agisce secondo la sua volontà. Le lettere, le cartoline che scrivo vengono portate via dal vento e quindi non so nemmeno se arriveranno… la mia esitenza, e in qualche modo l’esistenza umana, è come se venisse derisa dalla natura… è come se io non avessi nemmeno il dono della grazia. In questo senso “non ho potere”, non in senso politico.”
Nella sua poesia lei spesso interpella la natura, in un dialogo intimo, confidenziale… una poesia definita “metafisica”, che tace su questioni teologiche, ma che ci concentra sulla ricerca di un’armonia “tutta terrestre”…. come definirebbe lei la sua poesia?
“In effetti la mia poesia è una ricerca dell`armonia… per questo si e` tentato di collocarmi nel filone classico anche se senza molto successo… Anche se potrebbe sembrare un po’ paradossale, quello che veramente vorrei dalla mia poesia è vedere e capire più cose del mondo.”
“Non c’è nessuno di cui avrei voluto e voglio seguire le orme. Però ritengo che qualsiasi poeta riesca a leggere altri poeti riesce anche a immagazzinare tutto quello che gli serve e diventa più ricco… Posso citare due poeti polacchi che ho letto molto: Jozef Czechowicz e Czeslaw Milosz.”
Lei ha tradotto in polacco poeti molti diversi tra loro… Rimbaud, Apollinaire, ma anche Allan Ginsberg e Sylvia Plath. Che cosa ha imparato da questi poeti?
“Sicuramente dopo aver conosciuto questi poeti il mondo mi si è allargato. Traducendo questi poeti si sono aperti decine e decine di percorsi attraverso i quali sarei potuta anche andare… ma non e` detto che si debba seguirli per forza… averli conosciuti per me ha significato imparare molte cose… poi però ho trovato la mia strada.”
Lei soffre per le ingiustizie del mondo?
“Soffrire forse è troppo… Diciamo che di fronte a certe sventure universali tutti proviamo gli stessi sentimenti. Forse posso dire di essere più sensibile di qualcun altro… Senza sensibilità non può esserci un poeta… Però Milosz diceva che se un poeta soffre troppo per i dolori altrui non potrà mai scrivere qualcosa di buono.”
Nella sua poesia dialoga con molte persone che hanno realmente fatto parte della sua vita… sua madre, il fratello, il padre… Come si può portare la propria storia dentro la poesia e far si che la poesia sia comunque universale?
“Il poeta che lega troppo il proprio modo di essere al modo di essere degli altri, non compie adeguatamente il proprio dovere. E’ molto labile il confine tra la vita privata e quello che si chiama poesia… a volte si può travalicare questo confine – ovviamente il poeta ha il diritto di travalicare questo confine – però lo deve fare nel modo giusto.”
Lei crede in Dio?
“Si dice : ‘Anche gli atei credono in dio’. Si dice così perché il solo dubitare l’esistenza di dio significa affermarla. Ho molta difficoltà a parlare delle mie convinzioni religiose… comunque, sono cattolica di nascita…”
Come si immagina il suo futuro?
“Non ho intenzione di vivere per secoli. Quello che desidero è pubblicare tre libri, due dei quali sono già pronti.
Che cosa desidera profondamente?
“Desidero soprattutto ciò che è impossibile realizzare… e cioè che tutta la gente viva bene al mondo.”
[Roma, Festival di RomaPoesia, 27 settembre 2007]
Il video dell’intervista
 Valentino Zeichen, uno dei più raffinati poeti contemporanei italiani, racconta la sua “pagina di storia”. Era ancora bambino quando alla fine della Seconda guerra mondiale con l’esodo massiccio degli Italiani d’Istria lasciò Fiume, la città dove è nato, per trasferirsi con la famiglia a Roma, dove tuttora vive. La casa in cui Zeichen abita e che fin da quando ci siamo conosciuti, nel 1986, definisce con sottile ironia “una baracca”, si trova sulla via Flaminia, una delle strade più antiche della capitale, luogo ideale per il poeta che ha riconosciuto in Roma e nella Romanità la sua vera origine. Abbiamo incontrato Valentino Zeichen, “il poeta che a volte sorride, a volte si incupisce, in una densità varia di umori e negli scatti di un’intelligenza sempre agli antipodi dell’ovvio”, a Fabriano, nelle Marche, alla prima edizione di Poiesis, il Festival dedicato alla poesia curato da Francesca Merloni.
Valentino Zeichen, uno dei più raffinati poeti contemporanei italiani, racconta la sua “pagina di storia”. Era ancora bambino quando alla fine della Seconda guerra mondiale con l’esodo massiccio degli Italiani d’Istria lasciò Fiume, la città dove è nato, per trasferirsi con la famiglia a Roma, dove tuttora vive. La casa in cui Zeichen abita e che fin da quando ci siamo conosciuti, nel 1986, definisce con sottile ironia “una baracca”, si trova sulla via Flaminia, una delle strade più antiche della capitale, luogo ideale per il poeta che ha riconosciuto in Roma e nella Romanità la sua vera origine. Abbiamo incontrato Valentino Zeichen, “il poeta che a volte sorride, a volte si incupisce, in una densità varia di umori e negli scatti di un’intelligenza sempre agli antipodi dell’ovvio”, a Fabriano, nelle Marche, alla prima edizione di Poiesis, il Festival dedicato alla poesia curato da Francesca Merloni.
 Con “Stanze all’aperto” (Moretti e Vitali, 2008) lo sguardo di Alessandro Moscè torna a soffermarsi sui Luoghi in cui il poeta vive: il mare di Ancona e la collina marchigiana.
Con “Stanze all’aperto” (Moretti e Vitali, 2008) lo sguardo di Alessandro Moscè torna a soffermarsi sui Luoghi in cui il poeta vive: il mare di Ancona e la collina marchigiana.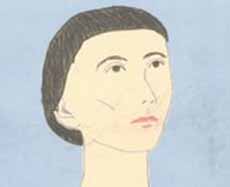 ‘Jeanne d’Arc e il suo doppio’ (Guanda, 2008)
‘Jeanne d’Arc e il suo doppio’ (Guanda, 2008) Julia Hartwig ha 86 anni. E’ nata a Lublino, in Polonia nel 1921. Insieme alla contemporanea Wislawa Szymborska, è considerata una delle maggiori poetesse del Novecento. Nel 2007 la prima antologia di poesie della Hartwig, dal titolo “Sotto quest’isola” , traduzione di Silvano De Fanti con una breve presentazione di Annalisa Comes, viene pubblicata dall’editore Donzelli. Esplode in Italia il fenomeno Hartwig. Alfonso Berardinelli, uno dei più importanti critici italiani, dopo aver letto la Hartwig scrive: “Ecco il ritmo che sa chiudere il mondo in una goccia d’acqua.” Il libro, presentato in prima assoluta al festival di RomaPoesia 2007, è stato l’occasione per incontrare la Hartwig e realizzare in esclusiva questa intervista, la prima in Italia della grande scrittrice polacca.
Julia Hartwig ha 86 anni. E’ nata a Lublino, in Polonia nel 1921. Insieme alla contemporanea Wislawa Szymborska, è considerata una delle maggiori poetesse del Novecento. Nel 2007 la prima antologia di poesie della Hartwig, dal titolo “Sotto quest’isola” , traduzione di Silvano De Fanti con una breve presentazione di Annalisa Comes, viene pubblicata dall’editore Donzelli. Esplode in Italia il fenomeno Hartwig. Alfonso Berardinelli, uno dei più importanti critici italiani, dopo aver letto la Hartwig scrive: “Ecco il ritmo che sa chiudere il mondo in una goccia d’acqua.” Il libro, presentato in prima assoluta al festival di RomaPoesia 2007, è stato l’occasione per incontrare la Hartwig e realizzare in esclusiva questa intervista, la prima in Italia della grande scrittrice polacca.