 “La vita dei dettagli” (Donzelli, 2009, euro 18,00) è la nuova avventura letteraria di una delle più apprezzate poetesse italiane, Antonella Anedda. Si tratta di un’opera di saggistica di grande significato in quanto offre lo spunto per un’importante riflessione, oggi, sul senso e sul significato dell’arte. Gli occhi della poetessa vedono, “pensano la vita” e ci riportano al viaggio compiuto da James Joyce con “Ulysses” e alla frase pronunciata da Stephen Dedalus: “Pensare la vita attraverso i miei occhi”.
“La vita dei dettagli” (Donzelli, 2009, euro 18,00) è la nuova avventura letteraria di una delle più apprezzate poetesse italiane, Antonella Anedda. Si tratta di un’opera di saggistica di grande significato in quanto offre lo spunto per un’importante riflessione, oggi, sul senso e sul significato dell’arte. Gli occhi della poetessa vedono, “pensano la vita” e ci riportano al viaggio compiuto da James Joyce con “Ulysses” e alla frase pronunciata da Stephen Dedalus: “Pensare la vita attraverso i miei occhi”.
“Dimmi a chi appartiene questa casa in fiamme, chi lancia la sua picca sul vuoto, quale peccato viene punito” si domanda la Anedda compiendo il suo ritratto, pietoso e impietoso, mettendo insieme frammenti, dettagli, accumulati negli occhi, immagini che l’hanno atterrita e affascinata.
“Che cosa si ferma nei nostri occhi?” Si chiede la poetessa. Cosa ci colpisce e ci commuove? Lo sguardo della Anedda “collezionista di perdite” procede minuzioso nella ricostruzione, ritaglia e fotografa dettagli delle opere di alcuni dei più grandi artisti visivi del nostro tempo, Nicolas De Staël (1914-1955) Marc Rothko (1903-1970) Bill Viola (1951) Jenny Holzer (1950) e si interroga: “Qual è il significato dell’arte?”
“Nelle scaglie nere che annunciano tempesta” lo sguardo non riunisce, ma scompone particolari che diventano un altro quadro. Ecco che l’osservazione e la sintesi della poetessa incrocia il solco di altri poeti che come la Anedda furono dei grandi cacciatori di immagini. Penso a Guillaume Apollinaire che divenne amico intimo di Pablo Picasso. Il punto di vista di Apollinaire nei confronti dell’arte rafforzò il grande artista che divenne Picasso e contribuì al suo precoce riconoscimento pubblico. Così “La vita dei dettagli” rafforza e consolida il senso e il significato di tutta l’arte, evidenziando il ruolo del poeta nella contemporaneità e attribuendo assoluto valore alla sua testimonianza.
La Anedda entra nel “frammento di un discorso” che comincia, per ogni poeta, proprio dall’osservazione, dallo stare davanti al “quadro”, all’immagine, affascinato o respinto da un tratto, dal dettaglio che compare o scompare del tutto, evidenziato dalla luce o inghiottito dal buio. Ciò che resta impresso nell’occhio del poeta è quell’infinitamente piccolo che ha attirato la sua attenzione, ha smosso la riflessione, l’argomentazione, il discorso che ha reso possibile – che rende possibile – la Sua Opera. L’attenzione del poeta al particolare diviene quindi la sintesi di una conoscenza di cui il poeta entra in possesso e dalla quale non potrà mai più separarsi. Quel dettaglio – una finestra spalancata sul visibile – è pensiero, movimento, azione, è l’Opera, nel suo farsi e disfarsi.
di Luigia Sorrentino


 Ci sono pochi uomini di cultura in Italia come Sergio Zavoli, attuale presidente della commissione di Vigilanza della Rai, già Senatore della Repubblica, ex presidente della Rai, giornalista, autore radiofonico e televisivo, scrittore, ma anche poeta.
Ci sono pochi uomini di cultura in Italia come Sergio Zavoli, attuale presidente della commissione di Vigilanza della Rai, già Senatore della Repubblica, ex presidente della Rai, giornalista, autore radiofonico e televisivo, scrittore, ma anche poeta.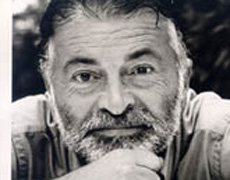 Si fa il possibile/ per questa gente”/ ti dicono di noi,/ “per farla stare meglio:/ da bere e da mangiare/ piu` che sufficiente,/ e sonno quanto basta,/ le loro messe, i libri,/ ore di svago e di riposo.”/ Ma e` un altro, il nostro,/ differente stato/ inerte e doloroso.
Si fa il possibile/ per questa gente”/ ti dicono di noi,/ “per farla stare meglio:/ da bere e da mangiare/ piu` che sufficiente,/ e sonno quanto basta,/ le loro messe, i libri,/ ore di svago e di riposo.”/ Ma e` un altro, il nostro,/ differente stato/ inerte e doloroso.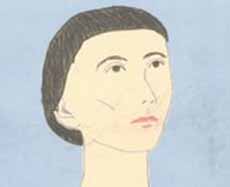 ‘Jeanne d’Arc e il suo doppio’ (Guanda, 2008)
‘Jeanne d’Arc e il suo doppio’ (Guanda, 2008)