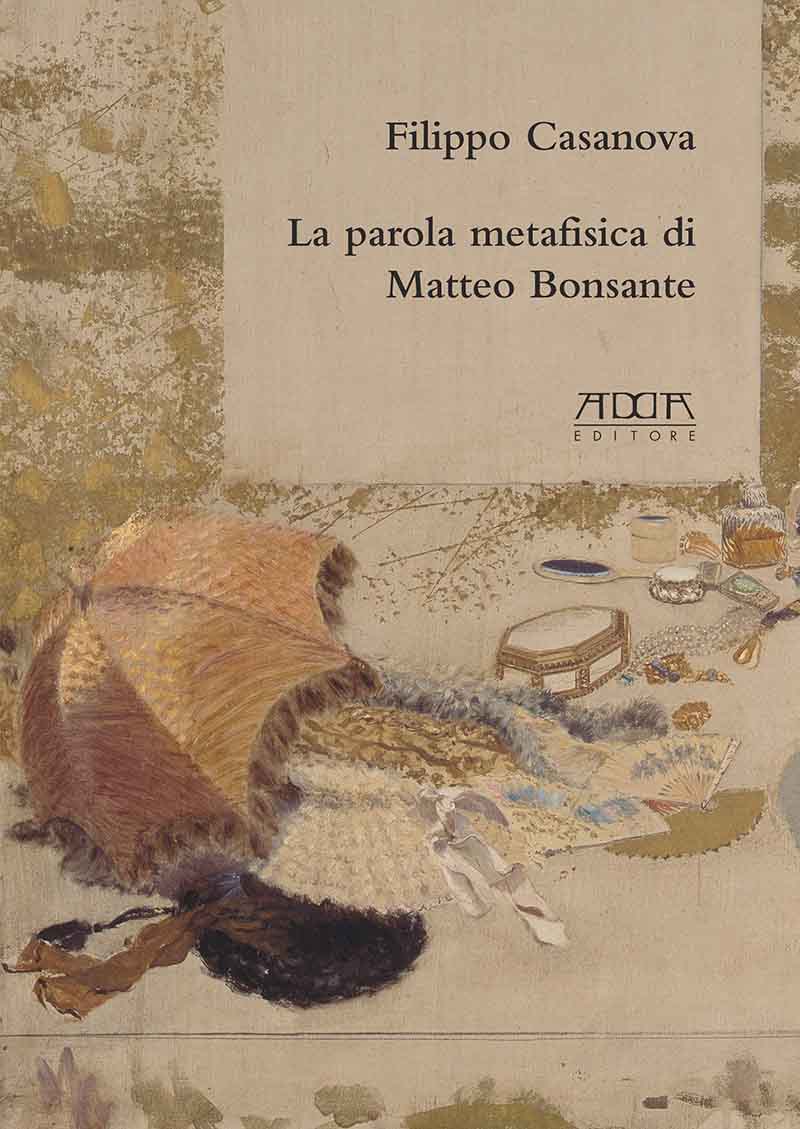
ESTRATTO
L’analisi dell’opera letteraria di Matteo Bonsante ci consegna, volendo trarne delle considerazioni generali, un grande affresco storico-letterario che abbraccia, a ben vedere, il periodo di tempo che va dagli anni Ottanta del XX secolo alla prima decade del XXI. Volendo usare un’immagine rappresentativa di questo lungo processo artistico, si può dire che l’opera bonsantiana ci appare come un lieve panno su cui si adagiano, in un’ottica di corrispondenze, i piani differenti che compongono la realtà: raziocinio e intuizione, libertà e determinismo, al di qua e al di là – tutto si compenetra in una trama esistenziale sempre volta alla ricerca effettiva e mai soltanto abbozzata di una chiave di volta che possa, in definitiva, suggerire all’individuo (poeta o lettore, poco importa) non solo una riflessione estetica ed etica sulla vita, ma soprattutto una pratica dell’esistere e dell’essere al mondo.
A partire dalla prima opera, Bilico, e attraverso una progressiva acquisizione dei rapporti di interconnessione tra le diverse compagini della realtà – noumeno e fenomeno –, si può affermare che Bonsante abbia cercato di fornire alla sua poesia un materiale sempre vivo e magmatico col quale riscoprire, attimo dopo attimo, una genuinità del vivere in apparenza irraggiungibile. ‹‹A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino››, ha affermato Picasso in riferimento alla sua personale e costante ricerca della semplicità della linea – di una forma, cioè, che potesse riassorbirsi in sé stessa senza retorica e senza ostentazione mostrando, per l’appunto, quella genuinità geometrica di cui è composta la realtà. Specularmente, non sarebbe affatto un errore comparare questa stessa ricerca picassiana a quella di Matteo Bonsante, un poeta che sin dagli esordi ha cercato di scavalcare la parola in quanto forma artificiale spesso incapace di comunicare l’essenziale a vantaggio di una melodia, di una carica immaginifica che tenta il finito e l’infinito per potersi ri-trovare in uno spazio fuori da ogni tempo e da ogni condizionalità fisica, riassorbendosi e raggiungendo così l’essenziale e il genuino che è, poi, il vero obiettivo della sua ricerca. Continua a leggere

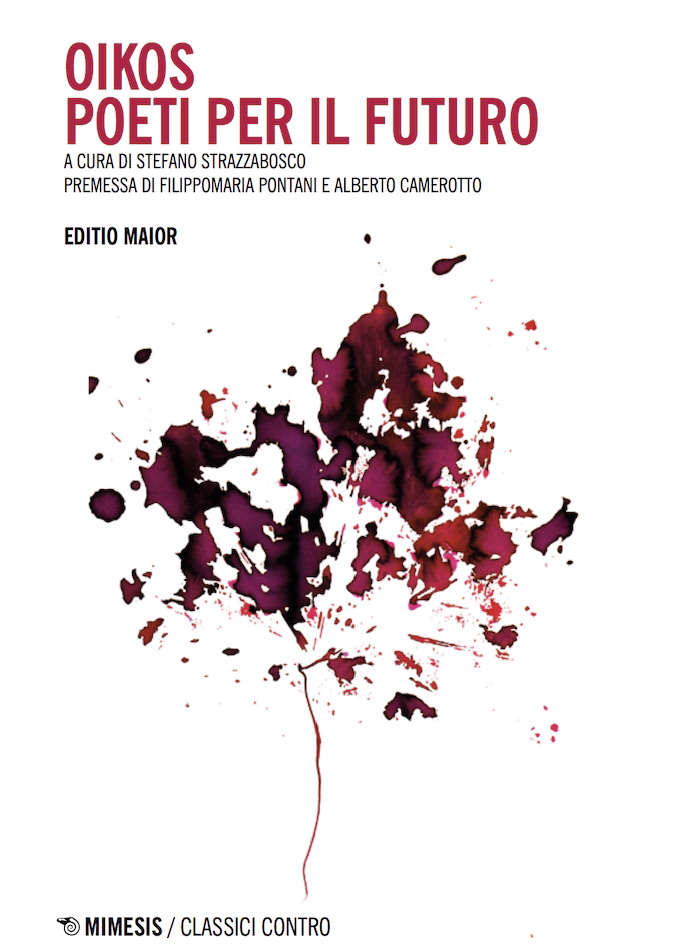 Oikos. Poeti per il futuro è un progetto poetico-civile dei Classici contro, vale a dire del gruppo di classicisti coordinati da Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani (Università Ca’ Foscari di Venezia) che ormai da anni ripercorrono i testi degli autori grecolatini per parlare delle questioni più spinose del presente (l’immigrazione, la giustizia, la bellezza, l’Europa e così via).
Oikos. Poeti per il futuro è un progetto poetico-civile dei Classici contro, vale a dire del gruppo di classicisti coordinati da Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani (Università Ca’ Foscari di Venezia) che ormai da anni ripercorrono i testi degli autori grecolatini per parlare delle questioni più spinose del presente (l’immigrazione, la giustizia, la bellezza, l’Europa e così via).

