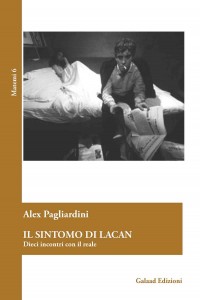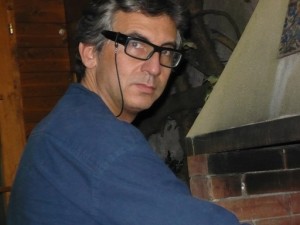Alberto Russo Previtali, foto di proprietà dell’autore
di Jean Nimis
Dopo Il destinatario nascosto. Lettore e paratesto nell’opera di Andrea Zanzotto (Franco Cesati, 2018), Alberto Russo Previtali propone un secondo saggio monografico sull’opera del poeta di Pieve di Soligo. L’autore ha inoltre dedicato ben nove articoli all’opera del poeta scomparso nel 2011, prova della sua esperienza riguardo a un’opera poetica reputata difficile e però essenziale per l’arco di tempo che va dalla seconda metà del Novecento al primo decennio del Ventunesimo secolo. Infatti, Andrea Zanzotto è stato un poeta tra i più significativi di questo periodo, certamente per la sua ricerca formale molto originale, ma soprattutto per la messa in rilievo dell’esperienza di un soggetto lirico inserito nella realtà contemporanea e intento ad esperimentare un principio di consistenza del linguaggio.
Alberto Russo Previtali parte dall’osservazione secondo la quale vari elementi del discorso fenomenologico lacaniano sono presenti nei testi in prosa e in poesia di Andrea Zanzotto. Era un elemento che Michel David aveva enunciato nel suo saggio del 1966[1] e che Stefano Agosti aveva ripreso nelle prefazioni ai volumi delle opere pubblicate da Mondadori fin dal 1973. Ed è questa configurazione che Russo Previtali mette in rilievo con precisione già nel suo prologo, dove si parte dal fatto che il linguaggio, considerato da Zanzotto in quanto dimensione “totale” (p. 10), non poteva che rendere conto di un distacco per così dire “fatale” tra significato e significante. Tale distacco appare già nel titolo del saggio, con la sbarra che separa i cognomi del poeta italiano e dello psicanalista francese. Russo Previtali insiste su “un punto teorico inaggirabile”: se Lacan rappresenta per il poeta trevisano “il nome del tentativo più coerente e organico di un’alleanza teorico-pratica tra linguistica e psicoanalisi”, non si tratta di ridurre sul piano interpretativo questa poesia al suo rapporto con la teoria dello psicanalista francese, bensì di riconoscere che è “una sua componente prospettica fondamentale, imprescindibile” (p. 10). Andrea Zanzotto, che leggeva il francese e che ha frequentato in modo regolare i testi di Lacan, aveva visto nel discorso teorico dello psicoanalista una potenzialità conoscitiva atta a permettergli di intavolare un approccio – poetico – del proprio rapporto soggetto-mondo.
 Occorre certo avere una piccola idea del percorso poetico di Zanzotto (sin dagli esordi, o almeno a partire da Dietro il paesaggio del 1951, fino a Conglomerati del 2009 e passando da La Beltà del 1968), ed è anche necessario avere abbastanza chiari alcuni dei concetti di Jacques Lacan per seguire l’analisi di Russo Previtali. Tuttavia, l’autore riesce a palesare in modo accessibile, citazioni all’appoggio, le modalità con cui i concetti in area psicanalitica si fanno presenti nell’operato poetico, lungo tutta la produzione di Andrea Zanzotto, sia nelle poesie che nelle prose (saggi e narrazioni).
Occorre certo avere una piccola idea del percorso poetico di Zanzotto (sin dagli esordi, o almeno a partire da Dietro il paesaggio del 1951, fino a Conglomerati del 2009 e passando da La Beltà del 1968), ed è anche necessario avere abbastanza chiari alcuni dei concetti di Jacques Lacan per seguire l’analisi di Russo Previtali. Tuttavia, l’autore riesce a palesare in modo accessibile, citazioni all’appoggio, le modalità con cui i concetti in area psicanalitica si fanno presenti nell’operato poetico, lungo tutta la produzione di Andrea Zanzotto, sia nelle poesie che nelle prose (saggi e narrazioni).