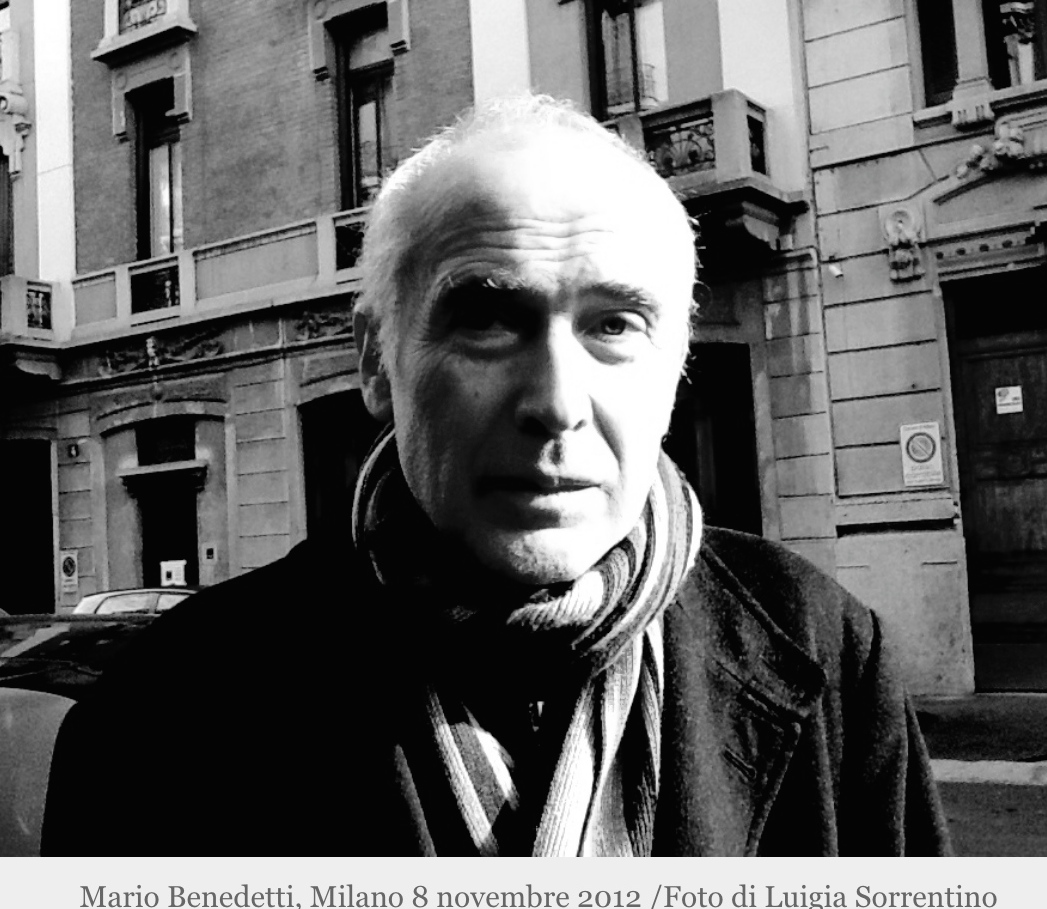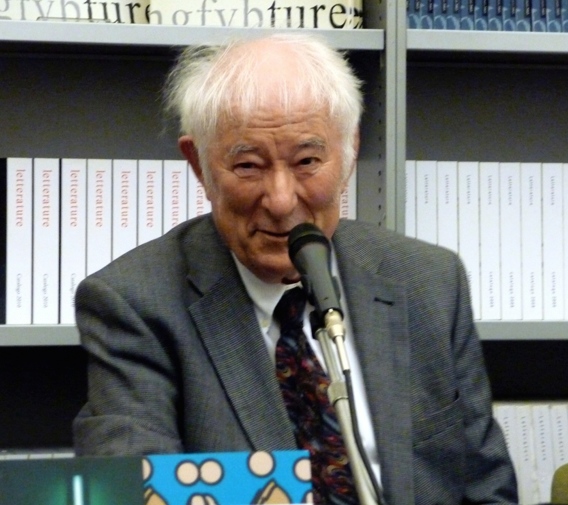Carsten René Nielsen
NOTA DI LETTURA DI DAVIDE CORTESE
(Genova, 2021)
_____
Leggendo le prose di Quarantuno oggetti di Carsten René Nielsen (Taut, 2021) si ha la certezza di avere sotto al naso uno poeta fiducioso: fiducia verso la propria scrittura, verso la «metafora» che ne comprende l’insieme e anche verso i propri lettori. Fiducioso, sì, però nei confronti di chi scivolerà fra i suoi testi la fiducia non sembra essere riposta nella capacità di un approccio corretto, quanto di seguire in maniera ligia i suggerimenti che l’autore dissemina. Le prose, infatti, sono scritte a testimonianza di se stesso e con un gran da fare di ornamento. La pratica è questa: a partire da un oggetto («cannuccia», «frigorifero», «motosega» ecc.) si costruiscono scene – quasi tutte isometre, suggerendo così l’idea di serie – che ospitano o si deformano fino ad assumere aspetti meccanicamente stranianti.
La scrittura di Nielsen, già pubblicato in Italia nel 2014 per EDB, era stata indicata come un «surrealismo nordico» e, in effetti, scorrendo questi Quarantuno oggetti, non sono poche le volte in cui i poeti del movimento si affacciano. Ma l’autore avverte: le sue prose non hanno «niente a che vedere col surrealismo»; e c’è da credergli: anche se l’ostinata stravaganza dei testi spinge ogni volta a chiedersi il perché di cosa si va leggendo, quella si compie nell’esatto contrario: non indica un sovrappiù soggiacente agli oggetti e nemmeno qualcosa che occhieggia sopito.
Le prose suonano a vuoto. Nessun rimando. Ancora, in un altro testo, Nielsen poggia una mano sulla spalla del lettore e dice (equiparando la «metafora», la sua, a un «tappeto»): «Gli avevo spiegato che le metafore sono, discutibilmente, inevitabili ma che ciò non significa che debba sollevare un angolo per vedere se sia stato spazzato qualcosa lì sotto […] puoi sollevare un angolo […] sotto la metafora c’è solo il pavimento».
L’aspetto generale del libro e l’intento dell’autore sembra essere quello di una provocazione, raggirando il lettore fino al punto in cui tirerà il libro contro al muro: costretto a sfilare davanti a un autoritratto in forma di «poeta» diffuso e rimandato; il prossimo «quadro», la prossima prosa sarà quella decisiva.
Nielsen non lascia nemmeno la costernazione di dover apprendere ciò. Previdente anticipa e suggerisce la più giusta reazione: «per tutto il giorno sta seduto a guardarmi con il suo stanco sguardo malinconico. Sono certo che mi odia. Anch’io farei lo stesso. Sono io, dopotutto, che gli ho dato questo lavoro».
ESTRATTI
CALZINI
Salgo sul podio, avendo questa volta scelto di illustrare scene dalla Bibbia con due marionette fatte con vecchi calzini. È un fiasco tremendo. Vengo chiamato pervertito e blasfemo. Non solo i cardinali, ma anche il papa, usano le peggiori maledizioni contro di me. C’è un bel po’ di distanza tra me e gli spettatori furiosi, ma non riesco a evitare di essere colpito da schizzi di sputo. Rientrato in camera mi faccio la doccia e capisco all’istante come avrei dovuto farlo. Gli arabeschi delle frasi girano lentamente nel mio cranio come giostrine illuminate dai riflettori. Più tardi, mentre la Guardia svizzera fa le sue ronde notturne, sto seduto sorridente sotto il firmamento del gigantesco letto a baldacchino e ricomincio da capo: «Che luce sia», dice il calzino. Continua a leggere