
Giovanni Agnoloni
NOTA DI LETTURA DI GIORGIO GALLI
Rileggere le cronache della fine di internet di Giovanni Agnoloni, oggi che la vita virtuale è diventata tutta la vita, può essere un’esperienza istruttiva e perturbante. Agnoloni si interroga su ciò che accadrebbe se la Rete crollasse, ed esplora tutte le possibilità pratiche, ma anche etiche, politiche e metafisiche, di un simile evento. Quanto potere avrebbe colui che riuscisse a controllare la Rete? E che tipo di potere sarebbe quello di colui che, padrone della Rete, decidesse a un dato momento di spegnerla? Sarebbe l’umanità capace di tornare a vivere come prima? E l’orologio della Storia tornerebbe semplicemente indietro, o scopriremmo che lo spazio virtuale ha modificato in maniera sorda ma irreversibile non solo il nostro modo di percepire la realtà, ma financo la realtà stessa? È da queste domande che prende inizio il percorso di Internet. Cronache dalla fine, composto di tre romanzi – Sentieri di notte, La casa degli anonimi e L’ultimo angolo di mondo finito – e dei due racconti riuniti nel dittico Partita di anime. Un’opera ponderosa, che tocca temi cari anche all’ultimo DeLillo, ma in anticipo su di lui di qualche anno, dato che l’indagine di Agnoloni è cominciata nel 2012.
Tutti i protagonisti di questi romanzi hanno perso qualcosa: chi la memoria, chi la famiglia, chi un amore sparito nel nulla… Ne La Casa degli anonimi sono spariti nel nulla, e il protagonista li cerca inutilmente, perfino i tre personaggi principali di Sentieri di notte, che esistono soltanto come nomi e ossessioni. Non è venuta a mancare solo la comunicazione fra diverse aree del globo. Anche passato e presente non dialogano più. Alcuni personaggi raccontano in prima persona la loro esistenza atemporale in una Casa – o in più Case? – simile a un limbo, a un intermundus fra la vita e la morte, desiderosi di tornare a vivere ma inconsapevoli di ciò che sono stati. La loro presenza si manifesta solo nei sogni di altri personaggi. Tutti, dunque, hanno perso il contatto con se stessi: con una parte, o con la totalità, di sé. Cosa li salva? L’incontrarsi, il ritrovarsi. Ma è difficile ritrovare se stessi in un mondo di identità incerte, ingannevoli, talvolta perfino fungibili – e qui Agnoloni sembra richiamarsi a tutta la letteratura sulla massificazione, sull’individuo come monade mondiale, alienata e scissa.
Anche la razionalità non è più sufficiente. I personaggi si muovono spinti da intuizioni irresistibili, da pure sincronicità junghiane (vale a dire da coincidenze significative solo per chi le esperisce). Il protagonista della Casa, Kasper, compie le sue azioni “ben sapendo, per motivi a me ignoti”, qual è il suo compito in questo gioco dove nulla è ciò che appare ma nulla è per caso. Le coscienze possono essere persino eterodirette, infiltrate da qualcun altro che vi prende stanza. Il socratico Gnothi seautòn, “Conosci te stesso”, diventa allora il comandamento più importante. Perché è solo ritrovando se stessi, ridiventando completi, che si può svolgere la propria funzione nel mondo. Accanto al motto socratico, c’è – con pari forza – l’esempio di Gesù, che, nel tempio, pur inveendo contro i Farisei, non si lascia distrarre da loro e continua a tracciare dei segni per terra. Cosa scrive? I Testi non lo dicono, ma ai nostri personaggi quel passo del Vangelo invia un messaggio: rintracciare i segni, decifrarli, interpretarli è il loro compito più sacro, perché i segni sono tutto, in un mondo che si è ridotto al suo proprio fossile. I segni sono ciò che sopravvive. Accogliere i segni, “abbandonarsi ai significanti” avrebbe detto Carmelo Bene, è l’unica via per ritrovare quell’unità a cui tutti aspirano, e che è sempre più lontana.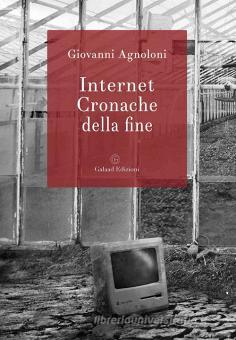
Ne L’ultimo angolo di mondo finito il cosiddetto mondo reale ha perso consistenza: vi si aggirano droni che controllano l’umanità dall’alto, ologrammi in forma umana che rimandano a ciascuno i propri pensieri e a cui ciascuno si rapporta come se fossero reali, senza accorgersi di starsi avviluppando in una spaventosa solitudine. Il paesaggio de La casa degli anonimi era popolato di esseri esausti e arrabbiati, che avevano ceduto agli avatar parte della loro umanità e col crollo di Internet erano rimasti privi di se stessi, privi di una ragione di sé. L’ultimo angolo di mondo finito fa emergere un panorama in cui il reale e l’irreale convivono al punto tale che i vivi hanno l’aspetto di fantasmi e i morti, col loro essere pure anime, hanno su di loro un vantaggio esistenziale e ontologico. Tutto ciò che appare può capovolgersi nel suo rovescio: gli eroi possono essere falsi, i benefici venir percepiti come minacce e gli eroi veri apparire come traditori e venduti.
Mano a mano che il coro di monologhi che è l’architettura dei romanzi si definisce, le vicende individuali emergono più nette, ma i sentimenti, le angosce e le sensazioni dei protagonisti si fanno sempre più simili. Guidati da un direttore d’orchestra onnipresente e invisibile, essi intonano, con le proprie voci, un’unica musica.
Nell’ultimo racconto di Discorso contro la morte (Joker, 2007), una raccolta di apocrifi di straordinaria intensità e unità, Marco Ercolani mette in bocca a Jurij Olesa la scoperta che tutte le voci dei poeti, nei loro taccuini segreti, si somigliano, che tracciano un’unica voce, una linea di canto sovrapersonale. Molti artisti hanno riferito l’esperienza di aver creato l’opera come sotto dettatura di una volontà superindividuale. Possiamo supporre che chi detta lo faccia dall’alto (la Divinità) o dal basso (l’inconscio collettivo junghiano), ma sappiamo che il risultato è la Poesia. E cos’è la Poesia se non la ricerca di un Suono, di quel Ur-Ton primordiale e universale che toglie alla parola il suo carattere arbitrario e la trasforma in parola motivata – in una cosa? Il primo romanzo “della fine di Internet” si apriva con un puro suono: le parole del Padre Nostro in aramaico. Ne L’ultimo angolo di mondo finito uno dei personaggi si getta dentro a un Suono, fatale e rigenerante, unica salvezza di un’umanità annichilita dai mezzi e sprovvista di fini; unica forza capace di rimettere in comunicazione gli automi autistici generati dalla falsa comunicazione della tecnologia.
Anche lo stile si fa via via più astratto. In Sentieri di notte, nel momento in cui crolla il Sistema, scompare Internet e si ferma l’erogazione dell’energia elettrica, la protagonista Kristine sta terminando il suo romanzo. Presa com’è dal finale, si accorge a malapena del disastro che è occorso. Pensa che sia un semplice black-out. Ma quando smette di scrivere, salva il file – è rimasta un po’ di carica nella batteria del portatile – e riprende coscienza di ciò che le avviene intorno, si accorge di un buio sovraumano e del tramestio che le sale in casa dalla finestra. Affacciandosi, scorge alla luce della luna – l’unica luce nel raggio di chilometri – la sua vicina in sottoveste, scesa in cortile a domandare che cosa è accaduto. Questo particolare realistico, della sottoveste, dà l’idea di un mondo che continua ad essere presente nella sua concretezza. Mano a mano che si procede nei romanzi, tracce realistiche come questa si fanno più rare. L’unico modo che ha l’essere umano per avventurarsi nella nuova realtà è orientarsi: ed ecco allora che Agnoloni riferisce i movimenti dei suoi personaggi dentro le grandi città del Nord e dell’Est Europa con la precisione di un geografo, dando conto dello stradario delle città, tracciando mappe e delineando percorsi come in un libro di viaggio.
Il percorso dentro i guasti della Rete porta a una soluzione mistica, che può non piacere a tutti, ma che, non presa alla lettera, rivela una verità semplice e sconcertante: la soluzione è la Poesia. Nel suo senso più vasto. Il recupero della poesia dell’esistere è il rimedio per eccellenza ai guasti indotti dalla falsa socialità, dalla falsa identità, dalla falsa vita della Rete.
ESTRATTO
Internet. Cronache della fine, di Giovanni Agnoloni, Galaad Edizioni, 2021
pagg. 416-419
Anche nella capitale tedesca, come ora a New York, nell’aprile 2027 si percepiva un’atmosfera frizzante, quasi che, smaltiti gli effetti della fine della Rete, la gente stesse recuperando l’umanità che aveva smarrito. Le luci del mattino e le ombre della sera erano limpide e pulite, senza traccia di tensione. Le persone sembravano aver ritrovato la voglia di vivere e comunicare, sollevando lo sguardo dai loro smartphone e guardandosi negli occhi. Per qualche settimana fu come se l’aria fosse stata lavata da un violento temporale. Respiravo con piacere e intuivo il crescere di una speranza. Forse fu per questo che decisi di trattenermi a Berlino, che mi appariva ancora come la frontiera più avanzata d’Europa e il miglior territorio di sperimentazione per cogliere i segnali di un rinnovamento.
Fu a maggio che le cose cominciarono a cambiare. Quando in città si diffusero i primi ologrammi.
Inizialmente nessuno ci fece caso. Camminavano in mezzo alle persone, in ambienti affollati, muovendosi tra loro con perfetta naturalezza. Finché alcuni non ne notarono la leggera trasparenza, ma soprattutto la somiglianza. Qualcuno, in effetti, ci si riconobbe. Ologrammi uguali a persone reali, che si comportavano come loro e sembravano perfino pensare, benché non parlassero. Erano presenze enigmatiche, specchi perturbanti in cui tanti berlinesi riuscivano a vedere riflesse le proprie paure, ma anche l’ombra di desideri inespressi.
Durò poco meno di un mese: giusto il tempo sufficiente a far sorgere interesse senza eccessivi allarmi. Poi delle squadre di varie ditte incaricate iniziarono a installare maxischermi in diverse zone della città, e apparvero slogan e video che invitavano gli abitanti a radunarsi in Alexanderplatz, in Potsdamer Platz, a Charlottenburg e negli altri punti nevralgici della capitale. L’evento era previsto per il 26 maggio.
Moltissimi, desiderosi di capire, risposero.
C’ero anch’io. Avevo deciso di recarmi nel parco di Tiergarten, uno degli spazi verdi più ampi del territorio urbano. La sera era sopraggiunta da poco e si stavano accendendo le prime luci artificiali. L’aria era pungente, e dal terreno emergevano fumi opachi, che scaturivano da anfratti invisibili. La gente, radunata come in attesa di un miracolo, guardava verso l’alto, in direzione dello schermo.
Non avrei saputo dire se tra quelle persone vi fossero anche degli ologrammi. Ma forse nessuno, in quel momento, ci avrebbe comunque fatto caso, concentrati com’erano tutti ad aspettare ciò che stava arrivando. Qualcosa di potente, che prometteva di compensare il vuoto del tempo trascorso senza Rete.
All’improvviso il video s’illuminò, mostrando, in risalto contro uno sfondo grigio scuro, tre frasi in caratteri bianchi.
Ologrammi nella città.
Ologrammi come oracoli.
Ologrammi come noi.
Dalla folla si staccarono alcune figure, eteree ma consistenti, che
confluirono sulla pedana ai piedi dello schermo.
E una di loro parlò.
Disse che, d’ora in avanti, tutti avrebbero avuto un proprio ologramma di riferimento, identico a loro, al quale si sarebbero potuti rivolgere come a un confidente o a un maestro. Dell’ologramma avrebbero potuto fidarsi ciecamente, perché in lui non avrebbero rivisto altri che se stessi al meglio del proprio potenziale.
Fu un discorso breve ma di grande impatto. I presenti si guardarono l’un l’altro, dapprima perplessi e increduli, quindi sempre più convinti: la novità li eccitò a tal punto che, nel giro di mezzo minuto, iniziarono a sentirsi applausi e grida di entusiasmo, in un crescendo compatto.
Era finita l’astinenza. Si poteva ricominciare.
Ci si poteva riagganciare.
Per me fu come essere folgorato da una scarica distruttiva. I segnali di rinascita che nelle settimane precedenti avevo creduto di intravedere mi crollarono addosso, sgretolandosi come pezzi d’intonaco. La fine di internet non era servita a nulla. La gente voleva essere schiava. In quegli ologrammi avrebbe trovato un surrogato di ciò che i social media avevano rappresentato in passato. Anzi, sarebbe stato ancor peggio, perché il contatto con gli altri sarebbe apparso superfluo, ora che si poteva vivere accanto a una copia migliorata di sé. Perfino l’autoconsapevolezza non avrebbe più avuto alcun valore. Riflettendosi in quegli specchi fittizi, le persone avrebbero creduto di essersi finalmente trasformate in ciò che non erano mai riuscite a essere: la quintessenza della loro natura più vera, l’energia vitale che non avevano mai saputo esprimere appieno. Che senso poteva avere sforzarsi di conoscere se stessi, quando si poteva affrontare la vita insieme a un clone virtuale capace di indicare sempre la cosa giusta da fare?
Non mi trattenni a lungo in città. Avevo già deciso di partire per svolgere le mie ricerche in giro per l’Europa, ma quello spettacolo mi rese intollerabile perfino il pensiero di indugiare ancora. Sapevo che questa nuova tecnologia si sarebbe estesa anche ad altre zone del continente, tuttavia volevo evitare di rimanere nell’epicentro di quella nuova follia; anche perché ignoravo se fossi già stato schedato e copiato olograficamente. Certo, era improbabile, visto che non ero un residente, per quanto quella mia visita dal barbiere mi lasciasse dei dubbi. Eppure, di una cosa ero intimamente certo: l’obiettivo della Macros, o di ciò che ne restava, era mappare e duplicare, col tempo, l’intera popolazione europea, in modo che ciascuno avesse a disposizione uno spin doctor olografico, capace di ricordargli “il meglio di sé”. E, sospettavo, di orientarlo a comprare determinate cose, a votare in un certo modo e ad aderire a un modello di società diretto dall’alto e privo di elementi di dissenso.
_______________
Giovanni Agnoloni (Firenze, 1976), è scrittore, traduttore letterario e blogger.
È autore di una quadrilogia di romanzi distopici sul tema del crollo di internet e della società del controllo, usciti in prima edizione tra il 2012 e il 2017 e in parte pubblicati anche in spagnolo e in polacco. L’intera serie, aggiornata, è stata poi riunita nel volume unico Internet. Cronache della fine (Galaad, 2021).
Suoi sono inoltre il libro di viaggio Berretti Erasmus. Peregrinazioni di un ex studente nel Nord Europa (Fusta, 2020) e ilromanzo psicologico Viale dei silenzi (Arkadia, 2019), e ha anche preso parte al romanzo collettivo Il postino di Mozzi, a cura di Fernando Guglielmo Castanar (Arkadia, 2019).
Ha scritto, curato e tradotto vari libri sulle opere di J.R.R. Tolkien, e tradotto o co-tradotto saggi su William Shakespeare e Roberto Bolaño, oltre a libri di Jorge Mario Bergoglio, Kamala Harris, Arsène Wenger, Amir Valle e Peter Straub.
Ha partecipato a numerose residenze letterarie e reading in Europa e negli Stati Uniti, e traduce da inglese, spagnolo, francese e portoghese, oltre a parlare il polacco e lo svedese.
Insieme alla giornalista Valeria Bellagamba ha creato la pagina Facebook “Anticorpi letterari”, che ospita video-interviste a protagonisti del mondo letterario e artistico italiano e internazionale.
I suoi contributi critici sono disponibili sui blog “La Poesia e lo Spirito”, “Lankenauta”, “Poesia, di Luigia Sorrentino” e “Postpopuli”.
Il suo sito è www.giovanniagnoloni.com.
