
IL LIBRO
Le cinquantuno conversazioni qui raccolte offrono un Giorgio Bassani in presa diretta e a figura intera: e restituiscono al lettore i suoi talenti indomabili e l’altezza – in tutti i sensi – della sua voce. Alcune di esse, appena ritrovate, compaiono in volume per la prima volta; altre, realizzate con la complicità di amici quali Mario Soldati, Enzo Siciliano, Manlio Cancogni e Claudio Varese, si svolgono come autentici happening; altre ancora ci presentano Bassani attraverso lo sguardo di beninformati cronisti americani, svedesi, brasiliani, inglesi, argentini e francesi. Autore di un’opera poetica, narrativa e saggistica fra le memorabili del Novecento, Bassani è innanzitutto l’inventore di una voce. Qui, lungo quattro decenni all’incirca, il lettore può ascoltarla mentre va prendendo forma, seguendone i guizzi di genialità critica e autocritica, i progetti irrealizzati che balenano per accenni, le illusioni e le delusioni, le impuntature e le gioie, le rabbie e gli slanci, il partito preso di contraddire e la fame di complicità, in breve: la progressiva scoperta di sé e del mondo nei momenti in cui si trova intercettata dalla pubblica notorietà, da un interlocutore equipaggiato di taccuino o di magnetofono o magari della sola memoria. Da oggi in avanti, Interviste 1955-1993 – volume curato da Beatrice Pecchiari e Domenico Scarpa, con una premessa di Paola Bassani – si aggiunge al canone dell’opera di Bassani come un diario vocale ininterrotto, come un autocommento su pungolo altrui. Il libro assertivo e antagonista di un uomo che seppe coltivare il raro dono della “distrazione interiore”. Continua a leggere

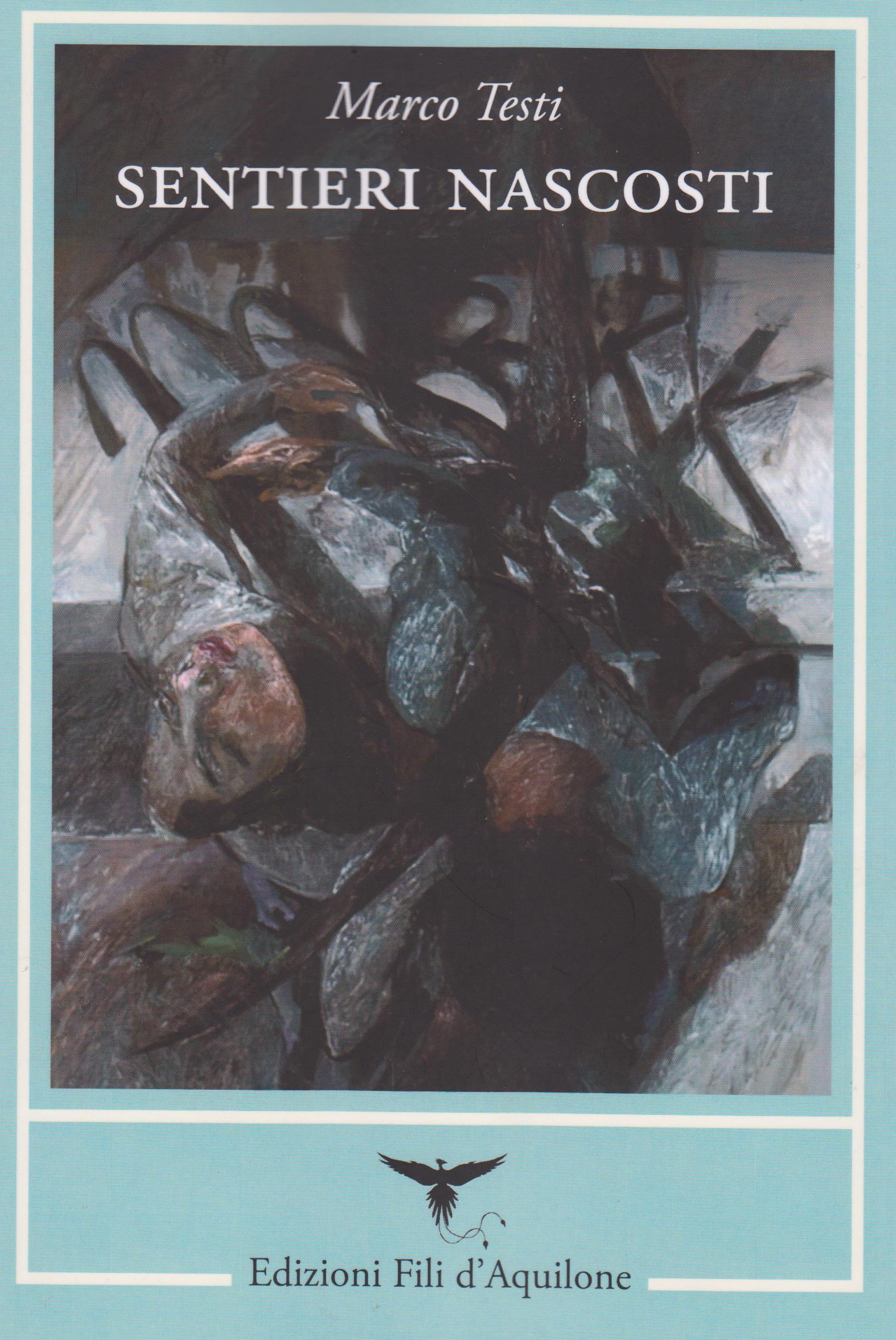


 Meglio star zitti? raccoglie centosettanta stroncature firmate da Giovanni Raboni in quarant’anni di attività critica: interventi talvolta garbati, più spesso sarcastici e addirittura spietati, tesi a mettere in discussione il valore e il significato di prodotti artistici (romanzi, poesie, film, spettacoli teatrali) e di fenomeni di costume. Ne fanno le spese nomi blasonati: Woody Allen, Italo Calvino, Umberto Eco, Federico Fellini, Dario Fo, Giorgio Gaber, Ernest Hemingway, Milan Kundera, Pier Paolo Pasolini e tanti altri.
Meglio star zitti? raccoglie centosettanta stroncature firmate da Giovanni Raboni in quarant’anni di attività critica: interventi talvolta garbati, più spesso sarcastici e addirittura spietati, tesi a mettere in discussione il valore e il significato di prodotti artistici (romanzi, poesie, film, spettacoli teatrali) e di fenomeni di costume. Ne fanno le spese nomi blasonati: Woody Allen, Italo Calvino, Umberto Eco, Federico Fellini, Dario Fo, Giorgio Gaber, Ernest Hemingway, Milan Kundera, Pier Paolo Pasolini e tanti altri.