
Tiziano, Ritratto di uomo, già Ludovico Ariosto, National Gallery Londra fonte: ferraraitalia.it
NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA
Composte tra il 1517 e il 1525, dunque nel torno di tempo tra la prima versione del Furioso (1516) e la seconda, decisiva (1532), le Satire di Ludovico Ariosto sono uno dei classici della letteratura italiana grazie alla spontaneità del dettame, all’innovazione formale (terzine dantesche con andamento epistolare), al forte ethos che si respira pur nella pianezza dei motivi.
Einaudi propone oggi una versione aggiornata della storica edizione del 1987 a cura di Cesare Segre: vi è una nuova introduzione, mutuata dalla collana francese «Les Belles Lettres» del 2014, anno della scomparsa dello studioso, alcune variazioni negli apparati testuali, in bibliografia e nel commento.
È insomma un’ottima occasione per rileggere e respirare nuovamente l’intensità dell’opera ariostesca alla luce del laboratorio critico, sempre molto puntuale e ordinato, di Segre.

Cominciamo col dire che le urticanti idee sulla realtà curtense che emergono dalle Satire rivelano sì il carattere (ispido) del loro autore, ma offrono uno specchio quanto mai vivido della vita quotidiana in un Cinquecento tutt’altro che idillico. Dice bene Segre quando, nel contributo prefatorio, sottolinea che con la sua «attenzione etica» l’Ariosto, «fingendo di difendersi, accusa senza reticenze».
Ed è proprio l’aspra recusatio a conferire al testo un tono genuino, agonico, ancor più teatrale delle stesse commedie (è ancora un suggerimento di Segre). Di cosa parlano e a chi sono indirizzate le sette missive? La prima, scritta tra il settembre e il dicembre 1517, è rivolta al fratello Alessandro e al nobile mantovano Ludovico da Bagno: il poeta non ha seguito Ippolito d’Este ad Agria in Ungheria e ne spiega le ragioni (non senza un certo sense of humor: «So mia natura come mal conviensi / co’ freddi verni; e costà sotto il polo / gli avete voi più che in Italia intensi. / E non mi nocerebbe il freddo solo; / ma il caldo de le stuffe, c’ho sì infesto, / che più che da la peste me gli involo»).
La seconda, del novembre ’17, indirizzata all’altro fratello Galasso, ha una trama da «romanzo poliziesco»: alla ricerca di benefici ecclesiastici Ludovico parte alla volta di Roma ma incontra prevedibili ostacoli e neghittose virtù.
Nella terza, la quarta e la quinta si interpellano invece due cugini: Annibale e Sismondo Malagucio (o Malegucio). I temi non sono dissimili dai precedenti: il passaggio del servizio da Ippolito ad Alfonso d’Este, il fastidio dei viaggi, la nomina a commissario in Garfagnana — e quindi la nostalgia per Ferrara —, i rischi e i vantaggi del matrimonio (di Annibale). Le date di composizione abbracciano gli anni ’18, ’20 e ’23 all’incirca. Le due restanti risalgono al biennio ’24-’25.
La Satira VI è rivolta all’amico Pietro Bembo: Ariosto chiede lume al letterato riguardo al possibile nome di un istitutore per il figlio Virginio (con incipit dantesco: «Bembo, io vorrei, come è il commun disio / de’ solliciti padri, veder l’arti / che essaltan l’uom, tutte in Virginio mio»). L’ultima vede protagonista il cancelliere ducale Bonaventura Pistofilo «che aveva proposto all’Ariosto la carica di ambasciatore presso il nuovo papa, Clemente VII, sfruttando la sua amicizia con la famiglia dei Medici». Continua a leggere


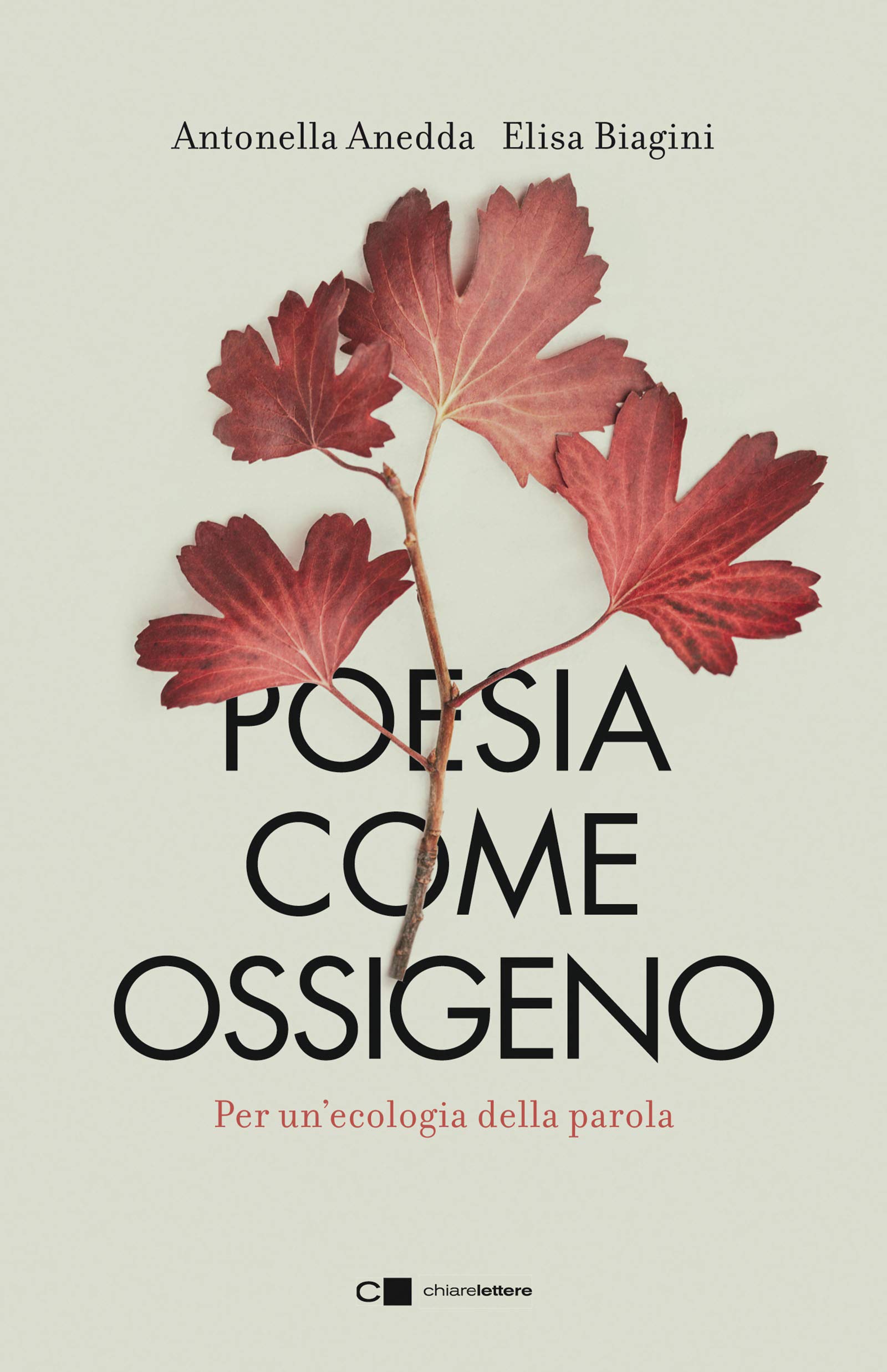
 Concetto peraltro ribadito in un altro scritto molto interessante della stessa Anedda: si tratta di un saggio poetico — sul modello di quelli di Jaccottet e Zagajewski ma punteggiato di lemmi e brevi argomenti che aumentano l’intenzione diaristica e la concertazione filosofica —, Geografie.
Concetto peraltro ribadito in un altro scritto molto interessante della stessa Anedda: si tratta di un saggio poetico — sul modello di quelli di Jaccottet e Zagajewski ma punteggiato di lemmi e brevi argomenti che aumentano l’intenzione diaristica e la concertazione filosofica —, Geografie. 

