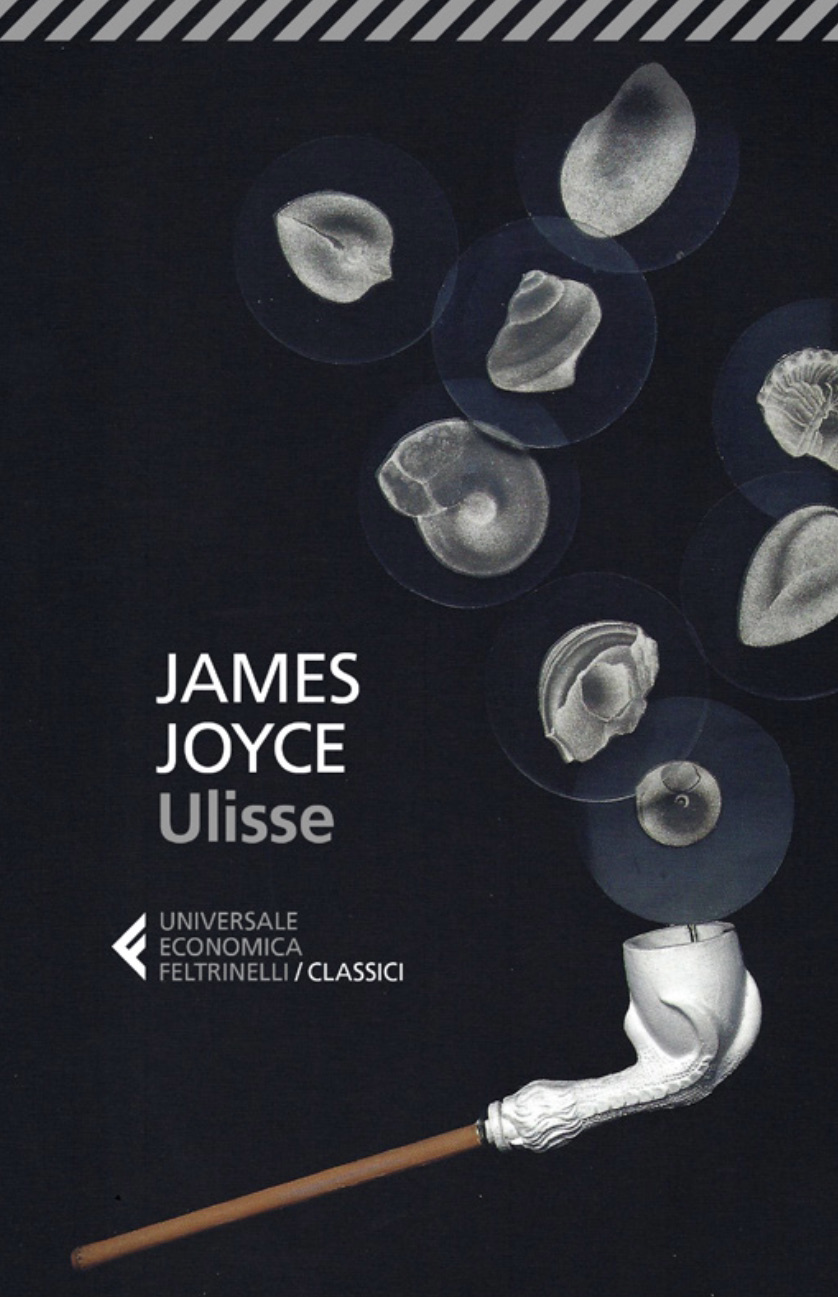Jeannette L. Clariond
Querría entregar mi cuerpo como has entregado el tuyo para un bien mayor. Pero es flaca la carne y débil este espíritu mío. No habría podido mover esa piedra que yacía sobre tu muerte y que sólo Magdalena supo descifrar, pues vio en tus ojos, oh profeta de las palmas, que todo cambia cuando miras.
Eres el dolor de ser mundo.
Vorrei donare il mio corpo come tu hai donato il tuo per un bene più grande. Ma spossata è la carne e debole questo mio spirito. Non avrei potuto spostare la pietra che giaceva sulla tua morte e che solo Maddalena ha saputo comprendere, poiché ha visto nei tuoi occhi, o profeta delle palme, che tutto cambia quando tu ci guardi.
Sei il dolore di essere il mondo.
***
Un cuerpo desnudo es un árbol sin corteza. Su silencio no pide la floración que recubra la desgarradura. Un cuerpo desnudo sabe que nadie puede ver su desnudez: dentro de su carne corre un río de soledades. A las tres de la tarde se oscureció aquel mar. A las tres en punto de la tarde tu desnudez inflamó de amor todo mi cuerpo.
Hay pasiones que queman la raíz, hay amores que arden más que mil hojas de pergamino.
Aun fuera del pote, ardería la flor.
Un corpo nudo è un albero privo di corteccia. Il suo silenzio non ha bisogno della fioritura che rivesta le lacerazioni. Un corpo spoglio sa che nessuno può vedere la sua nudità: nella sua carne scorre un fiume di solitudine. Alle tre del pomeriggio quel mare si fece oscuro. Alle tre in punto del pomeriggio la tua nudità gonfiò di amore tutto il mio corpo.
Ci sono passioni che bruciano le radici, ci sono amori che ardono più di mille pagine di pergamena.
Anche fuori dal vaso, arderebbe il fiore.
***
Cada tarde regreso a tu cuerpo y siento una inmensa aflicción al verte abandonado, sostenido del madero por ese clavo ardiente esperando que alguien desprenda los declives de la decepción. Pero, nacida como soy, carezco de la fuerza para ascender a tu reino, ese reino tuyo, vislumbrado mas nunca alcanzado. Yo no puedo con el peso de tu cruz, en mi corazón no ha nacido la rosa que, al desencadenarse el estruendo del mundo, llague tu cuerpo de misericordia.
Ogni pomeriggio torno al tuo corpo e sento un’immensa tristezza nel vederti abbandonato, sorretto sul legno da quel chiodo ardente, nella speranza che qualcuno possa allontanare i pendii della delusione. Ma, nata così come sono, non ho la forza di ascendere al tuo regno, quel tuo regno, intravisto eppure mai raggiunto. Io non ce la faccio con il peso della tua croce, nel mio cuore non è nata la rosa che, scatenandosi il fragore del mondo, piaghi il tuo corpo di misericordia.
***
Aprendí a beber mi propia sed. Aprendí que, para soñar tu rostro, era necesario negarme en el amor. Así me hice una contigo, así arrastré mis pies por el desierto. Ese desierto que tú habías sembrado de espinas para probar que el amor es así: un caminar ciego sin pedir nada a quien se ama. Entonces opté por callar, por devorar los mil demonios de mis miedos, acepté que tan sólo era una ancila de tu reino. Viví sin vivir, amé sin amar, me negué buscando aquella rama desnuda donde descansar mi marchito cuerpo.
Ho imparato a bere la mia sete. Ho imparato che, per sognare il tuo volto, era necessario negarmi in amore. Così divenni una con te, così trascinai i miei piedi nel deserto. Quel deserto che tu avevi seminato di spine per dimostrare che l’amore è così: un cieco camminare senza nulla chiedere a chi si ama. Allora ho scelto di tacere, di divorare i mille demoni delle mie paure, volli essere soltanto un’ancella del tuo regno. Ho vissuto senza vivere, ho amato senza amare, mi sono rifiutata di cercare il ramo nudo dove mettere a riposo il mio corpo sfiorito.
Davanti a un corpo nudo, a cura di Alessio Brandolini, Edizioni Fili d’Aquilone, 2021

??????? ? ?? ????? ???? della messicana ???????? ?. ????????, a cura di Alessio Brandolini. Un libro intenso e sensuale, non privo di tensione erotico-religiosa alla Alda Merini di cui l’autrice ha tradotto molti libri, poesia che vibra di passione e forza dove l’amore è “un cammino senza nulla chiedere” e il visibile e l’invisibile si fondono nel prodigioso mistero della poesia.