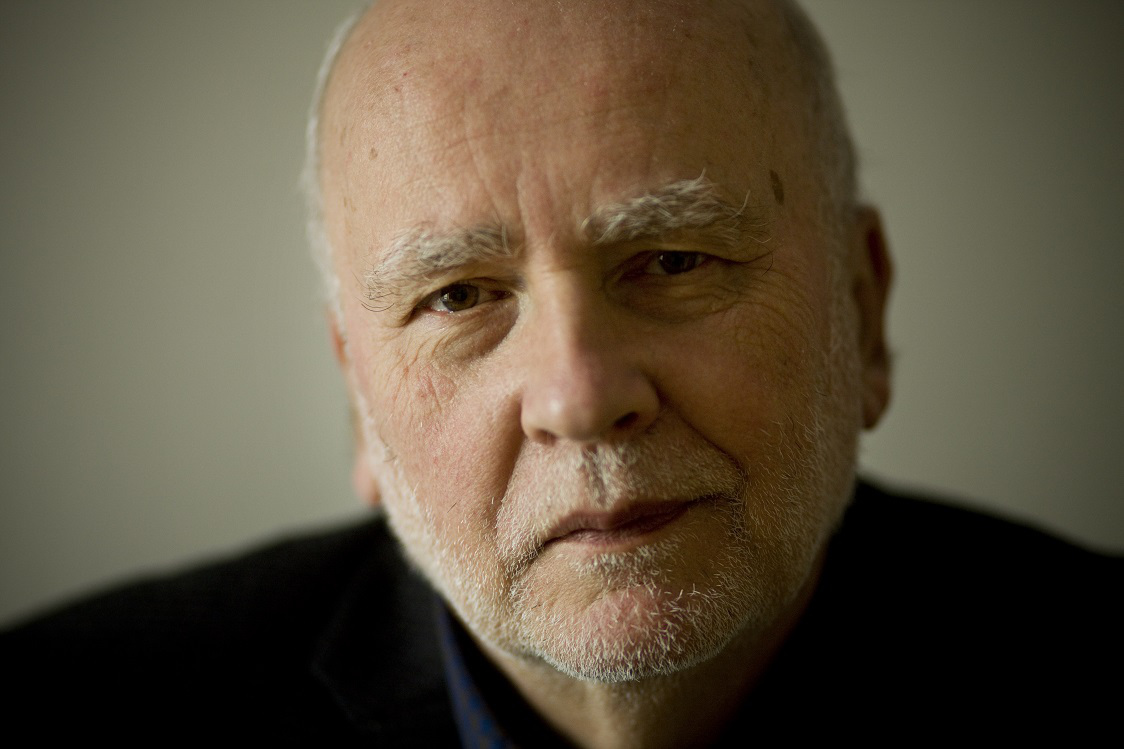RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA
La terra desolata? No, devastata. Quando Thomas Stearns Eliot nel 1922 pubblica il celebre poemetto, l’Europa è in effetti un luogo terribilmente solcato da macerie e distruzione, da dissesti materiali e finanziari, una terre gaste a misura dei poemi medievali, quelli del ciclo del Graal, del Re Pescatore e di Percival. Il richiamo non è dunque casuale. L’interessante proposta di una versione meno letteraria e più letterale del titolo è di Carmen Gallo che confeziona con testo introduttivo, traduzione e note d’apparato una nuova edizione per il Saggiatore.
La storia è nota: Eliot è a Losanna con la moglie, in cura per un lancinante esaurimento nervoso. Tra il dicembre del ’21 e il gennaio del ’22 compone The Waste Land e manda il plico con i fogli a Ezra Pound che opera praticamente una «Caesarean operation»: filtra, taglia, sintetizza. È lui il miglior fabbro a cui Eliot dedica i cinque ‘canti’ (La sepoltura dei morti, Una partita a scacchi, Il Sermone del Fuoco, Morte per acqua, Ciò che disse il Tuono) con cui è divisa La terra devastata. Cinque canti che sono composti secondo un preciso disegno artistico: il cosiddetto metodo mitico, ravvisato dallo stesso poeta americano nella recensione all’Ulisse di Joyce del 1923. In cosa consiste? Commenta G allo: «Eliot chiama in causa il ‘classicismo’, che definisce come fare ciò che si può ‘con il materiale a disposizione’, secondo le possibilità di tempo e di luogo. E sostiene il ‘metodo mitico’ joyciano, inteso non come rifugio nella ‘materia mummificata’ del passato, ma come continuo parallelo tra contemporaneità e antichità: l’uso di un paradigma archetipico per controllare, dare ordine e forma ‘all’immenso panorama di futilità e anarchia che è la storia contemporanea’».
allo: «Eliot chiama in causa il ‘classicismo’, che definisce come fare ciò che si può ‘con il materiale a disposizione’, secondo le possibilità di tempo e di luogo. E sostiene il ‘metodo mitico’ joyciano, inteso non come rifugio nella ‘materia mummificata’ del passato, ma come continuo parallelo tra contemporaneità e antichità: l’uso di un paradigma archetipico per controllare, dare ordine e forma ‘all’immenso panorama di futilità e anarchia che è la storia contemporanea’».
Il modernismo è tutto qui. In questa svolta del ‘classicismo paradossale’ (ampiamente utilizzato anche da Montale nella triade Ossi di seppia, Le occasioni e La bufera e altro) che mutua dall’antico, dal mondo classico segmenti poetici, interstizi narrativi e situazioni psicologiche capaci di ristabilire un ordine, ancorché fittivo, nell’epoca del caos della modernità. Ecco allora che la succitata tecnica espressiva possiede un deciso connotato ideologico con intenzioni euristiche: quel verso di Dante, quella menzione a Baudelaire, quel richiamo al Vangelo e alle Confessioni di Sant’Agostino che allargano a dismisura il bacino dell’intertestualità fino a far fluttuare il tessuto nel macrotesto di un ‘iperautore’, non sono soltanto opportunità per lo sfoggio di cultura di Eliot. Non si tratta di mera erudizione, insomma. Né vale la (debole) accusa di plagio che costrinse il poeta a redigere le famose note per l’edizione in volume del poemetto. Continua a leggere


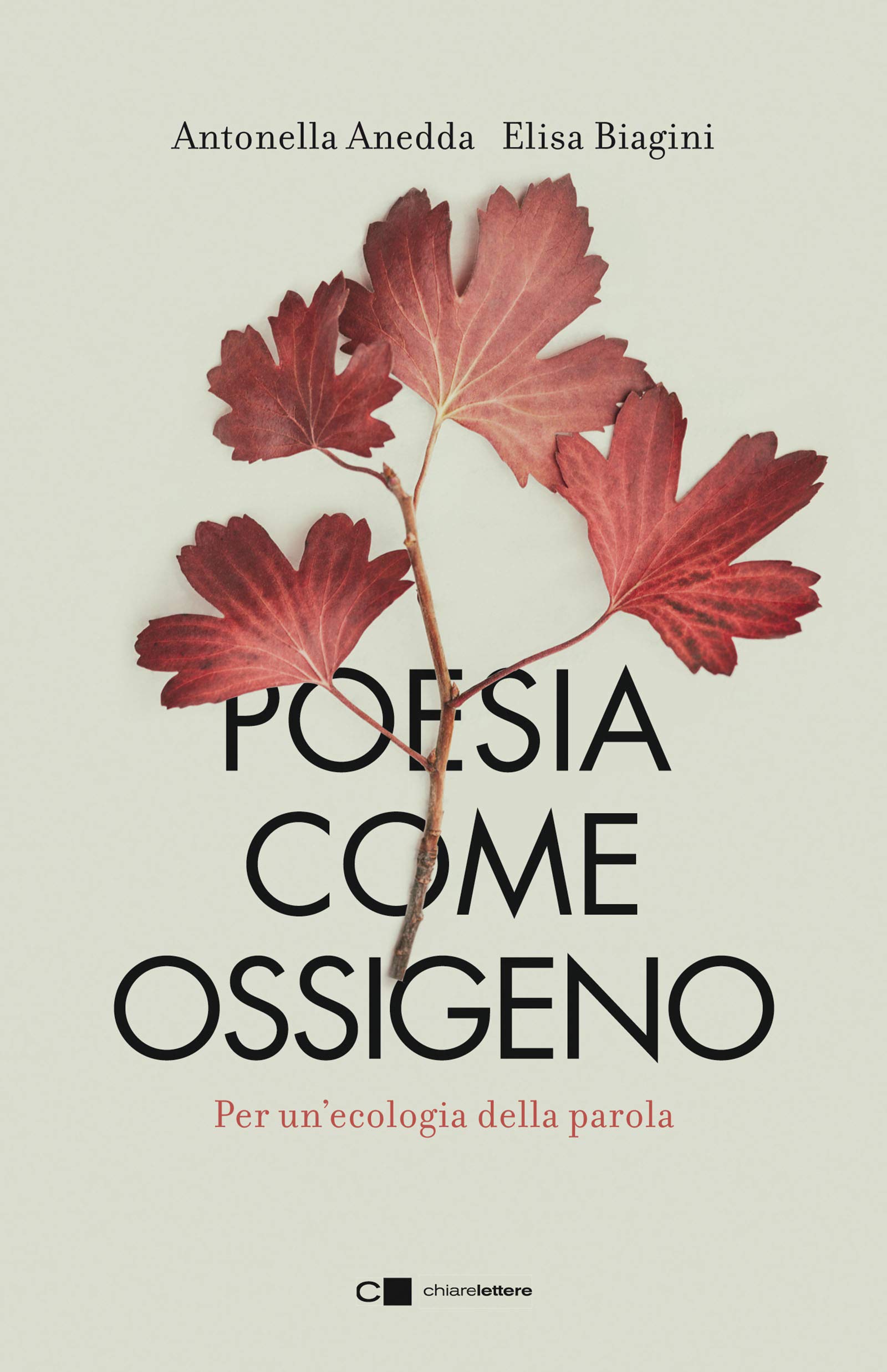
 Concetto peraltro ribadito in un altro scritto molto interessante della stessa Anedda: si tratta di un saggio poetico — sul modello di quelli di Jaccottet e Zagajewski ma punteggiato di lemmi e brevi argomenti che aumentano l’intenzione diaristica e la concertazione filosofica —, Geografie.
Concetto peraltro ribadito in un altro scritto molto interessante della stessa Anedda: si tratta di un saggio poetico — sul modello di quelli di Jaccottet e Zagajewski ma punteggiato di lemmi e brevi argomenti che aumentano l’intenzione diaristica e la concertazione filosofica —, Geografie. 
 COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA
COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA