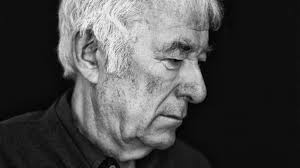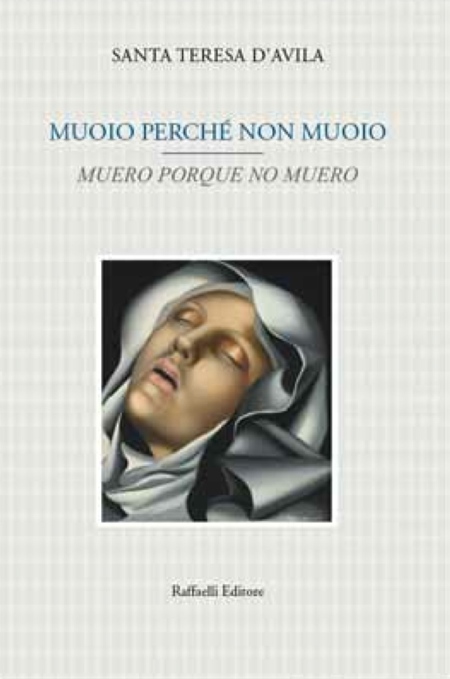 NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA
NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA
La tradizione a cui fanno riferimento i testi poetici di s. Teresa d’Avila (1515-1582) è senz’altro quella trobadorica: com’è segnalato nella notizia biobibliografica che segue i quindici testi selezionati e magnificamente tradotti dal curatore (Muoio perché non muoio, traduzione di Emilio Coco, Raffaelli editore, pp. 76, € 12), «tutto succedeva, scrive María de San José, ridendo e componendo “romances” e “coplas”». Il romance, in particolare, la forma poetica più tipica della tradizione spagnola, è sorto con i cantares de gesta e con i giullari, equivalenti iberici dei trovatori. La copla, cobla in occitano, è invece la strofa basica della poesia medievale. Le liriche sicuramente attribuibili a s. Teresa sono almeno una trentina (altre potrebbero essere state scritte da consorelle come María de San José), e la prima pubblicazione apparve nella miscellanea Escritos de Santa Teresa, con il commento di Vicente de la Fuente, nel 1862. Un’edizione singola delle Poesías uscì nel 1957.
Quelli di Teresa sono, in sostanza, testi d’amore. Ma di un amor mysticus, il cui destinatario è il «dolce Cacciatore», il Dio totalmente inaccessibile e absconditus che comunque «ferisce di dolcezza» — per utilizzare un’espressione di Jaufré Rudel, sicuro modello stilistico e tematico di questi versi — l’animo della poetessa. Ecco perché Teresa sente di partecipare a un’antinomia sostanziale dell’esistenza, e tutto l’apparato sintattico messo in campo ne testimonia la contraddizione e la razo: essendo l’Amato al di là della morte ma essendo Egli l’autore e la fonte della vita, in valore del passo evangelico di Mt 16,25 «chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà», la santa spagnola muore per il suo non morire. In altri termini: desidera perdere la vita per poterla guadagnare. Ma tale atteggiamento ossimorico non si ferma soltanto alla dicotomia suprema, bensì riguarda gli aspetti più minuti del quotidiano: «Sia nel pianto la mia gioia,/ soprassalto il mio riposo,/ la mia quiete dolorosa,/ e bonaccia la mia angoscia.// Tra le burrasche il mio amore,/ mio regalo la ferita,/ nella morte la mia vita,/ nel disprezzo il mio favore.// Mio tesoro l’indigenza/ il lottare il mio trionfo,/ mio riposo il lavorare,/ la tristezza il mio contento» (Aspirazioni). Con ardite antitesi petrarchesche, Teresa vuole rammentare a sé stessa e al lettore i paradigmi essenziali della vera vita: «Solo Dio basta». Questa è l’Efficacia della pazienza, questo è il duro richiamo a un esserci più marcato in profondità, solcato da un’inscalfibile consapevolezza. E quale poeta ai giorni nostri saprebbe tracciare un iter poetico più efficace del Cammino della croce? Quale poeta potrebbe oggi sperticarsi nelle Lodi alla croce o meravigliarsi della Bellezza di Dio con tale energia narrativa e fervore lirico?
Le poesie di s. Teresa — percorse da un’irriducibile venatura metafisica, che le rende attuali a ogni latitudine geografica e storica — sono uno scrigno di sapienza e di abnegazione, dedizione assoluta. Qualità, queste, assai utili per una società distratta come la nostra, che tuttavia potrebbe iniziare ad aprire gli occhi dinanzi a un simile bacino d’interiorità così ricco ed elevato.
Santa Teresa d’Avila, Muoio perché non muoio, traduzione di Emilio Coco, Raffaelli editore Continua a leggere