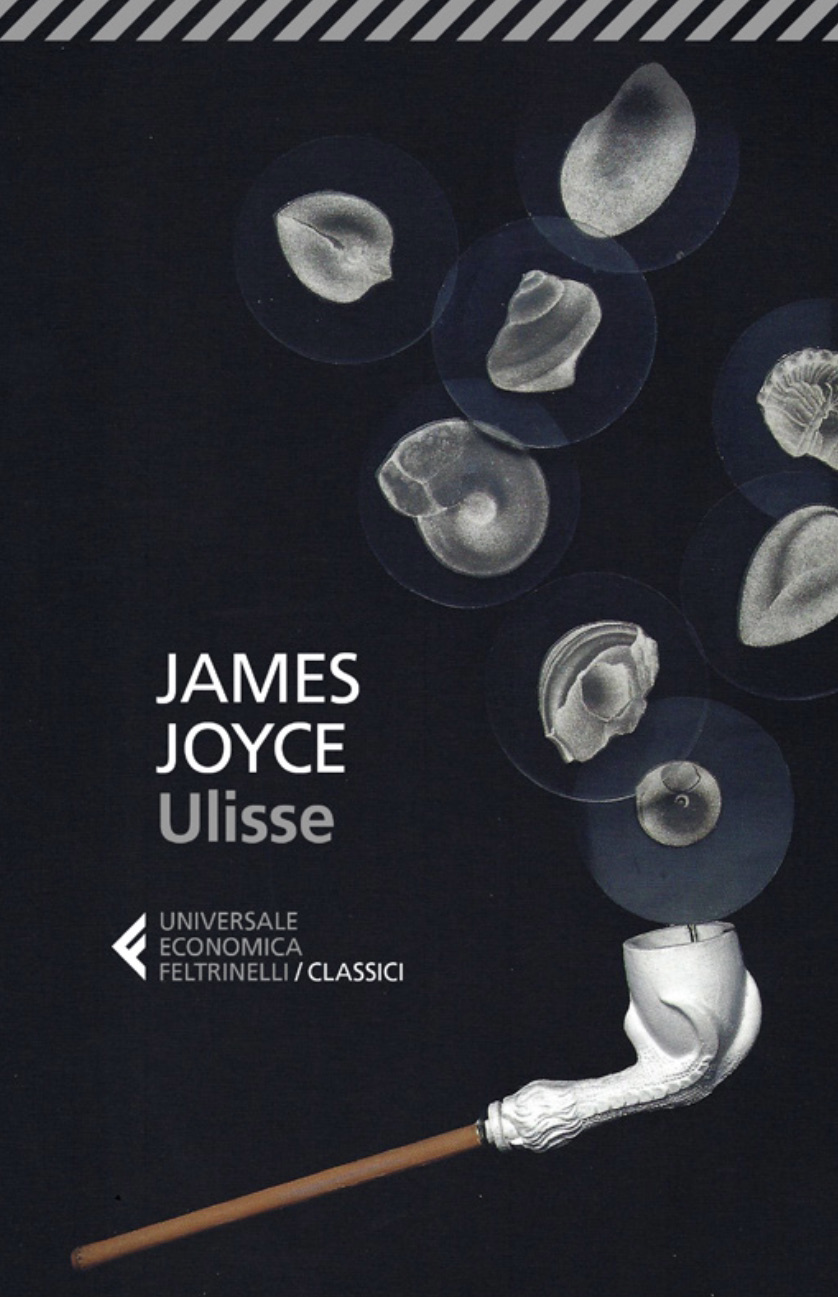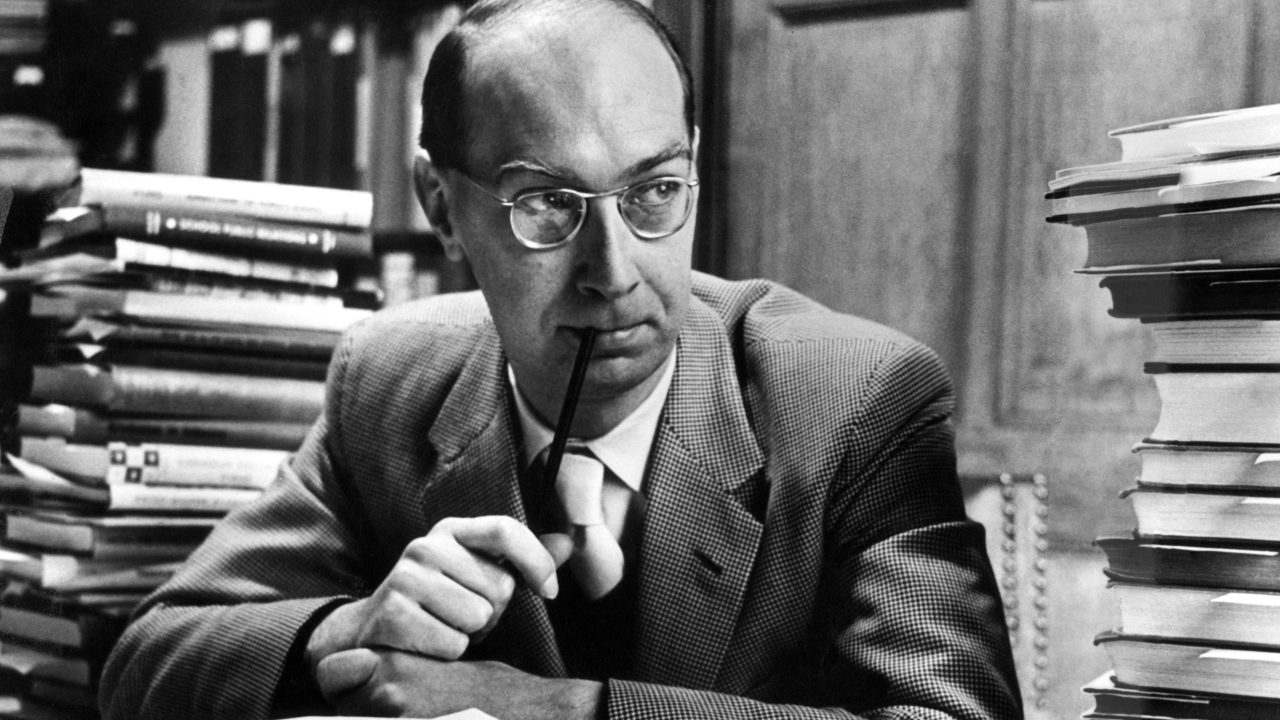John Keats
All’autunno
Tempo di nebbie e d’ubertà matura,
Dell’almo sole amico prediletto;
Tu che, seco, la vite ti dai cura
Di far felice d’uve, intorno al tetto,
E di pomi i muscosi alberi adorni,
Gonfi la zucca, e alle nocciuòle un sapido
Gheriglio infondi, e i frutti empi di nettare,
E ancor fai gemme, ultimi fior per l’api,
Ond’esse credon che coi caldi giorni
Sopra la terra Estate ognor soggiorni,
Per cui trabocca ogni umida celletta:
Chi non ti ha visto tra le tue ricchezze?
Talor chi cerca scopre te: sei colco
Su un’aia, pigro, ventilanti brezze
Fra i tuoi crini asolando; o presso un solco
Mezzo-mietuto, mentre il tuo falcetto
Lascia di tagliar l’erba e i fiori attorti,
T’infondono i papaveri il sopore;
O, attraversando un rivo, il capo eretto,
Come spigolatrice, a volte porti;
O, ad un torchio di sidro, gli occhi assorti
Tu fissi al gemitio per ore ed ore.
Dove son, dove i cantici di Maggio?
Non pensarvi, hai tu pur tua melodia:
Quando, affocando il dì che muor, d’un raggio
Roseo le stoppie opaca nube stria,
Un coro di zanzare si querela
Tra i salci fluviali, in basso o in suso
Spinte, secondo il vento cada o aneli,
E dai borri gli agnelli adulti belano,
Cantano i grilli, ed un gorgheggio effuso
Fa il pettirosso da un giardino chiuso,
Rondini a stormi stridono pei cieli.
Traduzione di Mario Praz Continua a leggere