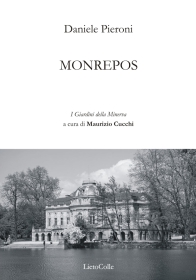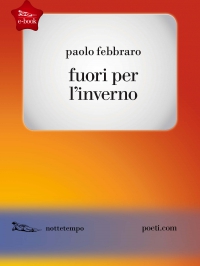La pornogrammia è il volto, il risvolto messianico della pornografia: un piccolo spostamento: scarto parodico: iper parodico: è il compimento, il perfezionamento di ogni dialettica di eros come stadio psichico e psico-pubblicitario: di eros e di porno: di funzione di oscenità e di valore di esposizione: è il risultato fermo della dialettica: il ritrarsi radicale del presente nel perfetto: da –grafia a –grammia… E’ un resto in stadio di effetto.
La pornogrammia è il volto, il risvolto messianico della pornografia: un piccolo spostamento: scarto parodico: iper parodico: è il compimento, il perfezionamento di ogni dialettica di eros come stadio psichico e psico-pubblicitario: di eros e di porno: di funzione di oscenità e di valore di esposizione: è il risultato fermo della dialettica: il ritrarsi radicale del presente nel perfetto: da –grafia a –grammia… E’ un resto in stadio di effetto.
La traccia di scrittura, ogni sua chiusura che però la tenga sì nel movimento, quindi la cosa che è stata in-scritta, è un che di ghegrammenon.
La pornogrammia, in somma, non si oppone alla pornografia, ma le sta accanto: le fa agio: la spurtusa solo.
La pornogrammia è cosa, forse non un oggetto… E provoca domande la cui elargizione è uno strazio, domande che insorgono e che continuano solo ad avere luogo: a scintillare levandosi. Continua a leggere
Category Archives: NELLO SCAFFALE
Daniele Pieroni, “Monrepos”
Dalla prefazione di Maurizio Cucchi
Daniele Pieroni realizza in questo suo nuovo libro, così internamente articolato, e pure così coerente, un momento decisivo, e direi il più nettamente alto e persuasivo della sua ricerca poetica. Lo si avverte, persino ad apertura di pagina, nella sobria ed energica densità della parola, nella solida compiutezza della forma, nella quale l’autore compie una meditazione lirica che potremmo definire sospesa tra un vivo senso di dolore e impotenza e un’adesione naturale, generosa, sempre attiva alla luce intermittente, eppure irresistibile dell’esserci, dell’esistere.
Ecco allora che la sua voce riesce a muoversi, nel decoro della sua pronuncia, tra le difficoltà concrete di una realtà personale in cui “il corpo vacilla”, in cui la concretezza delle cose tende a imporsi con il suo peso negativo e il coinvolgimento amoroso, il respiro aperto di un orizzonte in cui il poeta riesce a cogliere una serie di presenze varie, e in prevalenza vitali. Continua a leggere
Eliza Macadan, “Anestesia delle nevi”
 Non sappiamo da questo libro Anestesia delle nevi come era la vita in Europa quando inesplosa. Sappiamo che l’autrice europea e poliglotta ha adottato la terapia del freddo ed alzato le difese. Questo non si è risolto in debolezza, ma ha acuito sensibilità, reattività, riflessione e senso etico.
Non sappiamo da questo libro Anestesia delle nevi come era la vita in Europa quando inesplosa. Sappiamo che l’autrice europea e poliglotta ha adottato la terapia del freddo ed alzato le difese. Questo non si è risolto in debolezza, ma ha acuito sensibilità, reattività, riflessione e senso etico.
All’instabilità atmosferica, il libro aggiunge anche quella storica e morale, nonché una relativa calma emotiva, un tempo interiore con qualche eco di burrasca, ciò nonostante alcune dichiarazioni che echeggiano la finis Austriae, o una calma e decettiva apocalisse.
È questa della Macadan una poesia di energheia, di intonazioni e di virate del respiro. L’io poetico sa dire io con tutte le oscillazioni e le rifrazioni del caso.
Enunciazione, eloquio, immagini, cose, obbediscono a una interiore misura ritmica, a un fluire magmatico “fiume interiore” che li trascina verso la cadenza finale. Ogni sequenza è plurima e stipata di oggetti, aperti su più lati e prospettive. È una poesia di moto, un “andante con moto” inesorabile come il fluire dei tempi in un gorgo.
Alberto Toni, “Vivo così”
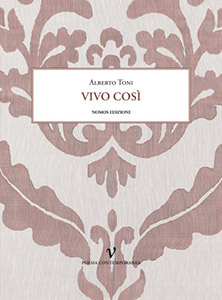 Dalla Prefazione di Mario Santagostini
Dalla Prefazione di Mario Santagostini
“Se mai esistesse ancora, un lettore ossequioso della divisione tra i generi letterari sosterrebbe che con questo libro di poesia Alberto Toni è rimasto fedele alla sua fondamentale, alta vena lirica ma l’ha, una volta per tutte, ramificata, contaminata, forse semistritolata fino a mascherarla e stravolgerla. Poi aggiungerebbe: Toni si è fermato un po’ prima d’arrivare nel terreno saldo dell’epos, è rimasto in una sorta di sua terra incognita. E noterebbe che nel viaggio si è servito di tutto: dai momenti verbali testati dalle storie letterarie fino ai topoi logori dal loro girare nella lingua viva.
La tesi troverebbe appoggi nelle serie di stilemi ripescati dalle grammatiche ermetiche che compaiono nel testo: per esempio negli inizi fastici nominali, o nelle anteposizioni dell’oggetto sul verbo. O nei puntuali e (io credo) studiati arcaismi, tra i quali un pascoliano “aree parole” mi pare essere il picco più evidente. Ma il richiamo alla tradizione e a un passo novecentesco o protonovecentesco è, in verità, soltanto uno tra i tanti componenti d’una matrice verbale primaria semisepolta nella memoria dell’autore e che, talvolta, riaffiora e offre frantumi, relitti lessicali riciclati, frammenti riusati. Tracce, insomma, di una sorta di lingua-sostrato che fa da supporto a una lingua di superficie anomala e generatrice di anomalie. Lingua dove coesistono momenti d’alta ricercatezza sintattica quale … ma anche a un passo il gelsomino/ tutto per te è fiorito/ e prelievi diretti del palato come: … Uno di passaggio che gli rivela qualche/ verità momentanea, tanto per dire/… ” […]
Continua a leggere
Paolo Febbraro, “Fuori per l’inverno”
Molti i temi e le soluzioni formali: le cinque sezioni affrontano la Storia, la Natura e l’Io nelle loro varie forme, evocando personaggi e miti del passato o affrontando decisamente il qui e ora.
Febbraro convoca più aspetti del mondo sulla propria pagina sonora e spesso tagliente, spaziando fra il monologo narrativo, la nuda scena e l’elegia, ma sempre riconducendo alla propria cifra stilistica personale, come un regista di teatro, le diverse figure che si presentano alla sua immaginazione.
Dalla quarta di copertina
I versi di Paolo Febbraro hanno da sempre un timbro ben riconoscibile, un elemento costruttivo razionale, un recitativo che si afferma nella forte suggestione ritmica dei suoi accenti. La sua è una vocazione teatrale, in qualche caso romanzesca, che contrastano con gli ideali che attraversano le poetiche del secolo scorso, che miravano a investire liricamente la realtà, o a fondarla nella parola. Continua a leggere