
Vicki Feaver, Credit ph. Caroline Forbes
The Handless Maiden *
When all the water had run from her mouth,
and I’d rubbed her arms and legs,
and chest and belly and back,
with clumps of dried moss;
and I’d put her to sleep in a nest of grass,
and spread her dripping clothes on a bush,
and held her again – her heat passing
into my breast and shoulder,
the breath I couldn’t believe in
like a tickling feather on my neck,
I let myself cry. I cried for my hands
my father cut off; for the lumpy, itching scars
of my stumps; for the silver hands –
my husband gave me – that spun and wove
but had no feeling; and for my handless arms
that let my baby drop – unwinding
from the tight swaddling cloth
as I drank from the brimming river.
And I cried for my hands that sprouted
in the red-orange mud – the hands
that write this, grasping
her curled fists
La fanciulla senza mani *
Quando l’acqua smise di uscirle dalla bocca,
e le ebbi strofinato gambe e braccia,
e torace e pancia e schiena,
con ciuffi di muschio secco;
e messa a dormire in un nido d’erba,
e stesi i panni fradici su un cespuglio,
e tenuta di nuovo stretta – il suo calore mi penetrava
nel petto e nella spalla,
il respiro cui non potevo credere
come una piuma a solleticarmi il collo,
mi lasciai andare al pianto. Piansi per le mani
che mio padre mi aveva tagliato; per i moncherini
tormentati dal formicolio di rugose
cicatrici; per le mani d’argento –
me le aveva date mio marito – che filavano e tessevano
ma non sentivano; e per le braccia senza mani
che avevano lasciato cadere la mia bambina – scivolata
dalla stretta fasciatura
mentre bevevo dal fiume rigonfio.
E piansi per le mani che germogliarono
dal fango rossiccio – le mani
che scrivono questo, e stringono
il riccio del suo pugno.
* In Grimm’s version of this story the woman’s hands grow back because she’s good for seven years. But in a Russian version they grow as she plunges her arms into a river to save her drowning baby.
* Nella versione dei Grimm le mani della donna ricrescono perché è stata buona per sette anni. Ma in una versione russa ricrescono mentre tuffa le braccia in un fiume per salvare la sua bambina che sta annegando.



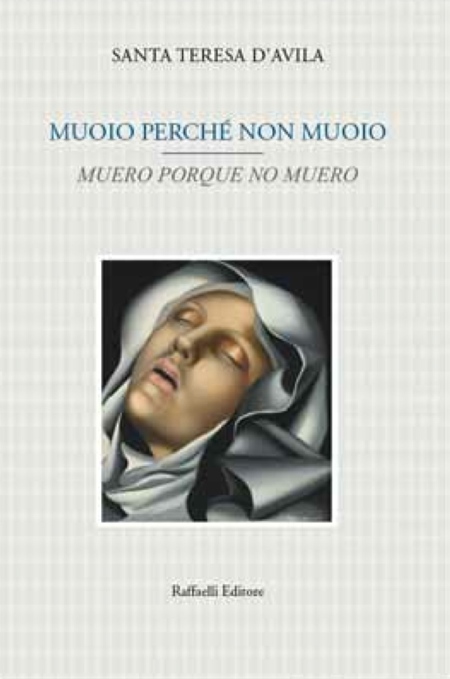 NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA
NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA