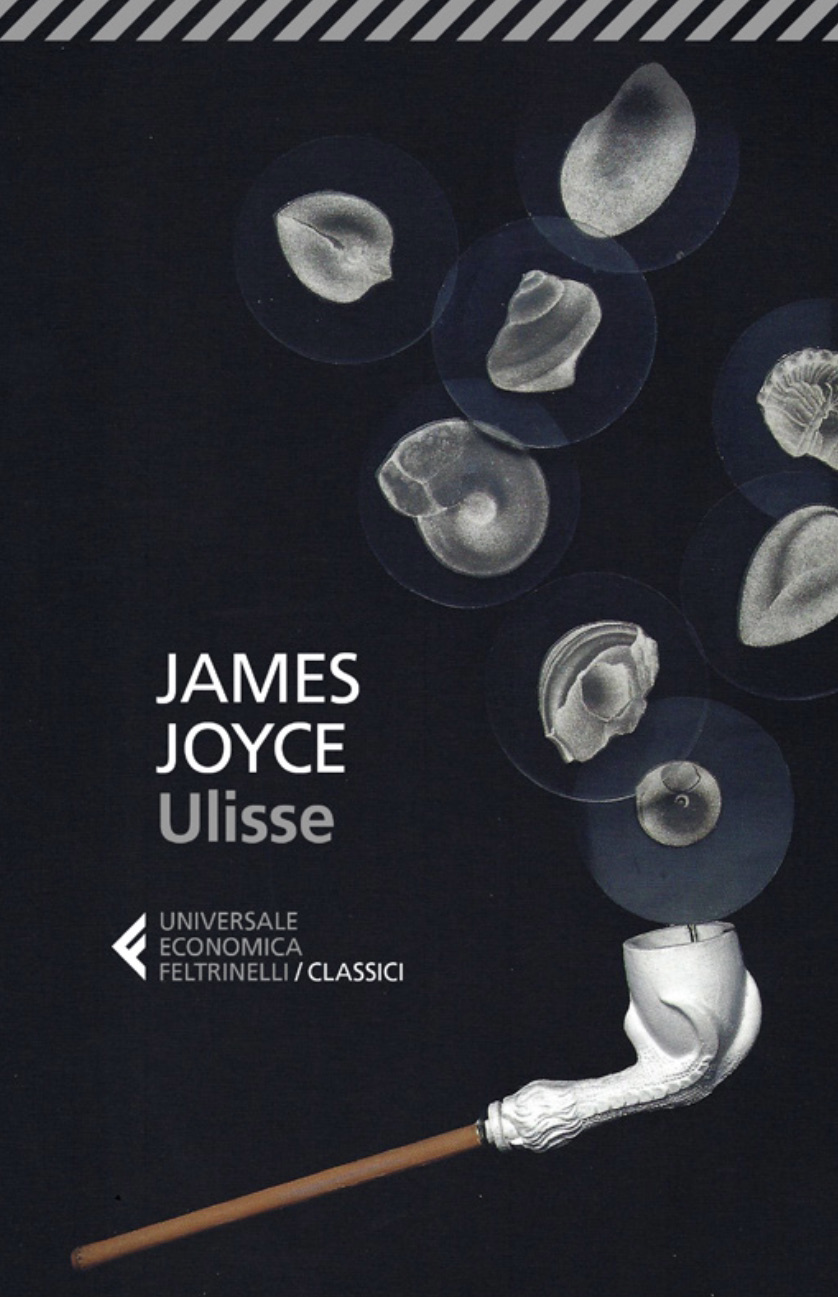Tag Archives: Alessandro Ceni
L'”Ulisse”, il capolavoro di Joyce, torna nella traduzione di Alessandro Ceni
In vista del centesimo anniversario della pubblicazione, nel febbraio 2022, il capolavoro di Joyce torna in una nuova traduzione a cura di Alessandro Ceni.
Dublino, 16 giugno 1904. È la data scelta da James Joyce per immortalare in poco meno di ventiquattr’ore la vita di Leopold Bloom, di sua moglie Molly e di Stephen Dedalus, realizzando un’opera destinata a rivoluzionare il romanzo. È l’odissea quotidiana dell’uomo moderno, protagonista non di peregrinazioni mitiche e straordinarie, ma di una vita normale che però riserva – se osservata da vicino – non minori emozioni, colpi di scena, imprevisti e avventure del decennale viaggio dell’eroe omerico. “Leggere l’Ulisse,” scrive Alessandro Ceni nella sua Nota introduttiva (qui pubblicata integralmente), “è come guardare da troppo vicino la trama di un tessuto” dove le parole, che sono i nodi della trama, rivoluzionano. Trascinata da una scrittura mutevole e mimetica, da un uso delle parole che è esso stesso narrazione, la complessa partitura del romanzo procede con un impeto che scuote e disorienta. Perché “un testo così concepito esige un lettore pronto a traslocarvisi armi e bagagli, ad abitarlo, a starci dentro abbandonando ogni incertezza”.
Una sfida insomma che, con il procedere della lettura, si trasforma in un vero e proprio godimento. Lo stesso di Joyce che, parlando del suo capolavoro, disse: “Vi ho messo così tanti enigmi e rompicapi che terranno i professori occupati per secoli a chiedersi cosa ho voluto significare; e questo è l’unico modo per assicurarsi l’immortalità”.
Nota introduttiva
di Alessandro Ceni
Ancora oggi il realista guarda solo verso
la realtà esteriore senza rendersi conto di
esserne lo specchio. Ancora oggi l’ideali-
sta guarda solo nello specchio voltando le
spalle alla realtà esteriore. L’atteggiamen-
to conoscitivo di ambedue impedisce loro
di vedere che lo specchio ha un rovescio,
una faccia non riflettente, che lo pone
sullo stesso piano degli elementi reali
che esso riflette.
Konrad Lorenz, L’altra faccia dello specchio –
La storia, disse Stephen, è un incubo dal
quale sto cercando di svegliarmi.
James Joyce, Ulisse
1. Abracadabra
Leggere l’Ulisse è come guardare da troppo vicino la trama di un tessuto. Spesso a rovescio. Per poi allontanarlo. E quindi riavvicinarlo. In un continuo movimento, anche muscolare, di avanti e indietro, o meglio, di indietro in avanti. Movimento durante il quale si ha coscienza e si dà contezza dello spazio e del tempo in cui esso avviene e dei sensi in atto. Questo processo diciamo ottico-cognitivo, incantatorio com’è proprio della sua qualità cinetica, incessantemente mettendo a fuoco e mandando fuori fuoco (offrendoci di volta in volta primi piani della fibra stessa del tessuto e campi lunghi dell’insieme dell’intreccio) ci conduce alla tutt’altro che stabilizzante condizione di trovarsi dentro e fuori dal testo contemporaneamente. L’Ulisse è la trama di una tela vista in simultanea nel recto, nel verso, alla luce ultra- violetta, a luce radente, e così via; tela che ha per telaio, che possiede per impianto portante, le due assi verticale-orizzontale delle due parole di apertura, “Stately” e “plump” (in questa traduzione “Sontuoso” e “polputo”), vale a dire l’alto/ basso, il drammatico/comico, l’eroico/farsesco del sopra/ sotto umano. Il dramma (nel senso stretto di rappresentazione seria di un avvenimento) e il comico (il suo contrario, la commedia dell’arte italiana) che vanno sobbollendo nel medesimo calderone danno origine per metamorfosi o trasformazione a una pozione che è la condizione del tragico quotidiano, quella condizione da tutti esperita dove l’antica matrice greca della ineluttabilità del destino e il moderno senso di illusorietà dell’esserci si fondono. I fili della trama del tessuto della tela sono i tanti e vari registri e colori (stilistici, linguistici) che animano questa stoffa fino a farcela balenare davanti per quello che potrebbe essere, per l’unicum che è: tutt’altro che “a misfire” (“un colpo mancato”, “una cilecca”), com’ebbe a definirlo Virginia Woolf, bensì uno straordinario e irripetibile colpito-e-affondato della scrittura. Un impensabile, fino ad allora (la data di pubblicazione è il 1922), tappeto magico.
2. Abracadabra
Nel leggere l’Ulisse ci si accorge che le parole, che sono i nodi della trama, rivoluzionano: com’è specifico della poesia, accade che le parole (anche una sola parola) illuminino violentemente rivoltandole le pagine, accendano orbitando di significato il tutto, incendino sul proprio asse l’immagine. Grande è la frequenza qui con cui la parola ci induce a percepire, grazie a una capacità sinestesica precipua della scrittura poetica, e in un modo a tal punto insistito che si potrebbe considerare l’intero testo alla stregua di un’unica poesia (niente a che vedere col poema), un’unica poesia dilatata, iperbolica, strutturata nelle 3 parti (I, II, III) ovvero macro-strofe del racconto divise in 18 episodi (3, 12, 3) ovvero scene ovvero macro-versi, dove ogni episodio è in realtà un lunghissimo, pantagruelico solo verso, ricchissimo di rime interne, assonanze, metafore ecc. che vanno materilizzandosi (cioè, vengono narrativamente rese) in persone, personaggi, casi, situazioni, frasi, espressioni ecc. L’impressione è che Joyce, superata nel 1916 la prova sperimentale del suo A Portrait of the Artist as Young Man, abbia voluto trasportare e ricomporre in prosa per il tramite tecnico della poesia una sua musica interiore, dove il geniale monstrum, il prodigioso ordito prodotto dall’unione di uno spartito sinfonico con un pezzo di chamber music ma dodecafonico – e Chamber Music è, come si sa, anche il titolo del primo libro di Joyce, una raccolta di poesie uscita nel 1907 –, miscela il recitar cantando (Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi) al melodramma pucciniano, le malìe di Ravel all’astrazione di Schönberg e alle fiamme di Stravinskij. È per questo che le sue parole nella pagina rivoluzionano: l’uso totale della lingua, declinata nei suoi multiformi linguaggi, fa della lin- gua in sé il racconto, il narrato (si presenta, diciamo, al pari di una Odissea della lingua, il cui canto è come se fosse per sortilegio in perenne esecuzione). E ancora: pittoricamente parlando, sembra quasi di assistere alla, per dir così, messa in scena di una pala d’altare giottesca, con la sua predella e le sue formelle (il cui ordine però è stravolto), dipinta da un cubista, di modo che lo stesso oggetto è osservato contemporaneamente da più punti di vista per ottenere una scomposizione che compone: un cubista con solidissime fondamenta figurative classiche (la mente va al Picasso di Les demoiselles d’Avignon).
3. Abracadabra
Dal leggere l’Ulisse – dai suoi nodi-parole della trama del tessuto del tappeto, dal suo inesorabile decontestualizzare e ricontestualizzare con la sua feroce conseguenza di spostamento di significati fino al rovesciamento e alla parodia (all’acuminato vertice della parodia della parodia), e oltre, fino alla purezza del travestimento e dell’imitazione (mai qui della dissimulazione o della falsificazione, perché qui tutto è onestamente e crudamente “reale” e “vero”), cioè a una sorta di sincronico incamminarsi sul filo senza bilanciere e farsi sparare dal cannone –, dal leggere l’Ulisse se ne può facilmente sortire con le ossa rotte e con la inquietante sensazione di non averci capito niente ovvero con la irritante sensazione di non possedere adeguate facoltà intellettuali, se non addirittura intellettive, oltre che con la ragionevole tentazione di liquidare il tutto come il coltissimo delirio di un letterato irlandese ebbro. In realtà, superato l’iniziale e, mi si passi, iniziatico sforzo di approccio, ponendosi in piena libertà e disponibilità nei confronti della sensibilità del testo, ci si può impadronire (e farsi irretire, esattamente farsi “prendere nella rete”) della profonda grandezza e bellezza di questo punto di non ritorno della letteratura mondiale di tutti i tempi. Da una parte il lettore tenga sempre ben presente che il modernismo joyciano, sodale della linea guida che andava allora tracciando il poeta Pound, ha salde basi evidenti e dichiarate oppure misteriosamente alluse proprio nella tradizione che va scardinando (avvelenando l’impianto stilistico dei grandi narratori dell’Ottocento europeo), secondo un procedimento comune a ogni opera d’arte autentica, e che qui, com’è ormai arcinoto, è costituita da uno zoccolo ovvero piattaforma (tettonica) o pangea formato dal Vecchio e Nuovo Testamento amalgamato alla totalità dell’opera shakespeariana (sulla quale Joyce abilmente riesce a innestare una speciale commistione ottenuta con le accese tinte di una novella chauceriana e le fosche di un truce dramma elisabettiano), passando per il mondo classico greco-latino, la mitologia gaelica e Dante e innervato da scrittori come Defoe, Sterne, Dickens, Rabelais, Cervantes, Balzac, tanto per rammentarne quasi a caso qualcuno; quindi il metodico lavoro di distruzione e di ricostruzione (di rinnovato utilizzo delle pietre del castello letterario) che caratterizza questo inedito omerico bardo del disastro dell’esistere poco o nulla ha a che spartire con l’inane macello di un avanguardista. Dall’altra parte un testo così concepito esige un lettore pronto a traslocarvisi armi e bagagli, ad abitarlo, a starci dentro abbandonando ogni incertezza, a imbarcarvisi provando dunque quel particolarissimo stato d’animo che si ha nel navigare, di identificazione di sé con la nave (io sono la nave/la nave sono io, la nave mi ha/io ho la nave): sono portato dal mezzo e ne divengo il mezzo. Al lettore è richiesto, insomma – an- che se è possibile che ne riemergerà come sfiorato dalla baudelaireiana “ala del vento dell’imbecillità” e stordito, claudicante, balbuziente – di calarsi nel buio della parola, nell’abisso della lingua, di scendere nell’agone di quelle pagine come un antico atleta di Olimpia: nudo. Si esige qui il cedere e l’affidarsi alla consapevole scelta del precipitare (in quel “Sì” con cui si chiude il viaggio?), evitando di controllare gli strumenti, le bussole e i portolani o i radar sollecitamente forniti dallo sterminato contributo critico e dall’apparato di commenti, glosse, note (utili, senza dubbio, ma giustificabili quasi del tutto da, legittimi, criteri editoriali), eludendo se possibile il sotteso, e presunto, schema compositivo che ricalcherebbe episodi dell’Odissea (e che a me pare invece presentarsi come un ulteriore depistaggio, a posteriori, joyciano, una ulissica trappola nella trappola, tanto ammiccante quanto grottesca, e proprio per le sue caratteristiche di erranza ed enigmaticità), e persino la figura medesima di Ulisse, che andrei casomai a rintracciare, anziché nell’eroe omerico, nell’arcaica figura mitica di un dio solare, cioè della nascita e della morte, antecedente alla colonizzazione greca dell’Egeo, pertanto da far risalire a prima dell’epica che lo riguarda. Il lettore infine cessi di continuare a guarda- re del prestigiatore il cilindro con la puerile speranza di capire come e perché ne esca il coniglio.
Alessandro Ceni, tre poesie

Alessandro Ceni
Persona sul crinale recinto
I peli del cardo quando volano
ai termini dei campi
chini sul capo addormentato
sfigurato dai sensi dell’asta abbandonata
alle reti
di prode lacune balatri d’uccelli
di litoranee selve d’arbori e d’agri argini
acuminati di gialle fruste
di fossi sannuti e balze e pruni e gelsi
dove declivano le ultime erte
fino a diroccarsi in abisso
la cancellata chiude l’ingresso della cava
la gente dalla rupe
il profilo steccato dell’orlo lì
il terreno è tutto dilavato
si muove e non puoi dirlo
sopra rare fronde
pigliati nelle frasche
per dune
forre stagni
dove lumina la chiostra degli scomparsi
l’eterna e sconfortata luna
la pianta emersa nel buio d’una notte
in diagonale col muro
i pappi muoiono con immote pupe al fianco
oltre i ferri puntuti della fibbia
***
Autocombustione
Mai in loro presenza.
Bensì dalla distanza, abbracciali,
quando sei invisibile e lontano, tutti,
affetti e amici.
Ma mai in loro presenza.
Lascia che il fiume sciolta in te la zavorra della speranza
si volga a controllare gli scalmi
e discenda le numerose anse del suo andare, che moltiplichi,
sgomiti, macini sassi stesi ed erbe insane: cose, tutte,
facilmente immaginabili: il fiume trasporta
banali cose: lo scomparso dato per scomparso, il
frammento del figlio rotto, la prestanza del drudo
e l’ignominia della sonda, l’incrollabile pornografia
della salvezza inalberata e il registratore
con incorporato il fantasma che assonaglia
catene da neve fuori scena o goccia a goccia
come collirio o flebo si esprime: rumori e insistenza.
Stringili al cappio del tuo infelice pensiero,
alla gomena del capestro della tua mente e,
allentato il solitario argano, impiccali,
sequenza per sequenza, nell’inutile cassero del tuo angusto cuore,
affinché come vibratili fiaccole dentro una caverna
o agitate ricerche sopra le rughe del mare o
grida controvento tra il vento nel frumento
restino avvedutamente inconsapevoli e più saggi
così privati del tuo nascosto amore. Continua a leggere
Alessandro Ceni, “Ho visto delle cose”

Alessandro Ceni
Io ho visto soltanto cose che impietriscono e commuovono come un perenne addio ai compagni. La sofferenza obiettiva dell’animale; le file dei bambini di altra nazionalità su un traghetto straniero andare via; i verdi pianori dove appaiono le città incendiate delle popolazioni ignote, le fedeli agli dèi e fiduciose dell’uomo, estinte come la piuma e il pelo; le innumerevoli forze occulte, gelose dei loro possessi, le terre gli alberi i fiumi che si debbono continuamente propiziare con sacrifici disperdere gli illusi dalla speranza di restar sempre uniti, perché la patria è soltanto un campo di tende in un deserto di sassi; le parole immorali della società civile baluginare anche negli occhi dell’amata un attimo prima dell’amore e la massa occulta e ostile dei suoi pensieri scivolarci nel mezzo, gravarmi addosso come uno sconosciuto che si chinasse all’orecchio e mi narrasse alcunché d’incomprensibile, per poi dormire e amare me; la sempre presente stanza accanto dove sotto lampadine purpuree qualcuno si pratica l’iniezione che guarisce e all’aprirsi della porta comparire l’airone. Ho visto delle cose, come tutti. da Mattoni per l’altare del fuoco, Jaca Book, Milano 2002 Continua a leggere
Giancarlo Pontiggia, “Voci, fiamme, salti nel buio”

Giancarlo Pontiggia, credits ph Dino Ignani
COMMENTO DI FABRIZIO FANTONI
Dopo “Il moto delle cose” Giancarlo Pontiggia torna a sorprendere il lettore con un’opera di rara intensità emotiva: “ Voci, fiamme, salti nel buio”, (Stampa 2009).
L’opera, divisa in due poemetti, – “Il camion e la notte” ed “Animula”- evoca un viaggio onirico che prende le mosse “in un vecchio cortile lastricato di beole grigie”.
E’ in questo spazio di quotidiana semplicità che ha inizio lo scivolare lieve e dolce tra le cose del mondo, quel “ perdersi in quei meandri favolosi/ sogni slanci chimere / tutto ciò che affonda nella vita”, che ti trasmette la gioia voluttuosa di perdersi in un oceano, la vertigine suprema di non essere più nessuno. Ci si ritrova così a contatto con la dimensione più autentica e vera della vita, che si squaderna davanti al lettore in tutte le sue forme, nel suo continuo farsi e disfarsi, nei suoi cambiamenti e nelle sue persistenze, mostrando “quanta notte è ovunque, quanto nero / tra le cose del mondo”. Questa lenta discesa all’origine del tutto è sottolineata dall’andamento della lingua che, da una pacata narratività dei primi componimenti, diviene – in particolare nel secondo componimento intitolato ”Animula”- sempre più magmatica: una moltitudine di materiale linguistico che prende direzioni inaspettate, raggrumandosi in forme inattese che si sfaldano per assumere nuova consistenza.
Il lettore si sente coinvolto dal martellìo costante della lingua e si trova a vorticare tra le parti che compongono il mondo, partecipando “all’inerzia delle cose”.
Con questi componimenti Giancarlo Pontiggia ci porta nella “notte, improvvisa, / con il suo mantello di nuvole scure…” in cui ha sede la poesia o, meglio, la sua origine.
La notte di cui parla Pontiggia altro non è che una dimensione spirituale in cui si ritrova il poeta nella più completa solitudine, in attesa che la parola si depositi.
Scrive Cristina Campo: “ come la manna di Sant’Andrea nella cavità dell’ampolla, il destino si forma nel vuoto in virtù delle stesse leggi complementari che presiedono al nascere della poesia: l’astensione e l’accumulo. La parola che dovrà prendere corpo in quella cavità non è nostra. A noi non spetta che attendere nel paziente deserto, nutrendoci di miele e locuste, la lentissima e istantanea precipitazione. Che è breve e non ripetibile”.
L’esperienza del sorgere della poesia ha qualcosa di simile ad una tensione mistica. Continua a leggere