
Roberto Esposito
IL DOPPIO VOLTO DELL’IMMUNITA’
DI ROBERTO ESPOSITO
Bisogna stare attenti a non ridurre il significato del concetto di immunità a un’esperienza recente, di carattere medico o giuridico, volta a chiuderci entro confini difensivi nei confronti dell’altro. Ciò non è sbagliato, ma va inserito in un orizzonte più ampio, adottando uno sguardo di lungo periodo.
Da questa prospettiva, per così dire genealogica, l’immunità, o l’immunizzazione è un paradigma attraverso il quale è possibile rileggere l’intera storia moderna. Se l’esigenza di autoprotezione della vita caratterizza tutta la storia umana, rendendola possibile, è nella modernità che essa viene percepita come un problema fondamentale, e dunque come compito strategico.
Privati delle protezioni naturali di carattere teologico che avevano caratterizzato la stagione premoderna, gli uomini sentono il bisogno di costruire dei dispositivi immunitari di tipo artificiale per proteggersi dai mali, dai conflitti e anche dalle novità che li minacciano, il primo dei quali è lo Stato moderno.
Quanto accade oggi non è che l’ultimo passaggio, sempre più accelerato e quasi ossessivo, di questo processo. Quello cui assistiamo, insomma, è uno straordinario mutamento di scala di un processo risalente nel tempo. Per capire il fenomeno in tutto il suo rilievo, storico, filosofico, antropologico, non dobbiamo smarrire la complessità del meccanismo di immunizzazione, evitando ogni semplificazione polemica o retorica.
Esso è un processo ambivalente, che produce effetti contraddittori. L’immunizzazione è allo stesso tempo necessaria e rischiosa, protegge dai rischi e ne genera a sua volta altri. È necessaria perché nessun corpo individuale o collettivo potrebbe sopravvivere a lungo senza un sistema immunitario che lo protegga da conflitti insostenibili – per esempio senza il sistema immunitario del diritto una società esploderebbe. Ma è rischioso perché, oltre una certa soglia, l’eccesso di protezione rischia di bloccare l’altra esigenza umana fondamentale che è quella della comunità, cioè della relazione tra gli uomini.
Il problema che abbiamo anche oggi di fronte non è quello, semplicistico, di contrapporre comunità e immunità, ma articolarle in una forma sostenibile che non sacrifichi l’una a favore dell’altra. Certo, oggi, forse mai come oggi nel corso di tutta la storia, assistiamo ad una crescita abnorme dell’esigenza immunitaria. Essa è diventata il perno intorno al quale ruota tutta la nostra esperienza reale e simbolica, il punto d’incrocio di tutti i linguaggi – biologici, giuridici, politici, economici. Riguarda insieme il corpo individuale e il corpo collettivo, il corpo sociale e il corpo informatico, tutti in difesa contro i virus di vario genere che li attaccano o sembrano attaccarli.
In questo modo l’equilibrio tra communitas e immunitas sembra spezzarsi a favore di quest’ultima. Il limite appare superato, con la conseguenza di ridurre al minimo non solo la vita in comune, ma perfino la libertà individuale. Il rischio ultimo cui le nostre società immunizzate vanno incontro è quello che si sperimenta durante le malattie autoimmuni, quando il sistema immunitario è talmente forte da rivolgersi contro lo stesso corpo che dovrebbe proteggere, distruggendolo.
Si è visto che questo – un eccesso di difesa da parte degli anticorpi – è quanto accade anche nel covid 19, con l’esito di infiammare i polmoni, come scrive nel suo ultimo libro sull’immunità – Il fuoco interiore – l’immunologo Mantovani. Qui si determina il classico controeffetto delle procedure immunitarie quando sono spinte aldilà della loro funzione normale. Continua a leggere

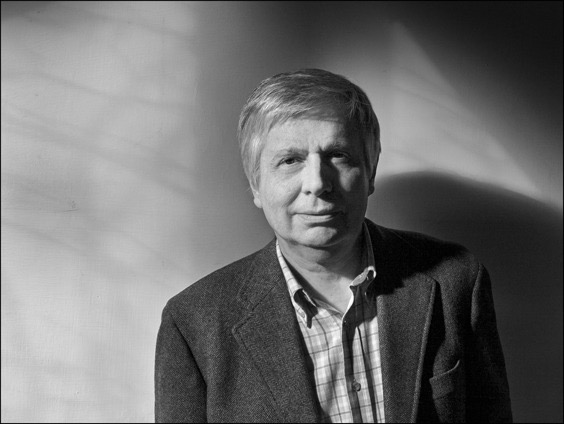

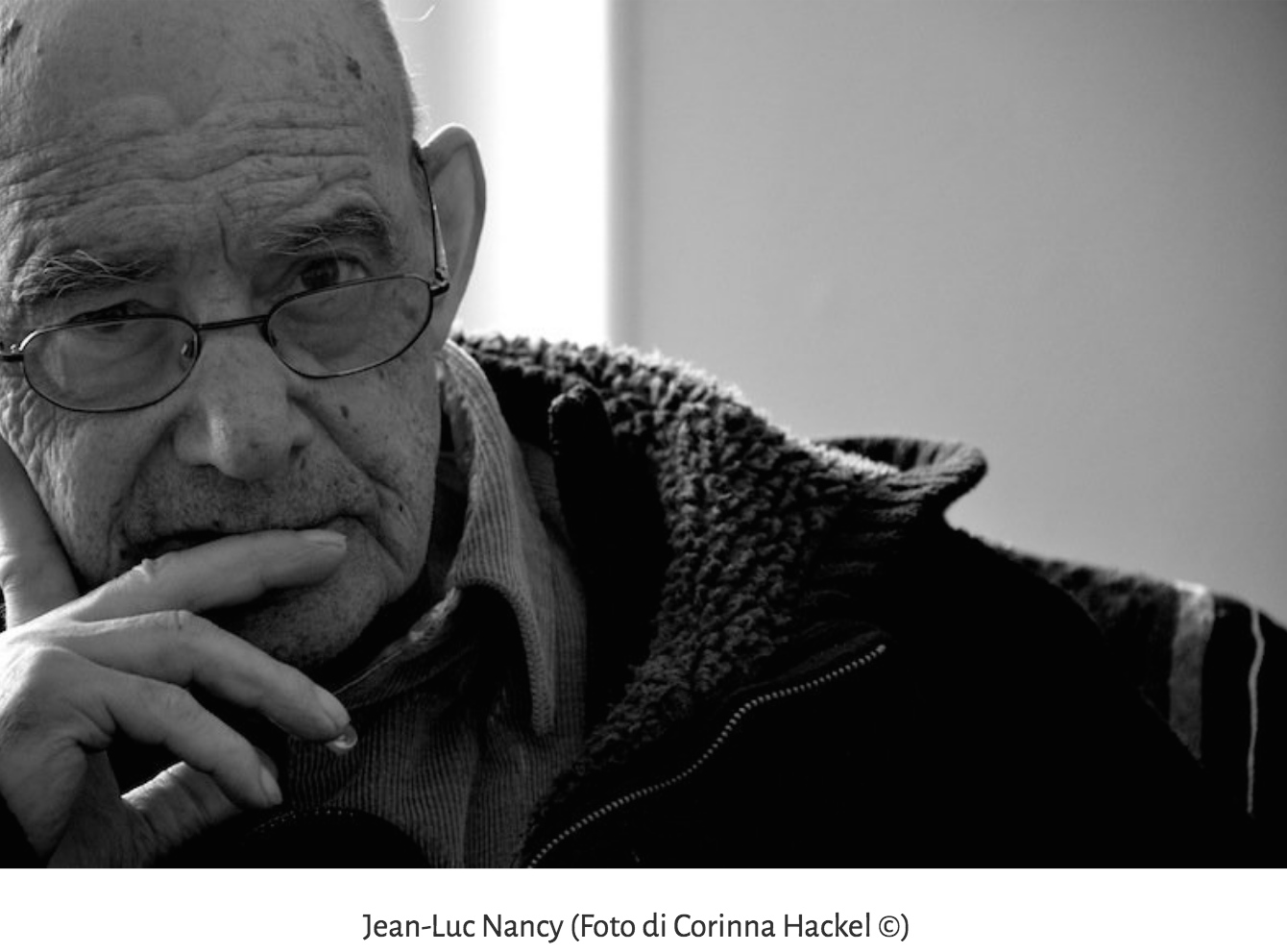 INTERVISTA A JEAN-LUC NANCY
INTERVISTA A JEAN-LUC NANCY