
Ritratto del poeta milanese Carlo Porta (1774-1821), in un pastello del Bruni (1821)
Sissignor, sur Marches, lu l’è marches,
marchesazz, marcheson, marchesonon,
e mì sont el sur Carlo Milanes,
e bott lì! senza nanch on strasc d’on Don.
Lu el ven luster e bell e el cress de pes
grattandes con sò comod i mincion,
e mì, magher e biott, per famma sti spes
boeugna che menna tutt el dì el fetton.
Lu senza savè scriv né savè legg
e senza, direv squas, savè descor
el god salamelecch, carezz, cortegg;
e mì (destinon porch!), col mè stà sù
sui palpee tutt el dì, gh’hoo nanch l’onor
d’on salud d’on asnon come l’è lu.
Lei è marchese, sì, signor Marchese,
marchese, marchesotto, marchesone;
io so il signor Carlo milanese
e basta, senza briciola di Don.
Lei si fa lindo e bello e prende peso
grattandosi con comodo i coglioni;
io per campare, magro, in male arnese,
mi faccio il culo in continuazione.
lei senza saper scrivere né leggere,
senza, quasi direi, saper discorrere,
si gode smancerie, vezzi, corteggi;
io qui (porca la sorte!) su quei bei
registri tutto il dì, neanche ho l’onore
d’un saluto dall’asino che è lei. Continua a leggere

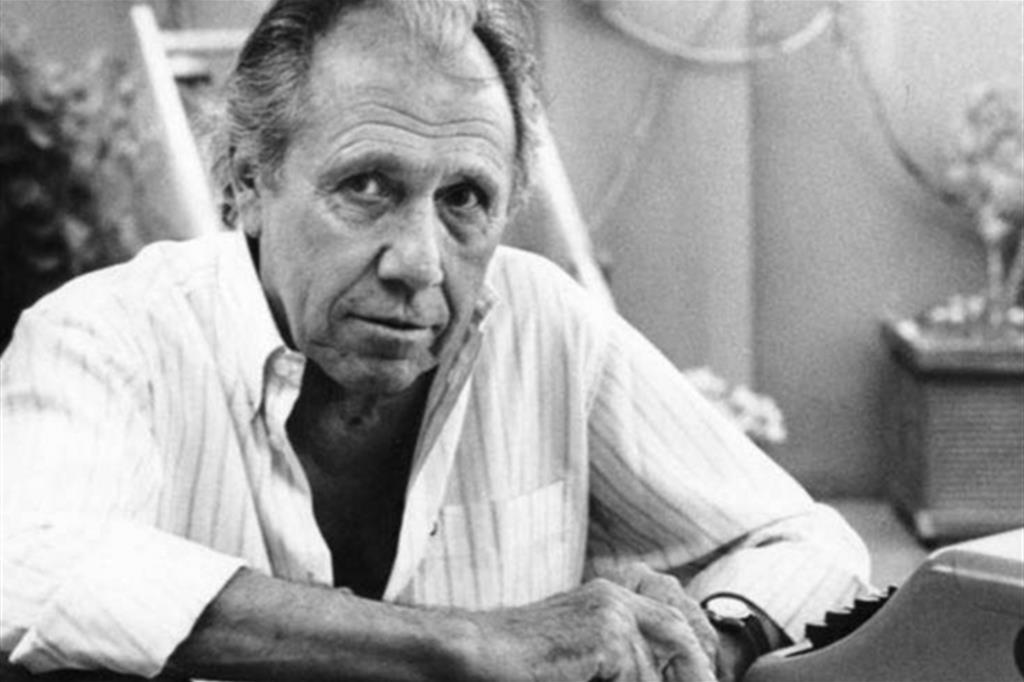 di Eleonora Rimolo
di Eleonora Rimolo

