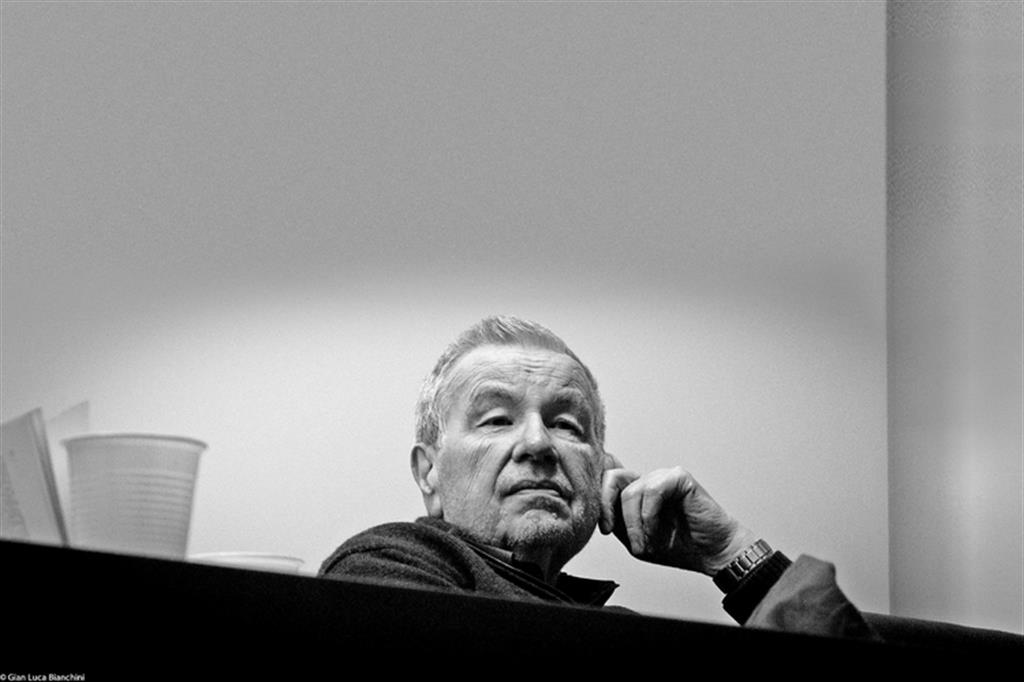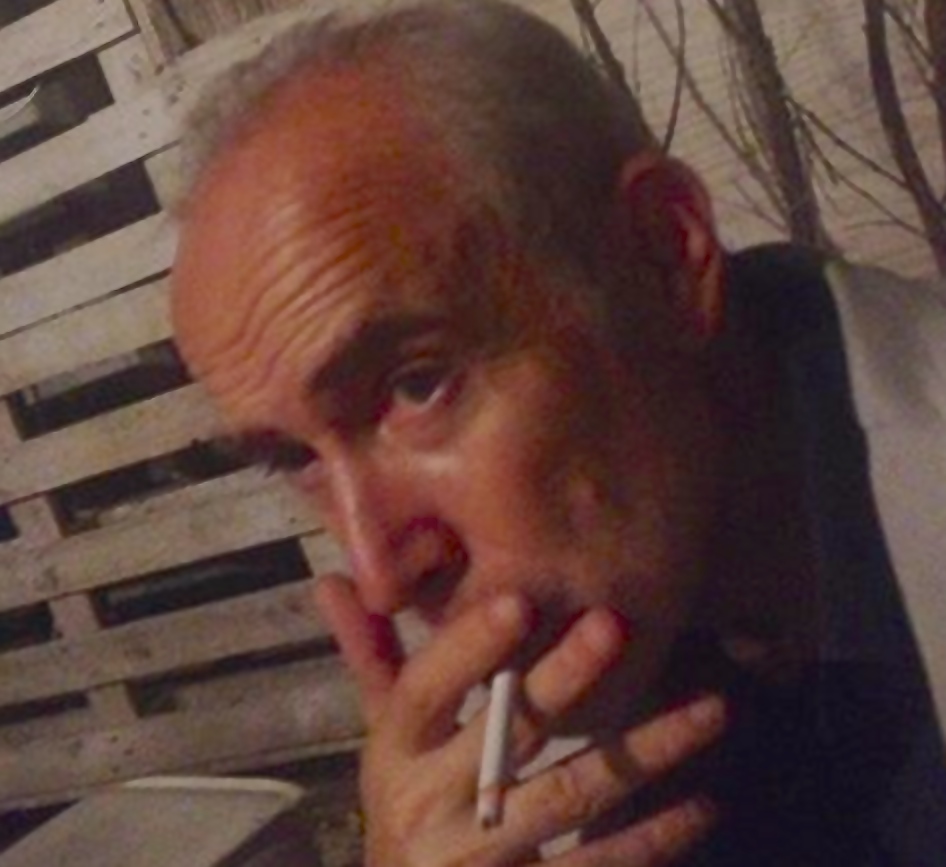Luigia Sorrentino
Nota critica di Giuseppe Martella
Fatto salvo il suo valore poetico intrinseco, il testo “Olimpia, Tragedia del passaggio” di Luigia Sorrentino (in scena al Napoli Teatro Festival Italia, direzione artistica di Ruggero Cappuccio, il 16 luglio h.22.30, Giardino Romantico di Palazzo Reale, a Napoli) ha tutte le valenze proprie di una sceneggiatura rituale, come per esempio La sagra della primavera di Stravinsky, di per sé musica memorabile che tuttavia si compie appieno nelle movenze del balletto omonimo. Alla sola lettura, Olimpia (Interlinea, 2013, 2019), sembra infatti quasi opporre resistenza come un diamante: un’architettura splendida e tagliente, immersa nell’azzurro intenso di un cielo mediterraneo. Una creatura di luce: donna, città e dea. Nel corso del testo, ti rimanda poi figure cangianti in cui ti rifletti ruotandovi intorno, come in un assedio senza fine. Una città-tempio ben difesa da alti bastioni, sui cui spalti appaiono visioni elusive di larve e di donne, di colossi e di chimere. Una città fuori del tempo, certo, nuova e vecchia insieme, sfuggente visione nel bianco che ti acceca.
*
Un’architettura più che umana che custodisce gelosa i segreti di un mondo e i possibili tempi della sua storia. Il testo appartiene alla linea alta, visionaria e veggente, del simbolismo europeo (tra Otto e Novecento, da Rimbaud a Valery, da Hölderlin a Rilke, e fino a Paul Celan), condensata al massimo in un intreccio archetipico che ha già di per sé movenze da tragedia greca, dal momento che i ruoli degli attori e del coro si fondono in una dimensione estatica, impersonale e sembrano obbedire ai dettami di un fato occulto tanto più quanto ci sembra di essere “sempre sulla soglia di una scoperta cruciale” (Milo De Angelis) e quanto più la scena sembra annegare in un tripudio di luce (il dominio del colore bianco assume qui infatti la doppia connotazione della purezza e del lutto).
Strutturalmente si tratta infatti di un dramma pronominale dove la permutazione delle tre persone (io, tu, lei) avviene con cadenze cerimoniali che distribuiscono il dentro e il fuori ad ogni cambio di scena. Lasciando poi che siano gli spettatori (lettori) ad assegnare le sfere dell’immaginario, del simbolico e del reale in questo percorso iniziatico che coniuga le due facce del mito greco, essoterica ed esoterica, la luce di Olimpia e l’ombra di Eleusi, proiettandole verso l’irrisolvibile ambiguità del tragico. Nel complesso il testo organizza i suoi spazi semantici proiettandoli sulla mappa dei luoghi della città sacra, sicché l’intreccio che ne risulta è letteralmente una serie di superamenti di soglia o di riti di passaggio, per cui la costruzione e la visita di questa città di parole alla fine coincidono. L’architettura e l’archeologia si sovrappongono in modo tale che quando si è giunti alla fine del percorso si viene rinviati all’inizio e la città nuova lascia intravedere in sé lo scheletro di quella vecchia, l’insieme di detriti e di rovine che costituiscono le sue fondamenta. Torniamo così nella grotta dell’inizio, nel ventre della terra madre da cui siamo usciti, chiudendo una specie di cerchio magico di cui l’immagine del lago, che si trova al centro del poema, costituisce il fuoco virtuale della riflessione, l’occhio immoto del ciclone, la sua soglia simbolica interna: il luogo del possibile sprofondamento del volto che ci manca, la “lei che è lì” dall’inizio, l’oggetto del desiderio e dell’adorazione, della ricerca e del canto, l’Euridice di Orfeo, l’ombra amata che può ad ogni istante sprofondare “a un passo da noi”. Perché qui si tratta di una iniziazione che è nel contempo esistenziale e poetica. Ed è a questo punto che, in Olimpia, all’io poetico come allo spettatore, viene incontro “il traguardo dell’ombra” (39), la porta liquida che gli può consentire di scendere nell’immemoriale inconscio per trarne fuori immagini mirabili, oppure al contrario condannarlo a sprofondare insieme ad esse in un vortice allucinatorio, nel labirinto di specchi e nella foresta di simboli che pure deve necessariamente costruire e attraversare. La struttura del testo di Olimpia, pure nella descrizione sommaria che si è data, ci rimanda dunque imperiosamente a quell’orizzonte mitico in cui soltanto quest’opera può davvero essere vissuta e compresa.