 di Fabrizio Fantoni
di Fabrizio Fantoni
Roma, 10 febbraio 2013
Milo De Angelis nella prefazione di “Olimpia” (Interlinea 2013), afferma: “Scrivendo Olimpia, Luigia Sorrentino scrive il libro della sua vita. Olimpia punta all’essenza, tocca in profondità le grandi questioni dell’origine e della morte, dell’umano e del sacro, del nostro incontro con i millenni. Ha uno sguardo lungimirante: sguardo ampio, prospettico, a volo d’aquila. Ma ha anche improvvisi affondi nella fiamma del verso.”[…] E aggiunge: […] “I tempi s’intrecciano, entrano in un’epopea dove tutto è così nostro da diventare remoto, tutto è così perduto da diventare presente. Olimpia riesce a esprimere questo tempo assoluto, e lo fa in modo mirabile, con architetture possenti ma anche con i guizzi fulminei della vera poesia. Tempo assoluto che contiene ogni tempo.” Un’opera della maturità, sottintende il poeta scrivendo: “Olimpia punta all’essenza, tocca in profondità le grandi origini della vita e della morte.”
Chi è per te Olimpia?
“Olimpia” è l’incontro con un luogo, con un’essenza femminile, con una città, con una condizione, la condizione umana. Nel libro non vi è più nulla della città, forse non c’è più nemmeno l’umano, ma soltanto il riverbero di una voce che arriva da lontano. Tutto è irrimediabilmente sparito, raso al suolo, forse proprio per questo De Angelis scrive che “Olimpia” esprime un tempo assoluto, cioè un tempo che contiene ogni tempo. Tutto è già accaduto, è dietro di noi, ma anche davanti a noi, racchiuso in uno spazio circolare. La poesia è lì, in un’essenza viva, nitida, pulsante, è una voce che chiama a sé i suoi figli e li accresce, “in tutto ciò che siamo stati” e facendo questo percorso a ritroso nel tempo, tocca le grandi origini della vita e della morte. Continua a leggere
 Ve ne siete andati con il viso inerte
Ve ne siete andati con il viso inerte
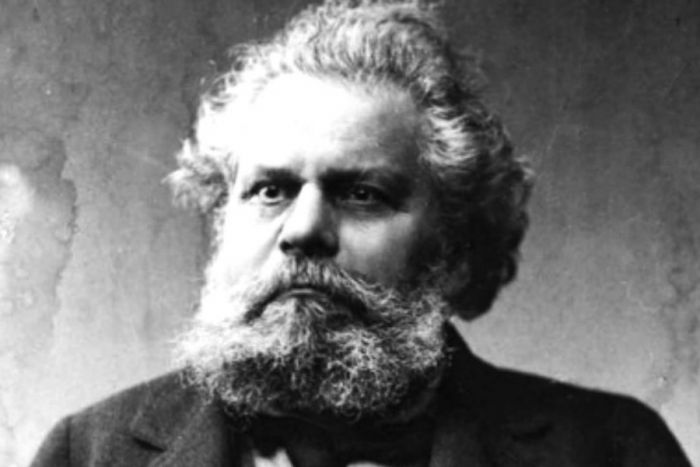

 di Fabrizio Fantoni
di Fabrizio Fantoni