
Stefano Dal Bianco
In questo libro, scritto in un ampio arco di tempo, dal 1993 al 2001, ripubblicato nella Collana Gialla di Pordenonelegge (LietoColle, 2018) Stefano Del Bianco riflette tra le cose e i luoghi della sua realtà quotidiana. “Ritorno a Planaval” è in un certo senso il diario lirico, la registrazione dei movimenti anche minimi di uomo – il poeta stesso – che si osserva esistere.
Uno dei libri di poesia più amati degli ultimi vent’anni viene qui riproposto con una ricca postfazione di Raffaella Scarpa, un intervento di poetica dell’autore e un saggio di Fernando Marchiori.
IL VETRINO
Una sera, ero in ritardo, con un asciugamano inavvertitamente, ho urtato una preziosa bottiglietta di profumo, che è caduta. I pezzi sono stati raccolti, quasi tutti in un primo momento, altri nel corso del tempo, a mano a mano diminuendo le proporzioni dei reperti. Dopo un mese in un anfratto del pavimento è comparso un vetrino trasparente, ma nessuno l’ha raccolto.
È passato altro tempo, ogni volta che entravo nel bagno
lo vedevo e mi ripromettevo: «Prima di uscire
lo raccolgo e lo butto»,
e nelle mie faccende lo tenevo d’occhio
perché non se ne andasse o scomparisse
tra le frange del tappeto o altro.
Ma il bagno libera i pensieri e al momento
di uscire dalla stanza un’altra
memoria ne prendeva il posto,
e il vetrino è rimasto e negli ultimi giorni
è diventato un’ossessione, un’ossessione
all’ultimo secondo regolarmente rimossa.
E oggi mi sono impuntato,
mi sono concentrato più di ieri
e più dell’altro ieri e ce l’ho fatta:
è stata una vittoria graduale
di una memoria su altre memorie.
Ho allungato la mano e con sorpresa
il vetro non ha opposto resistenza:
è stato docile, si è fatto raccogliere
come se per tutto questo tempo
avesse atteso me, il mio intervento.
Adesso non so se per pietà, per un senso del dovere
per rispetto o per amore l’ho posato
sul nero della scrivania, davanti a me,
e scrivendo lo contemplo e raccolgo
la sua storia di cosa legata alla mia,
uno stesso appartamento ci contiene.
Sono orgoglioso di averlo salvato
e lui risponde alla luce e manda timidi bagliori.
Ma io ci vedo dentro il firmamento e questa notte
lo metto all’ aperto e me lo guardo
perché c’è la luna, perché ritorni,
nella chiara altezza di cobalto, il cielo. Continua a leggere




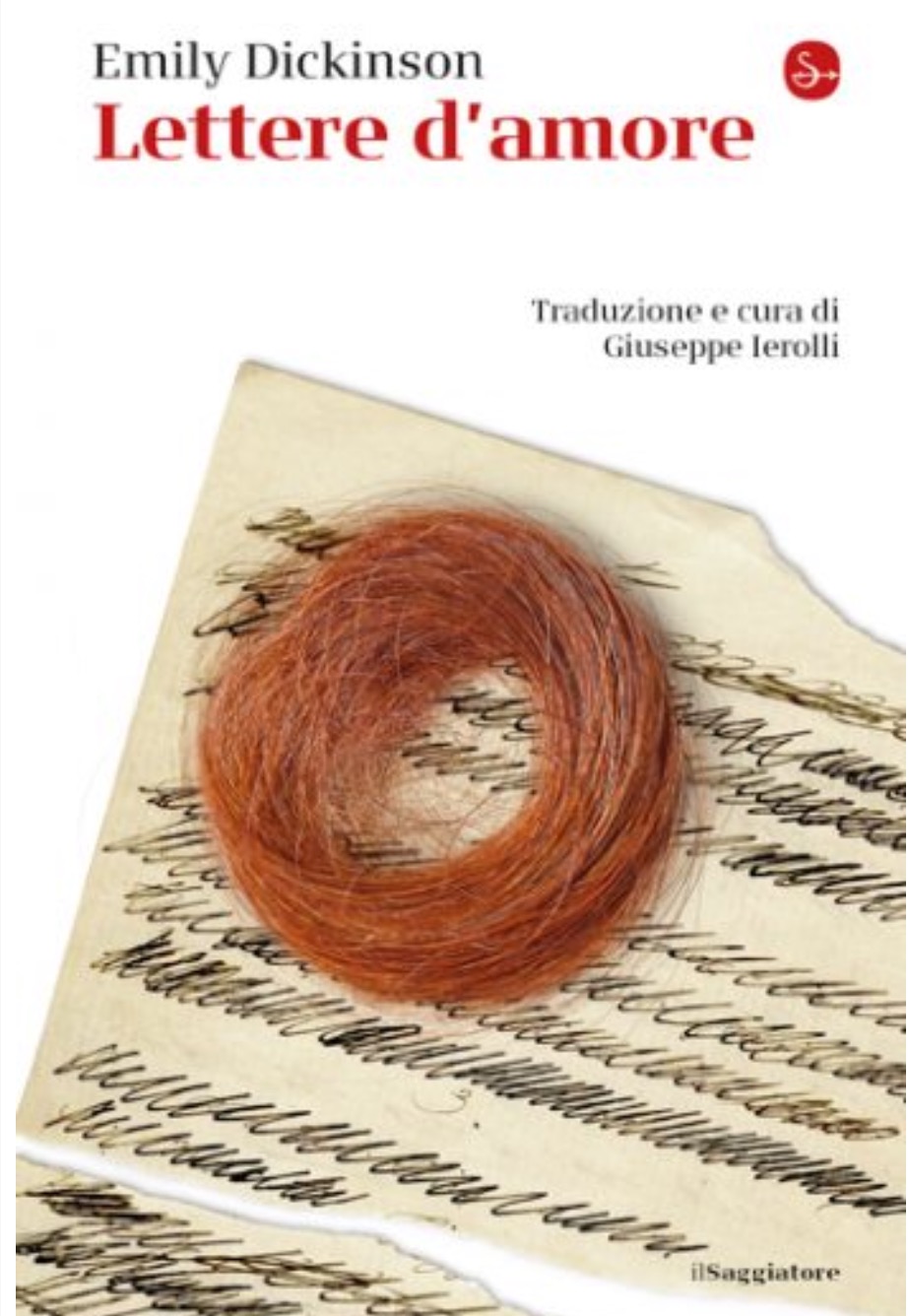 Appassionato, mistico, tenero e doloroso: nell’opera di Emily Dickinson l’amore è declinato in molte forme diverse, tutte intense, sempre liriche. Anche quando la poesia si fonde con la prosa, come in Lettere d’amore. In questa raccolta epistolare c’è tutta la vita di Emily Dickinson: le prime lettere alle amiche del cuore, i biglietti di San Valentino, le missive indirizzate all’amato giudice Lord; il rapporto duraturo con l’amica e poi cognata Susan Gilbert e la morte dei genitori; la relazione letteraria più che ventennale con Thomas Higginson; lo scambio con il «Master», un destinatario che, se mai è esistito, rimane ancora misterioso. L’amore di Emily Dickinson è tutto spirituale eppure compiutamente terreno, pervasivo di ogni aspetto della vita e sorgente di poesia. È forza motrice dell’universo, sotto il cui segno ogni vivente arriva a vedere la luce. Le Lettere d’amore di Emily Dickinson sono l’espressione pura e sublimante di questa potenza primordiale cui tutti dobbiamo e vogliamo soggiacere.
Appassionato, mistico, tenero e doloroso: nell’opera di Emily Dickinson l’amore è declinato in molte forme diverse, tutte intense, sempre liriche. Anche quando la poesia si fonde con la prosa, come in Lettere d’amore. In questa raccolta epistolare c’è tutta la vita di Emily Dickinson: le prime lettere alle amiche del cuore, i biglietti di San Valentino, le missive indirizzate all’amato giudice Lord; il rapporto duraturo con l’amica e poi cognata Susan Gilbert e la morte dei genitori; la relazione letteraria più che ventennale con Thomas Higginson; lo scambio con il «Master», un destinatario che, se mai è esistito, rimane ancora misterioso. L’amore di Emily Dickinson è tutto spirituale eppure compiutamente terreno, pervasivo di ogni aspetto della vita e sorgente di poesia. È forza motrice dell’universo, sotto il cui segno ogni vivente arriva a vedere la luce. Le Lettere d’amore di Emily Dickinson sono l’espressione pura e sublimante di questa potenza primordiale cui tutti dobbiamo e vogliamo soggiacere. 