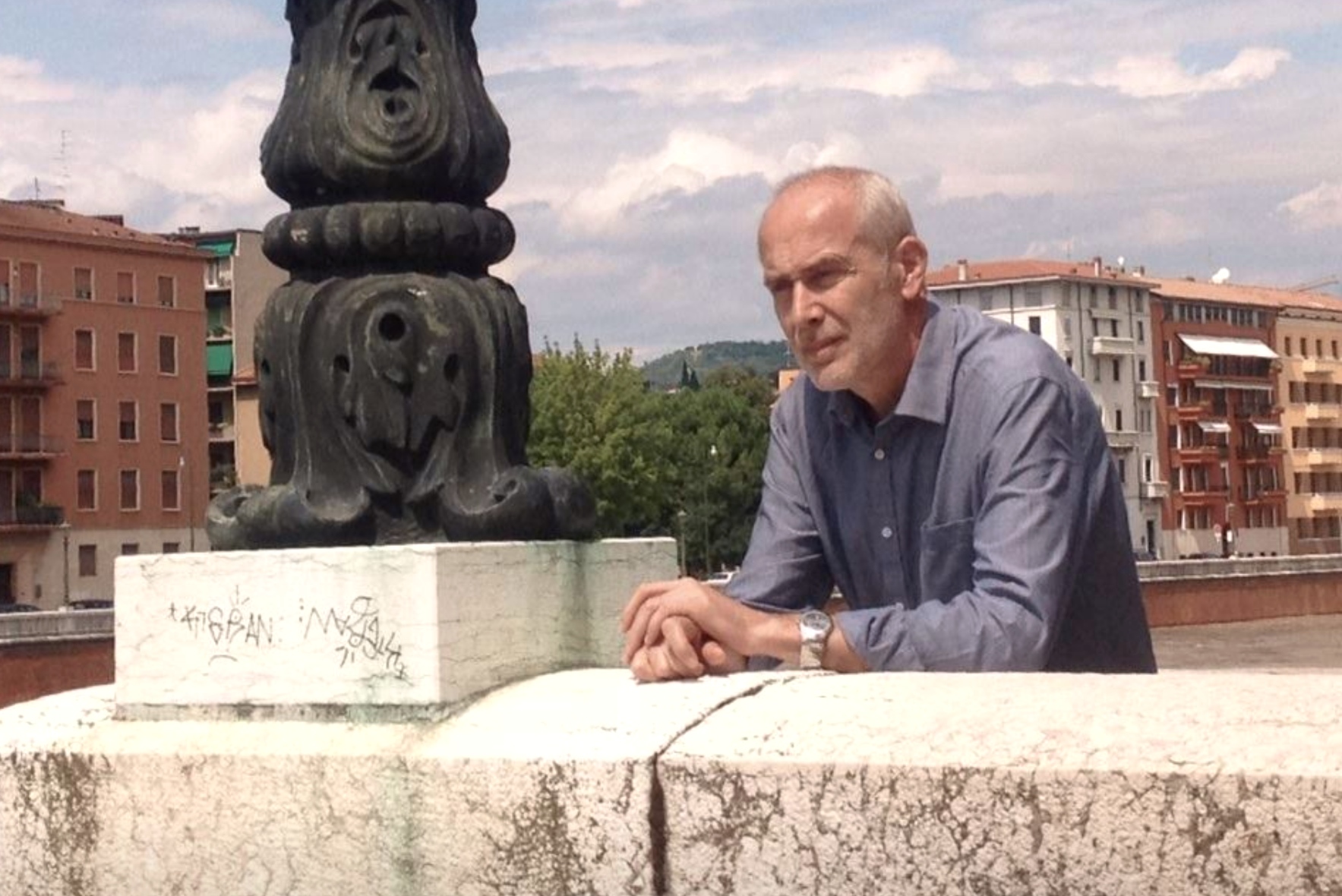
L’ultima foto di Mario Benedetti postata sul suo profilo di facebook, nell’estate 2014
di Fabrizio Fantoni
Sta solo fermo nella tosse.
Un po’ prende le mani e le mette sul comodino
per bere il bicchiere di acqua comprata,
come tanti prati guardati senza dire niente,
tante cose fatte in tutti i giorni.
Intorno ha una cassettiera con lo specchio,
due sedie scure, un armadio, l’incandescenza minuscola di una stufa.
Dei centrini, la stampa di una natività con il rametto di ulivo,
un taccuino, dei pantaloni, delle cose sue.
Davanti il cielo che è venuto insieme a lui,
gli alberi che sono venuti insieme a lui. Forse una ghiaia di giochi
e dei morti, che sono silenzio, un solo grande silenzio, un silenzio di tutto.
A volte l’acqua del Cornappo era una saliva più molle,
un respiro che scivolava sui sassi.
A volte tutto era l’uccellino del freddo disegnato sul libro di lettura
vicino a una poesia scritta in grande da imparare a memoria.
A volte niente, venire di qua a prendere il pezzo di cioccolato
e la tosse, quella maniera della luce di far tremare le cose,
gli andirivieni, il pavimento stordito dallo stare male.
La prima impressione che offre questa poesia Per mio padre, tratta da Umana gloria (Mondadori, 2004) è di sfogliare un vecchio album di fotografie, lasciato abbandonato da qualche parte , e poi ritrovato.
I paesaggi, le case, gli interni delle stanze dove si consuma l’intimità familiare, gli oggetti della vita quotidiana, si dispiegano sulla pagina come su una scena, convocati dal poeta in una dimensione fuori del tempo e del reale e si fanno, nello spazio della poesia, “fiaba” intesa come dimensione della bellezza sul punto di scomparire, della grazia per un attimo intravista e poi persa, proprio come le apparizioni trascoloranti che popolano le storie.
Si racconta che il faraone Micerino, essendo condannato dagli dèi a vivere una vita breve, decidesse di illuminare con migliaia di fiaccole i suoi palazzi e i suoi giardini in modo da trasformare le notti in giorno ed avere la percezione di vivere più a lungo.
Questa è la metafora più bella del poeta perché, del resto, cosa fa il poeta se non cercare di trattenere, quanto più possibile, quel poco che gli è dato di vivere?
Mario Benedetti, di certo, va in questa direzione, ponendosi, tuttavia, ad una “distanza”dalle cose – la distanza propria del sopravvissuto, di chi può narrare ciò che è stato prima del naufragio- che gli permette di imprimere all’oggetto della sua rievocazione un carattere simbolico che si fa specchio di un paesaggio metafisico interiore in cui l’essere umano appare costantemente sul punto di dissolversi:
“solo qui sono, nel tempo mostrato, per disperdermi” Continua a leggere

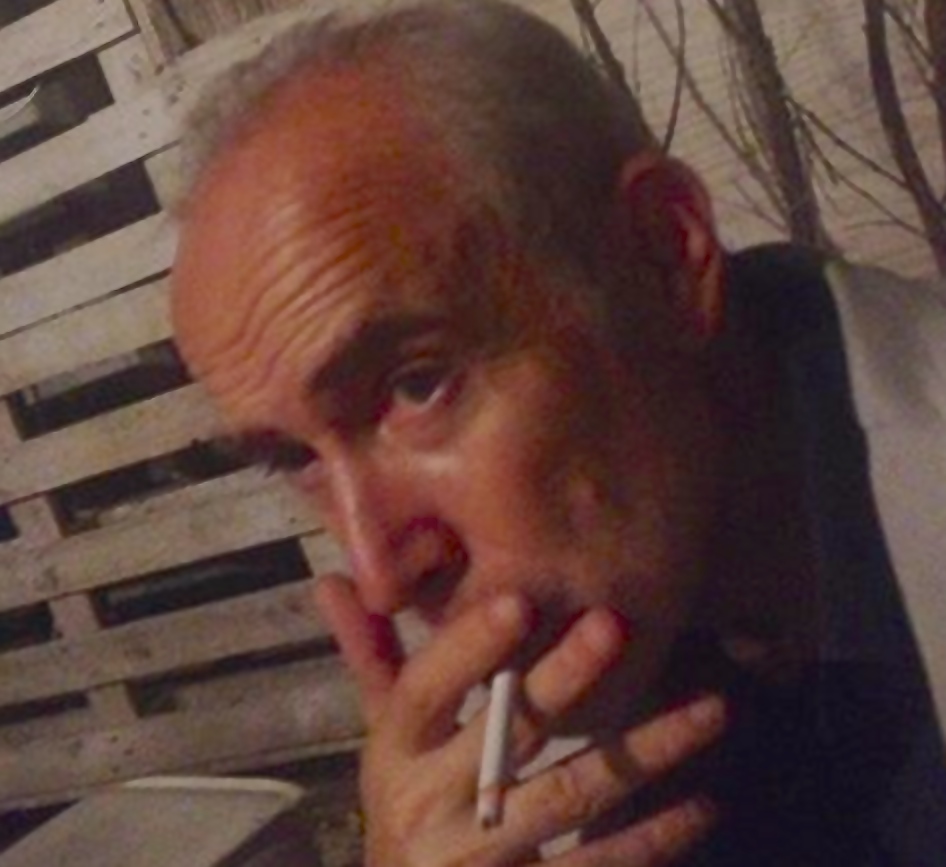
 di Elio Grasso
di Elio Grasso
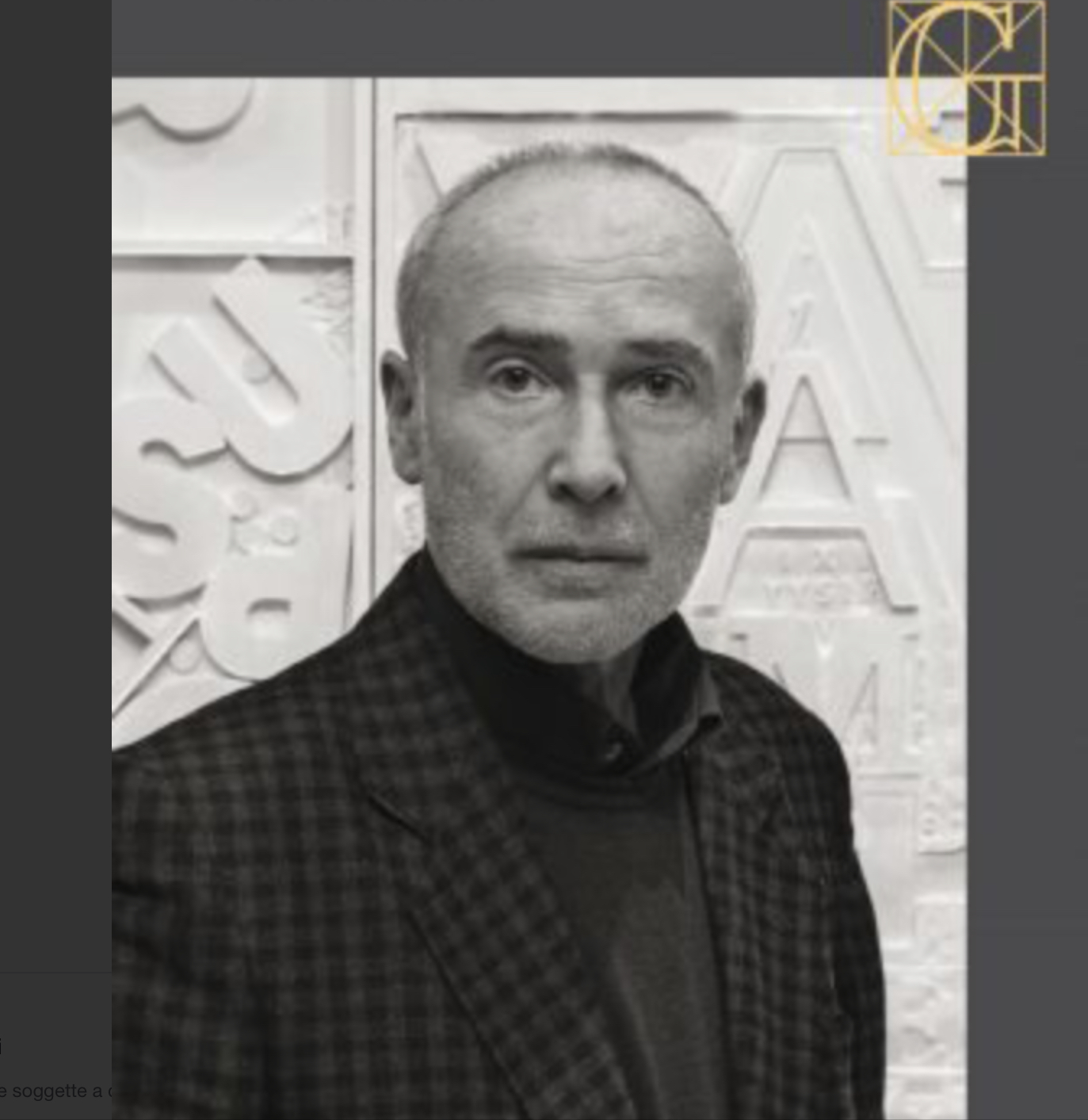 Appunti sul paesaggio in Andrea Zanzotto e Mario Benedetti
Appunti sul paesaggio in Andrea Zanzotto e Mario Benedetti