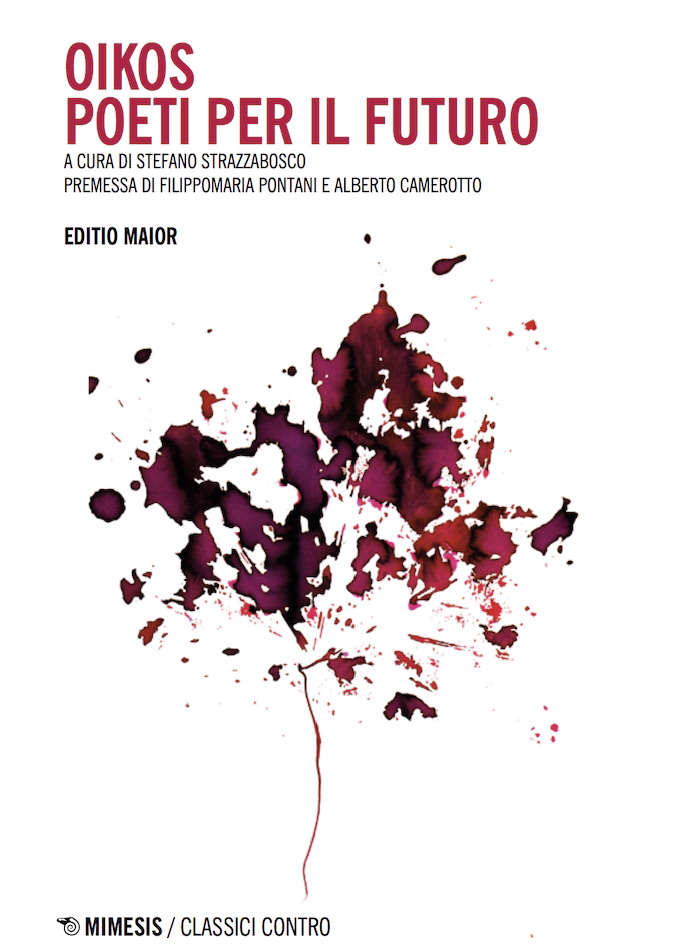 Oikos. Poeti per il futuro è un progetto poetico-civile dei Classici contro, vale a dire del gruppo di classicisti coordinati da Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani (Università Ca’ Foscari di Venezia) che ormai da anni ripercorrono i testi degli autori grecolatini per parlare delle questioni più spinose del presente (l’immigrazione, la giustizia, la bellezza, l’Europa e così via).
Oikos. Poeti per il futuro è un progetto poetico-civile dei Classici contro, vale a dire del gruppo di classicisti coordinati da Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani (Università Ca’ Foscari di Venezia) che ormai da anni ripercorrono i testi degli autori grecolatini per parlare delle questioni più spinose del presente (l’immigrazione, la giustizia, la bellezza, l’Europa e così via).
Nel 2020 e 2021, il tema dei Classici contro è appunto OIKOS: l’ambiente, la natura, cioè la nostra casa comune.
Il progetto, tra le varie iniziative in cantiere, si traduce in un’antologia contenente 150 poeti contemporanei di molti Paesi del mondo (Oikos. Poeti per il futuro, a cura di Stefano Strazzabosco, Premessa di F. Pontani e A. Camerotto, Disegni di L. De Nicolo, Mimesis/Classici Contro n. 18, Milano-Udine 2020) e in una serie di azioni, tanto in linea come in presenza – quando possibile –, che fanno dialogare i poeti con classicisti, insegnanti e studenti di vari licei italiani.
L’antologia, di cui esiste anche un’edizione minore con una selezione di 80 autori, riunisce alcune tra le voci più significative della poesia contemporanea: per fare qualche esempio, si va dal grande autore marocchino-francese Tahar Ben Jelloun, che come altri ha scritto una poesia apposta per Oikos, alla poetessa beat statunitense Anne Waldman, che dedica il suo testo (anche questo inedito e scritto per l’antologia) all’amica Patti Smith; dagli israeliani Tsuriel Assaf, Sabina Messeg, Maya Weinberg, Adi Wolfson, Elad Zeret, rappresentanti di una eco-poesia che è stata tra le prime a dedicare attenzione ai temi ambientali, alle cinesi Ming Di, Jami Xu e Xiao Xiao; dalla vietnamita Nguyen Phan Qué Mai ai messicani Homero Aridjis, David Huerta, Blanca Luz Pulido; dai colombiani Rómulo Bustos Aguirre, Juan Manuel Roca, Ángela García, Yirama Castaño Güiza, Myriam Montoya, Armando Romero al croato Drazen Katunaric, i cechi Petr Kral ed Erik Ondrejicka, il finlandese Jouni Inkala, gli svedesi Lars Gustaf Andersson e Lasse Söderberg; e ancora, dal congolese Gabriel Okoundji al giapponese Goro Takano e gli statunitensi Bill Mohr, Robin Myers, John Taylor eccetera. Continua a leggere



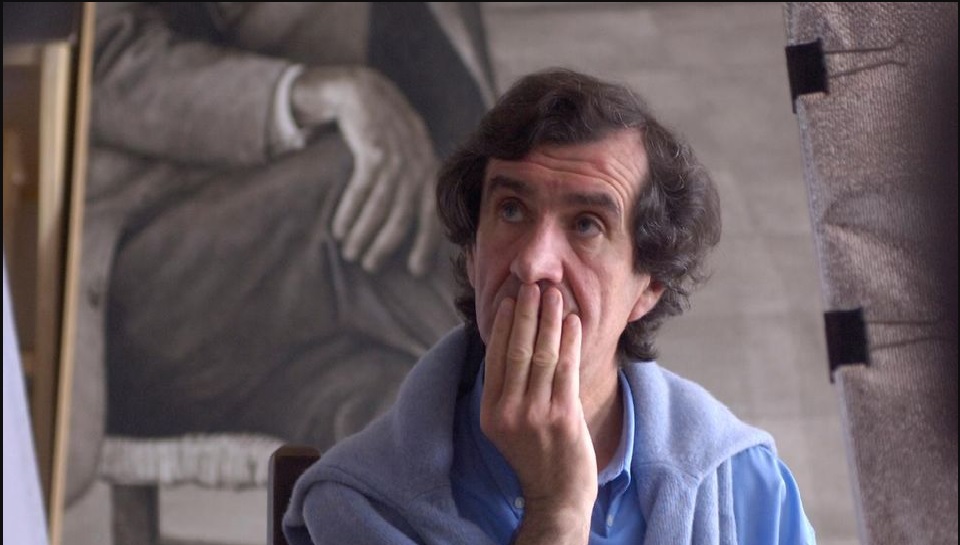 Ottave Scelte
Ottave Scelte Domani è domani,
Domani è domani, La Casa della Cultura di Milano rilancia Nella città contemporanea a partire dal 12 novembre, un nuovo ciclo di letture e incontri.
La Casa della Cultura di Milano rilancia Nella città contemporanea a partire dal 12 novembre, un nuovo ciclo di letture e incontri.