
La storica manifestazione culturale della Capitale LETTERATURE – Festival Internazionale di Roma 2021 fa parte del programma dell’Estate Romana 2021, organizzata da Zètema Progetto Cultura, torna per la sua Ventesima edizione nella cornice dello Stadio Palatino, con un format del tutto rinnovato.
Cinque serate, a cura di Andrea Cusumano e Lea Iandiorio, con la regia di Fabrizio Arcuri in cui viene declinato il tema “Leggere il mondo” grazie a poeti e scrittori e tante altre voci, non solo della letteratura e della poesia, che si esprimono su questo argomento, portando la loro esperienza e la loro interpretazione sul tema.
Concepito come uno spettacolo tra le arti, un’esperienza in cui le diverse espressioni artistiche si intrecciano in un dialogo connesso, grazie alla nuova location dello Stadio Palatino che rende lo spazio protagonista, un tutt’uno con la narrazione. In questo nuovo contesto culturale, cuore pulsante sono l’opera dei MASBEDO (duo artistico formato da Nicolò Masazza e Jacopo Bedogni) e lo spazio sonoro di Marino Formenti (indicato dal Los Angeles Times come il “Glenn Gould del XXI secolo”), danno vita ogni sera a un evento esperienziale sempre nuovo.
L’appuntamento è dal 21 al 25 luglio.
A cura dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, promosso da Roma Culture, il Festival vedrà la partecipazione di autori italiani e internazionali del calibro di Roberto Saviano, Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021, Milo De Angelis, Elisa Biagini, Carmen Maria Machado, Aixa de la Cruz e Katharina Volckmer, Gianrico Carofiglio, Roberto Alajmo, Erri De Luca, Patrick McGrath, Roberto Venturini, Muriel Barbery, Cristina Morales e Mario Desiati.
L’accesso è gratuito ma su prenotazione, essendo la capienza massima di 500 posti.
UN’ESPERIENZA LIBERATORIA DOPO IL LOCKDOWN
“Dopo questo lungo periodo passato distanti, con i nostri rapporti sociali, professionali, le nostre relazioni internazionali e familiari ridotte ad una comunicazione davanti allo schermo di un computer, abbiamo voluto sublimare questa esperienza passando da uno schermo pandemico ad uno schermo poetico” ha dichiarato Andrea Cusumano, curatore del Festival insieme a Lea Iandiorio. Che aggiunge: “Letterature è un’esperienza dove la parola si fonde con lo spazio, dove l’arte, intesa come immagine, suono, scrittura, si manifesta in un evento unico ogni sera. Gli scrittori e le scrittrici che incontreremo, in questa ventesima edizione, ci restituiranno la loro idea di come la scrittura e la letteratura possono, in questo momento di cambiamento, aiutarci a reinterpretare il nostro rapporto con gli altri, l’economia, la salute, l’ambiente. Ovvero a leggere il mondo che ci aspetta.”
Il palco è stato eliminato, in modo da dare un peso maggiore alla fisicità degli autori che saranno presenti al Festival. “E poi abbiamo voluto immergere il festival dentro l’installazione artistica, facendo innanzitutto una riflessione sullo spazio e sul luogo in cui incontrarsi finalmente in presenza– ha aggiunto Cusumano- la ‘finestra sul mondo’ proposta dai Masbedo riprende il tema di Letterature per sublimare attraverso la bellezza e la poesia il tempo che abbiamo passato davanti allo schermo. Ma stavolta, anche grazie alla letteratura, sarà un’esperienza liberatoria.”
PROGRAMMA COMPLETO

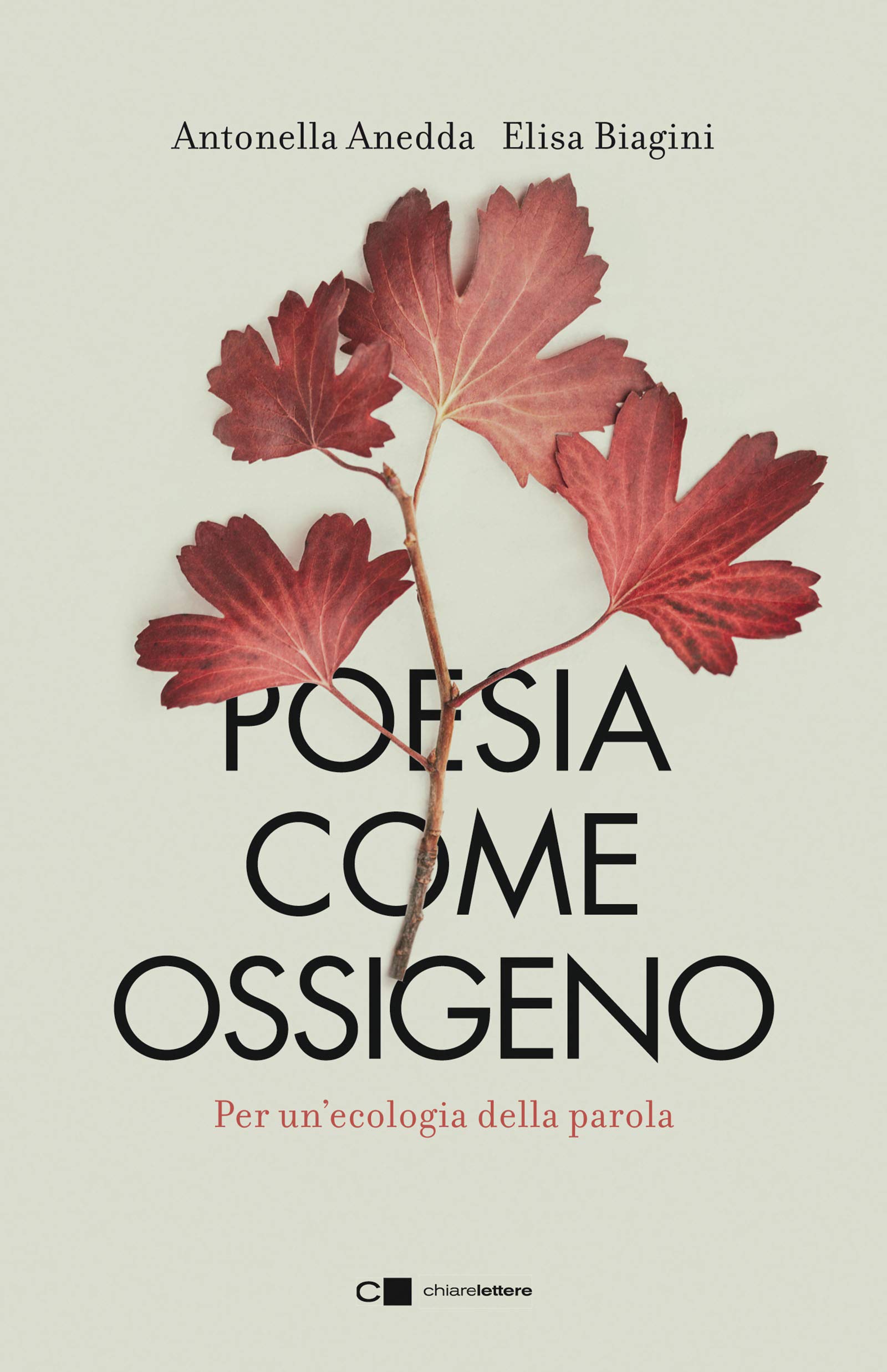
 Concetto peraltro ribadito in un altro scritto molto interessante della stessa Anedda: si tratta di un saggio poetico — sul modello di quelli di Jaccottet e Zagajewski ma punteggiato di lemmi e brevi argomenti che aumentano l’intenzione diaristica e la concertazione filosofica —, Geografie.
Concetto peraltro ribadito in un altro scritto molto interessante della stessa Anedda: si tratta di un saggio poetico — sul modello di quelli di Jaccottet e Zagajewski ma punteggiato di lemmi e brevi argomenti che aumentano l’intenzione diaristica e la concertazione filosofica —, Geografie. 

