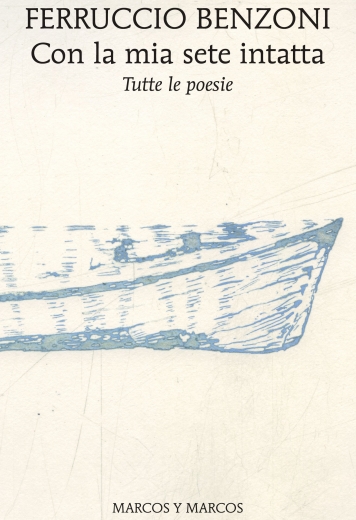Emilio Rentocchini, per gentile concessione di Giorgio Giliberti
NOTA DI LETTURA DI LUIGIA SORRENTINO
Emilio Rentocchini è un poeta grandissimo e raro. Scrive ottave in endecasillabi in un idioma sassolese, una lingua scomparsa quasi reinventata dal poeta, che sopravvive nella sua memoria, una lingua di mezzo tra il modenese e il reggiano. Véver e basta uguel a trasparir (Vivere e basta equivale a trasparire), verseggia il poeta come un menestrello, con una voce antica e ultima, e raccoglie nella forma stretta del verso, la verità più profonda: il valore della vita.
Ecco che l’aspetto del linguaggio elevato a simbolo, diventa sostanza, essenza, al di là dell’apparenza delle cose, argine al quale appigliarsi, e nella pronuncia, la lingua si fa slavina, neve che si stacca dalla montagna e scivola via.
Grazie alla pubblicazione di Lingua madre, (Incontri Editrice, Sassuolo, pp. 296, euro 14), è possibile attraversare tutta la produzione in versi di Emilio Rentocchini.
L’opera raccoglie le poesie di Otèvi (1994), Segrè (1998), Ottave (2001), Poediànt (2004), Giorni in prova (2005), Stanze di confine (2014).
Le ottave del poeta di Sassuolo sono 256, composte nell’arco di più di vent’anni in una gabbia metrica che rimanda al Boiardo e all’Ariosto, straordinari poeti della sua terra. Ogni poesia è accompagnata dalla traduzione in italiano, una variante “autosufficiente e persuasiva”, come ebbe a definirla Giovanni Giudici.
195
Véver e basta uguel a trasparir
e ander via veirgin, soul chi gh’la fa a fer
dla sô realtê un sìmbol al sa sintir
d’esr esistî; l’è deintr al spec mea cer,
panê, ch’i armàgnen lè i noster respir
mai pers: nueter, segrét, in al penser
di eter. Palida luna al dopmesdè
t’ê la risposta in me ai dè d’in dè.
Vivere e basta equivale a trasparire
e andarsene vergini, solo chi fa
della sua realtà un simbolo sente
di essere stato; è nello specchio
appannato che restano i nostri respiri
non perduti: noi, segreti, nel pensiero
degli altri. Pallida luna del pomeriggio
sei la risposta, in me, ai giorni comuni.
199
Al fiour, òreb e mót, al seint chi al guerda,
as lancia incountra a l’aria a l’incontrari
léber da la sô tera ed gera o merda
e al sa d’eser dla lus dal lucernari
fiurand, ed véder, anch per chi an le guerda.
Se un po’, dre grot seinsa n’intestatari
do tótt l’è melta e gresta, as volta al clour
d’un pisalet pulvreint, mai piò dulour.
Il fiore, cieco e muto, sente chi l’osserva,
si slancia incontro all’aria all’incontrario
liberato dal terreno di ghiaia o sterco
e sa di essere della stessa luce del lucernaio
fiorendo, di vetro, pure per chi non lo guarda.
Se poi qualcuno, lungo dirupi privi di intestatario
dove tutto è argilla e crosta, si volge al colore
di un piscialetto polveroso, mai più dolore.
da: Lingua madre, (Incontri Editrice, Sassuolo, 2016) Continua a leggere