
Nikos Kazantzakis
RECENSIONE DI ALBERTO FRACCACRETA
Nel 1956 il Premio Nobel per la Letteratura è assegnato ad Albert Camus, che diviene il più giovane detentore dell’ambita onorificenza. Lo scrittore francese di origine algerina, con eleganza d’antan, invia un telegramma al più anziano collega : «Voi l’avreste meritato cento volte di più». Di fatti — si saprà in seguito — in quella tornata l’autore neogreco arrivò secondo, fortemente penalizzato per altro dal suo stesso paese che «si mobilita, non già per sostenerlo, bensì perché non gli venga assolutamente assegnato il prestigioso riconoscimento». È quanto scrive Nicola Crocetti nell’informatissima introduzione all’Odissea di Kazantzakis, opus magnum del poeta cretese, diviso in 24 canti — come le lettere dell’alfabeto greco — e composto dal «numero sacro» di 33.333 versi (5.527 in più dei poemi omerici messi insieme!) in decaeptasillabi, una sorta di metro barbaro che tenta di ricreare il ritmo degli esametri classici.
L’Odissea costa al suo versatile artefice 13 anni e mezzo di lavoro (dal 1925 al 1938), 7 stesure autografe, 240.000 versi redatti a mano, con un esercizio di scrittura che arriva anche a 200 decaeptasillabi quotidiani e con la presenza di 7.500 athisàvrista, ossia parole introvabili sui vocabolari, trascritte personalmente sul taccuino e recepite nelle isole Cicladi, espressione della cosiddetta dimotikì, la lingua popolare.
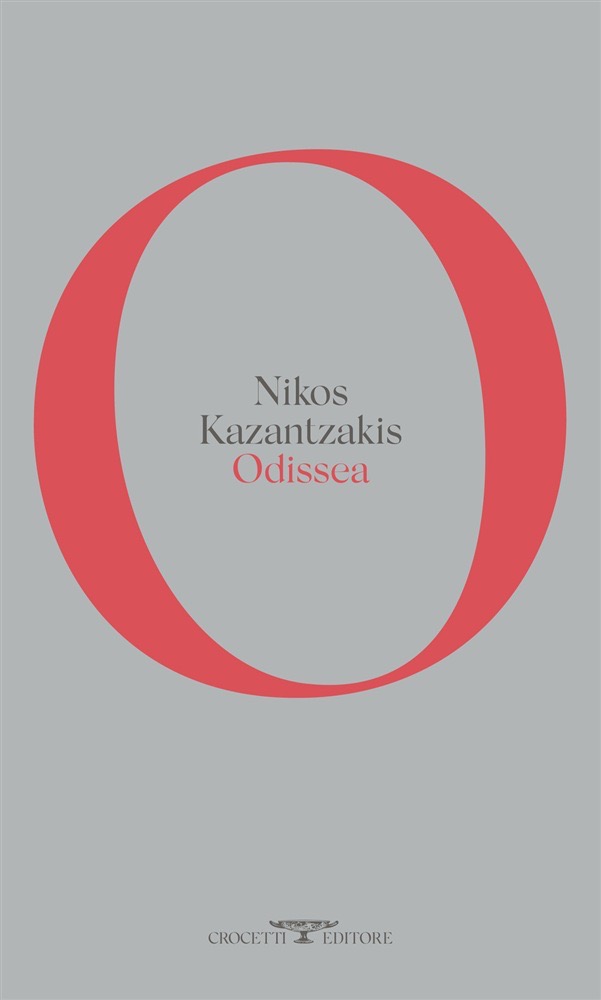
Ma il multiforme ingegno di Kazantzakis non era nuovo a imprese di questo genere: fu traduttore infaticabile dell’Iliade, della Divina Commedia, di Shakespeare, del Faust di Goethe e anche di Bergson, Darwin e Nietzsche, autore di drammi, opere di poesie, romanzi (si pensi a Zorba il greco, Il poverello di Dio e L’ultima tentazione, portata al cinema da Scorsese nel 1988). La sua «sconfinata fantasia» e la «prodigiosa capacità lavorativa» divengono presto leggendarie. Siamo, infatti, dinanzi alla vastità di un’intelligenza come poche nell’intero Novecento, uno scrittore profondamente incompreso a causa dei suoi rimpasti filosofici e ideologici (un eclettismo à la Posidonio), di quell’ibridismo sincretico che è alla base della sua stessa concezione religiosa.
La parola d’ordine dei libri di Kazantzakis è forse contaminatio, ossia quella tecnica di fusione di registri stilistici e visioni spirituali che ha come risultante un condensato caleidoscopico: non stupisce allora che il sequel dell’Odissea omerica, fluvialmente composta dal poeta di Iraklio classe 1883, funzioni come una «sintesi di tremila anni di storia del pensiero» e appaiano nel corso del poema Gesù (il Pescatore Gentile), Don Chisciotte (Capitan Uno), Buddha e addirittura Trotsky, Lenin e Stalin sotto mentite spoglie.
Ma qual è il significato profondo del testo? «Tutta l’opera di Kazantzakis — scrive Crocetti che ha lavorato indefessamente alla traduzione per quasi un decennio, producendo per altro una versione armoniosa e naturale, premiata recentemente dai lettori del Corriere della Sera —, e l’Odissea in particolare, è animata dalla lotta del bene contro il male. Secondo l’autore cretese, il compito di un poeta e di uno scrittore non dev’essere la ricerca del bello, ma la verità; non la creazione di un’utopia, ma la trasformazione dell’utopia in realtà». Dietro alle ottime aspirazioni si cela però un «pessimismo eroico» e il tentativo ulissiaco di fondare una Città ideale fallisce con l’esaurimento delle forze tensive.
L’Odissea, monstrum letterario che richiama a sé in un unico calderone lo scibile, racconta l’evoluzione stessa dell’umanità, il desiderio di grandezza, la sete inesausta di avventure e lo scontro con il trascendente (come Giacobbe e l’angelo di Dio), lo smisurato anelito dell’uomo non soltanto verso la conoscenza — aspetto che Kazantzakis ha mutuato dall’Ulisse dantesco —, ma soprattutto verso un principio di pienezza e di pace, già ravvisabile nelle prime battute dell’epos (Proemio, vv. 1-3): «Sole, grande astro orientale, berretto d’oro della mente,/ che amo portare di traverso, ho voglia di giocare,/ perché gioiscano i cuori finché siamo entrambi vivi». Le trappole logiche e i paradossi insiti nella poesia di Kazantzakis, persino nell’impurità linguistica, sintattica e ortografica, coincidono con le misticheggianti antinomie del suo pensiero, con il suo immaginare Dio ostaggio d’amore dell’uomo.
Magnifico è l’episodio in cui la Morte si addormenta e sogna la vita (canto VI, vv. 1265-1292): «Dorme la Morte, e sogna che esistano uomini vivi,/ che sulla terra s’innalzino case, palazzi e regni,/ che sorgano giardini fioriti, e che alla loro ombra/ passeggino donne nobili e cantino le schiave».



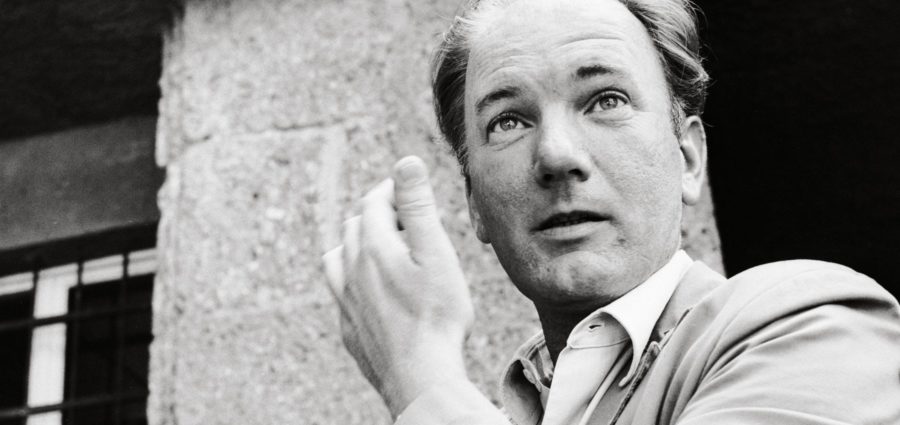 COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA
COMMENTO DI ALBERTO FRACCACRETA
 In occasione della imminente presentazione a Pordenonelegge (giovedì 19 settembre) della nuova edizione di
In occasione della imminente presentazione a Pordenonelegge (giovedì 19 settembre) della nuova edizione di