
NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA
Il saggio critico che il giovane studioso Michele Cencio ha dedicato alla figura di Mario Luzi, Un luogo della mente. Teatro e tragico, prende in considerazione non soltanto l’opera drammaturgica del poeta fiorentino, ma più approfonditamente il suo itinerario esistenziale, segnato da una seria riflessione «sul senso del male e del tragico nell’uomo contemporaneo».
Luzi approda al teatro nel momento in cui si accorge dell’inesauribile dialettica dell’essere e dell’«incessante metamorfosi» che colma il mondo, sostanzia le cose. Complice la conoscenza degli scritti di Teilhard de Chardin (il «gesuita moderno» di Montale), la parola luziana si spoglia della purità dura e trasparente propria dell’ermetismo fiorentino degli anni ’30 e ’40 per entrare nel patibolare agone delle vicende umane, a partire grossomodo da Nel magma (1963), silloge di snodo, se non addirittura di ripensamento delle strutture formali e contenutistiche fino ad allora utilizzate.
Scrive Cencio: «Tutta la critica è unanime nel ritenere che dagli anni Sessanta in poi la produzione poetica luziana andrà di pari passo con quella teatrale in maniera quasi inscindibile favorendosi perfino l’innescare ulteriori prospettive. Non sussiste, perciò, l’idea di un Luzi poeta e uno drammaturgo come fossero due persone distinte, poiché la ricerca è la stessa così da poterla leggere in filigrana da entrambe le parti». Insomma, il teatro è un’altra morphé (un’altra faccia) della lirica. O meglio: il teatro, precipuamente in versi, permette di lasciar cogliere con maggiore precisione all’autore e al lettore la «strada tortuosa» del divenire, la sua capitale tensione all’Uno.
Con l’«uccisione del sacro» il poeta deve scovare il santo, ossia il ripristino del «giardino delle delizie» oltre il «cammino purgatoriale» della storia: esso va rintracciato dunque in quel «luogo della mente» grazie al quale si supera l’«appiattimento» e la «stasi» fornite dalla sofferenza, che è espressa artisticamente con la modulazione della tragedia (i modelli principali, in tale direzione, sono Shakespeare e Racine). Luzi incontra il genere impossibile par excellence della modernità, la tragedia appunto, per riannodarsi all’anelito divino che non può essere eluso dall’uomo, causa ed effetto dei suoi stessi desideri. Continua a leggere

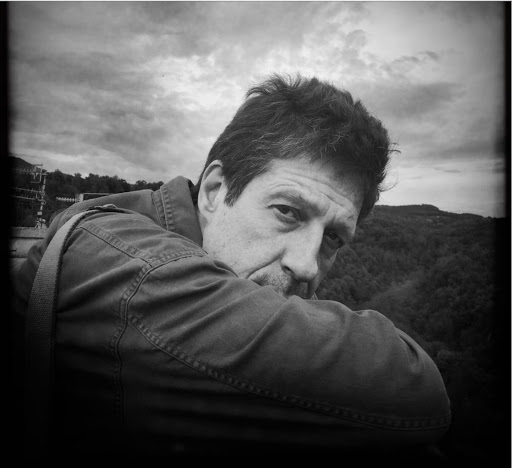

 E io chi sono?
E io chi sono?

