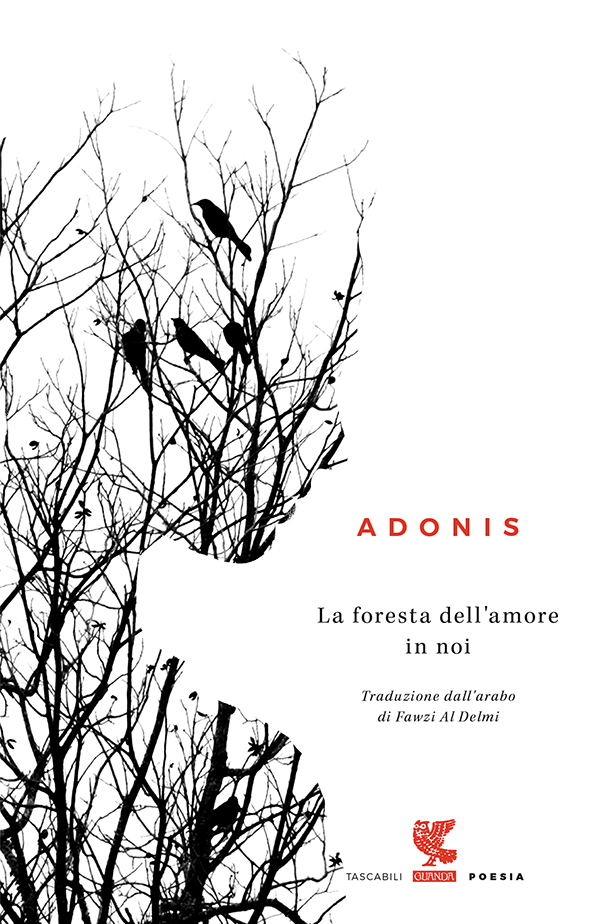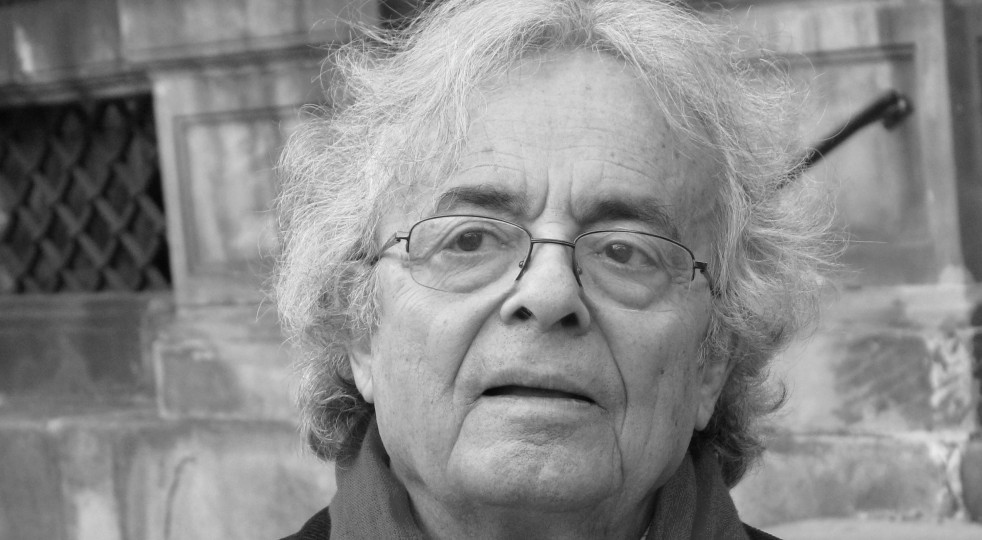Nato a Roma nel 1880 e scomparso precocemente nel 1918 a causa dell’influenza “spagnola” che lo aveva trovato già debilitato in seguito alle ferite riportate in guerra, Guillaume Apollinaire è stato uno dei protagonisti assoluti della poesia della sua epoca. Maestro indiscusso delle avanguardie del primo Novecento, anche nella sua poesia perseguì gli ideali delle nuove estetiche. Tuttavia sarebbe improprio e fuorviante limitare la sua opera a questa, pur fondamentale, ricerca espressiva. Apollinaire, in realtà, fu anche un poeta ben consapevole della tradizione letteraria; la sua adesione ai motivi di una modernità che appariva sempre più dirompente – e che avrebbe trovato nei suoi “Calligrammes” (1913-1916, apparsi nel 1918) una delle opere esemplari della nuova poesia – non gli impedì di continuare a coltivare il senso profondissimo della parola, che già si ritrova nei suoi esordi poetici (dal “Bestiario” a “Alcools”), un lascito della grande poesia simbolista che lo aveva preceduto. Apollinaire fu anche un grande poeta d’amore, nel senso più profondo del termine; nella sua poesia, l’amore più carnale e l’amore spirituale si fondono in modo originale, dando vita ad alcune delle più belle poesie d’amore del Novecento. Colpisce, in particolare, come ben chiarisce Fabio Scotto nella sua prefazione, «la sovrapposizione del tema amoroso con il tema bellico»: la fascinazione esercitata da quest’ultimo sul poeta francese, alla pari di diversi altri scrittori dell’epoca alle prese con il primo immane conflitto mondiale, è tanto forte da penetrare nella lingua stessa della poesia, «materiale poetico al servizio dell’amore e della mitologia personale del poeta».
Fondendo il tono malinconico della canzone e della ballata alle movenze più irregolari del verso libero, ma spesso rimato e sempre musicale, Apollinaire dà prova in questo libro di una straordinaria vitalità che fa dell’amore, vissuto come passione sentimentale e ossessione erotica, una forza, un appiglio di salvezza tra gli scoppi delle bombe del primo conflitto mondiale nel quale combatté sul fronte, un’estrema speranza nella possibilità che la vita prevalga sulla morte oltre ogni umano limite.
Con questa antologia, curata da uno dei massimi esperti e traduttori di poesia francese, Fabio Scotto (poeta egli stesso e curatore, tra l’altro, del recente ‘Meridiano’ Mondadori
dedicato a Yves Bonnefoy) continuiamo la pubblicazione delle grandi raccolte d’amore dei più grandi poeti del Novecento, che già ha avuto tanto successo con le analoghe opere di Neruda, García Lorca, Salinas, Rilke, Kavafis, Cvetaeva, Pessoa e altri.
Guillaume Apollinaire, “Poesie per Lou” Passigli Poesia, a cura di Fabio Scotto, 2017



 di Claude Debon
di Claude Debon