
Amelia Rosselli, Credits ph. Dino Ignani
di GIUSEPPE MARTELLA
L’ipotesi che avanzo in quanto segue, con la massima cautela poiché non sono un italianista di professione, è che la lettura delle poesie giovanili in inglese di Amelia Rosselli che appaiono in Sleep ci offra una chiave preziosa per comprendere la peculiarità e il fascino di tutta la sua produzione.
Questi testi appaiono infatti di una inattualità e di una pregnanza sorprendenti, come fossero estratti dalla matrice del tempo, dall’irripetibile età dell’oro della letteratura inglese, fra Cinque e Seicento, fra Shakespeare e John Donne. Per essere poi proiettati sulla tragedia storica del nostro Novecento, sugli incubi kafkiani di questo secolo breve segnato dalla Shoah e da due guerre mondiali.
Incubi vissuti sulla propria pelle e divenuti saga familiare della poetessa, traumi psicosomatici che ne hanno segnato insieme lo spaesamento esistenziale e la Stimmung poetica, che si può definire come un consapevole delirio prolungato o anche una meditata atonale “arte della fuga” che si arresterà come è noto con un taglio secco come quello dell’ascia che apre la luminosa sequenza di Sleep: “Pray be away/ sang the hatchet as it cut slittingly/ purpled with blood. The earth is made nearly/ round , and fuel is burnt every day of our lives.” “Prego vattene/ cantò l’accetta mentre acuminata tagliava/ imporporandosi di sangue. La terra è fatta quasi/ tonda, e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita.” (8)
Fatta questa premessa, voglio sviluppare l’ipotesi che tutta l’opera di Rosselli si possa intendere come traduzione da una lingua madre fantasmatica. Lingua madre intendo, l’inglese, perché sua madre era inglese e le avrà probabilmente sussurrato suoni e parole di questa lingua nella prima infanzia; in quella fase precoce di formazione psichica che Lacan chiama “stadio dello specchio” e che si trova mirabilmente condensata nell’antichissimo mito del bambino Dioniso sbranato dai Titani mentre una nutrice gli regge uno specchio in cui egli può vedere i suoi assassini, coi volti coperti di maschere bianche identiche alla sua, circondarlo danzando per farlo infine a pezzi.
E’ il mito della nascita della coscienza individuale dalla nuda vita, dal sentirsi tutt’uno col copro della madre. La lingua materna (fonica, tattile e gestuale) ci offre perciò l’imprinting originario, il sostrato su cui si innesteranno tutte le lingue in seguito acquisite.
I suoi connotati di brusio farfugliante, cantilena, voce-corpo appassionata che detta precocemente la metrica del linguaggio come casa dell’essere, insistendo per essere rimembrata all’occorrenza come ciò che può mutare l’imperativo della legge in un gesto di perdono, appaiono tra le righe di questo mirabile ringraziamento in Sleep: “Pardon in the shape of mother with/ her pale lipstick sticks out/ its tongue at me…And thrice she shifted rule/ into comfort…lisping the three-hatched gum-stuck hole of/ a home: your teats, your mother-/ attitude, your smallest worms, giants/ in the passion.” “Perdono in forma di madre con/ il suo rossetto rosa pallido mi caccia fuori/ la lingua…E tre volte mutò la regola/ in conforto…sondando il campo, farfugliando quel/ buco di casa a tre botole e appiccicato con la/ colla: i tuoi capezzoli, il tuo atteggiamento/ di madre, i tuoi più piccoli vermi, giganti/ nella passione.” (160)
Lingua fantasmatica, però, nel caso della Rosselli, perché la prima parte della sua infanzia fu spesa a Parigi e dunque francese fu il contesto sociale in cui crebbe fino al tragico momento dell’assassinio del padre per mano di sicari fascisti, quando lei aveva sette anni, e dell’inizio delle sue peregrinazioni prima in Inghilterra, poi in Nord America e infine in Italia: della sua “Fuga di morte” (Todesfuge: Celan) fra le lingue del mondo.
In tali peregrinazioni, alcuni anni a suo dire relativamente sereni dell’adolescenza, li trascorse negli Stati Uniti, proprio accanto alla madre, ed è lì che probabilmente la lingua inglese deve avere riaffermato il suo primato poetico nell’espressione di un vissuto travagliato, gettando i semi della splendida fioritura che pochi anni appresso si sarebbe manifestata nelle prime liriche di Sleep (1953), che costituiscono come il preludio di quel lungo sonno-sogno cui avrebbe poi in seguito costantemente anelato come balsamo di una insopportabile tensione psichica, quale appare già in Variazioni belliche (1964) e che sarebbe sfociata infine nella vera e propria psicosi paranoide attestata da Serie Ospedaliera (1969).
In ogni caso è evidente che l’italiano viene buon terzo fra le lingue correntemente parlate dalla poetessa, manifestando infatti quelle improprietà e idiosincrasie, inciampi e giri di frasi inconsueti, che non sfuggono all’orecchio di un parlante nativo e che Pasolini, al momento della pubblicazione sul Menabò delle prime poesie che sarebbero confluite in Variazioni belliche, ebbe a chiamare i “lapsus” caratteristici del suo dettato poetico.
Il mio assunto è qui che l’italiano sia per Rosselli una lingua d’arrivo in cui ella inconsciamente traduce il dettato fantasmatico della madrelingua inglese. Se è vero infatti che la poesia costituisce una lingua di secondo grado, elaborata a partire dalla lingua ordinaria, così come sostiene Jurij Lotman, ciò accade in Rosselli in modo del tutto peculiare. Ed è in quest’ottica che va compreso anche l’interesse della poetessa per la musica atonale, come quella in cui sentiva di poter conseguire quella “emancipazione delle dissonanze” che non sono per lei solo di carattere psichico ma anche eminentemente linguistico, in quanto la prosodia dell’italiano in cui scelse di scrivere è radicalmente diversa da quella dell’inglese, dove per esempio l’enjambement suona molto più naturale almeno fino dai tempi di Shakespeare. Sicché ciò che può sembrare sperimentale nella nostra lingua poetica non è spesso che la norma in quella inglese. L’insistita ricerca dell’enjambement, quel suo andare a capo su particelle enclitiche o sincategorematiche, è un tratto ben noto della versificazione di Rosselli che corrobora questa ipotesi lettura. Continua a leggere



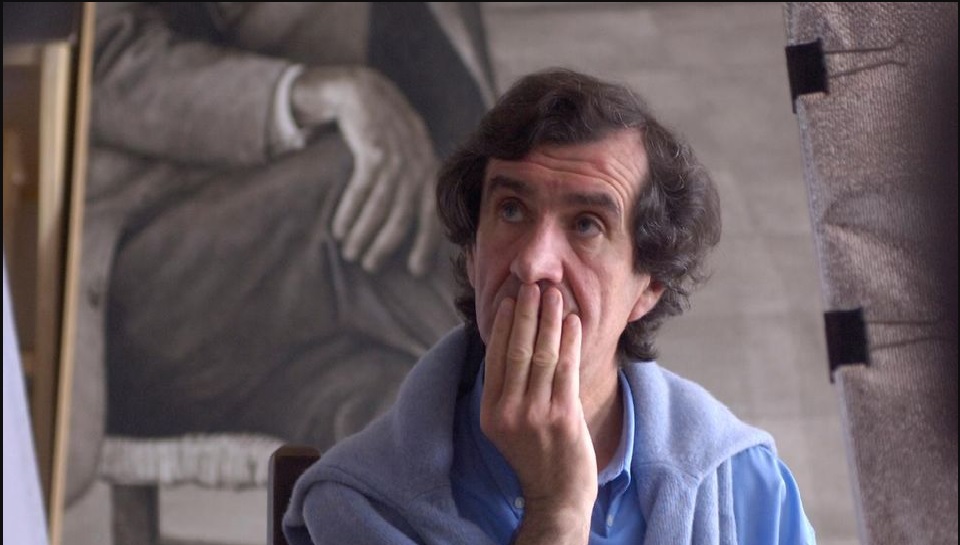 Ottave Scelte
Ottave Scelte

