
Alessandro Bellasio
NELL’AMBRA
Sepolti
sotto queste bende, dove
il nostro odio
tende il filo
e si fa pensiero, verklärte Nacht
di un mercurio strano
che ci divora con i suoi granelli, una
pioggia
leggera e già inalata, che anche tu
misurasti a morte con il tuo respiro:
sei nell’ambra.
«Due grammi
di astinenza mutano
la mente in una torcia, scavano
con unghie vuote
dentro il sonno, e tu
sotterrato il lume
ti scopri da te stesso arato».
Gli occhi, talvolta, hanno mani,
entrano nei faggi
radunandone i magneti
mappano
la struttura del vento.
Una vertigine, perenne,
scendendo dalla macchina
spegne i fari, avvicinandosi
con un solo passo
mi sussurra
Non avrò
in questa vita mai
altra gioia
all’infuori di te
LITIO
Un luogo azzerato è l’ora
dove abbiamo respirato cenere, la
polvere, finissima,
di queste esalazioni
tra cui vivremo piano e cancellati… Avvolti
nella strana calma
di un sussulto, dove le sostanze
agiscono radiali, diventano sentenza
dipinta e improvvisa
nello stridio di noi: ecco,
da un alto giorno, venirci incontro
i nostri sensi
inginocchiàti, dentro il niente,
nei patriarchi – qui,
riversi sui giornali,
dove capiamo a stento il nostro esistere,
l’interludio, perenne,
di notizie e scorie
che vi crivellano civili
con i kalashnikov, gli F16.
Scocca
da lontano questo colpo, e
si alza sopra i legni
dove sbatte respirando
nel niente degli uomini, mentre
un urlo
pende dal soffitto, sempre
più preciso sempre
più vicino, squarciandosi la gota… Altri
cieli, poi, lunghissime
incursioni dentro la radice,
tra le raffiche – il soffio
di nessun ossigeno
in volo verso il paradiso, quando
punta il freddo
che vive nelle docce, l’attimo
che vi attraversa
senza generarsi, fino
al giorno del giudizio,
finché sia l’ergastolo
di ogni cellula e dei secoli
e l’universo torni
nel suo principio immobile.
Estratti da “Monade“, di Alessandro Bellasio (L’arcolaio, 2021)


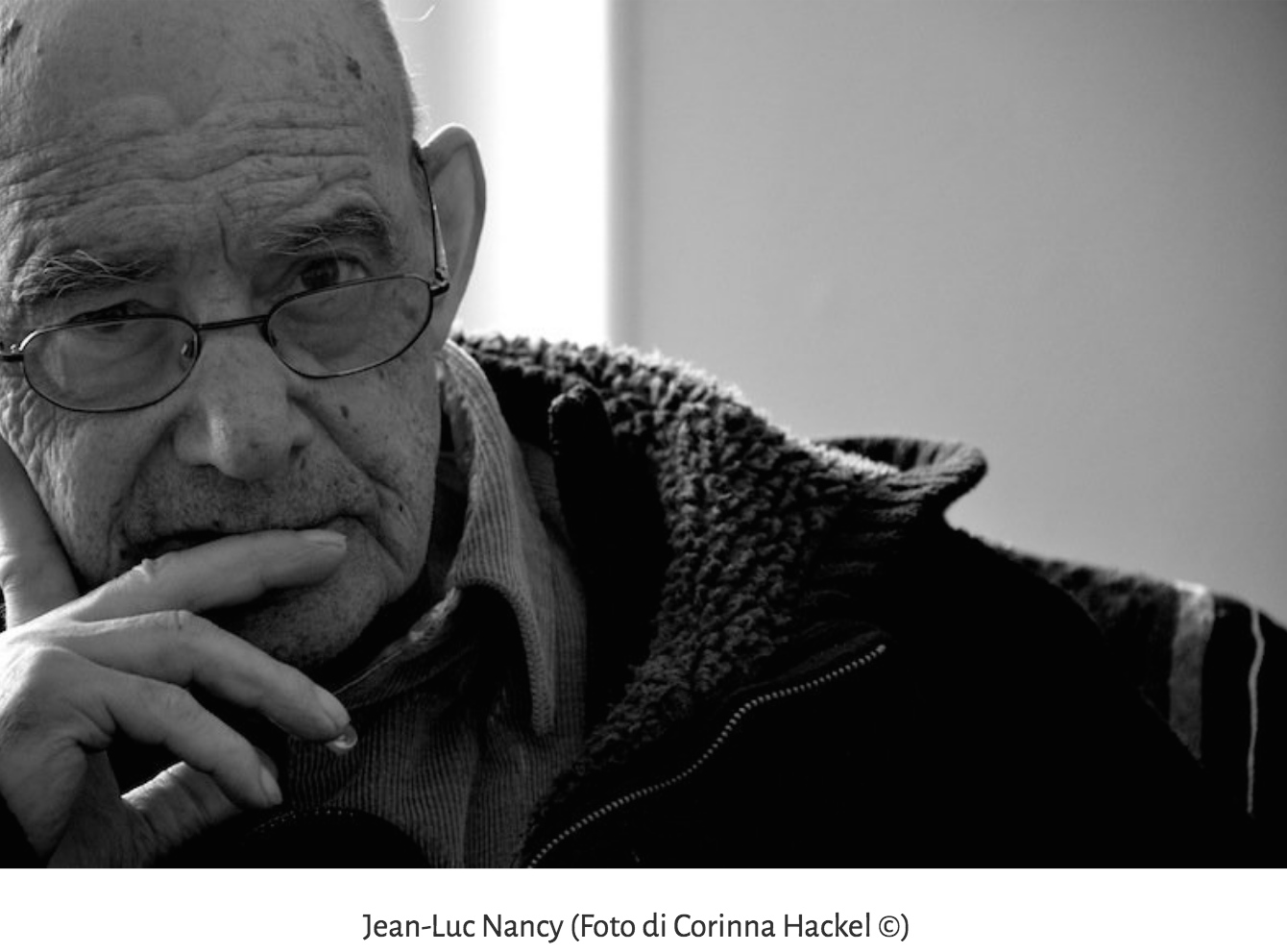



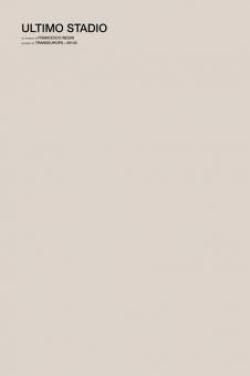 emerge è così un ritratto fedele della velocità (e voracità) anfetaminica con cui si è obbligati a esistere e estinguersi nell’epoca dell’ipercapitalismo planetario, ridotti a materiali di scarto prima ancora di essere entrati nel ciclo produttivo, e condannati comunque e da sempre a una vita larvale. D’altro canto, la decisione preliminare di accostarsi mimeticamente all’oggetto del proprio furore, nel tentativo di destrutturarlo dall’interno, accentuandone al massimo le linee di faglia e esasperandone le tensioni oppositive, trova riscontro in una lingua e in una sintassi più travolte che stravolte, in un cozzare e deflagrare dei segni che lascia inviolato il codice che li governa, nel tentativo (impossibile?) di batterlo sul suo stesso terreno, svelandone tutta l’ipocrisia e il nichilismo di fondo. Non poco, perché nel panorama (non solamente nostrano) di sempre più soffocante omologazione letteraria, culturale, esistenziale, il gesto di sfida e la vitalità tachicardica del romanzo di Negri rappresentano una vera boccata di ossigeno per chi non si accontenta della paccottiglia concertata a tavolino che, sempre più disinvoltamente e impunemente, viene spacciata per letteratura.
emerge è così un ritratto fedele della velocità (e voracità) anfetaminica con cui si è obbligati a esistere e estinguersi nell’epoca dell’ipercapitalismo planetario, ridotti a materiali di scarto prima ancora di essere entrati nel ciclo produttivo, e condannati comunque e da sempre a una vita larvale. D’altro canto, la decisione preliminare di accostarsi mimeticamente all’oggetto del proprio furore, nel tentativo di destrutturarlo dall’interno, accentuandone al massimo le linee di faglia e esasperandone le tensioni oppositive, trova riscontro in una lingua e in una sintassi più travolte che stravolte, in un cozzare e deflagrare dei segni che lascia inviolato il codice che li governa, nel tentativo (impossibile?) di batterlo sul suo stesso terreno, svelandone tutta l’ipocrisia e il nichilismo di fondo. Non poco, perché nel panorama (non solamente nostrano) di sempre più soffocante omologazione letteraria, culturale, esistenziale, il gesto di sfida e la vitalità tachicardica del romanzo di Negri rappresentano una vera boccata di ossigeno per chi non si accontenta della paccottiglia concertata a tavolino che, sempre più disinvoltamente e impunemente, viene spacciata per letteratura.