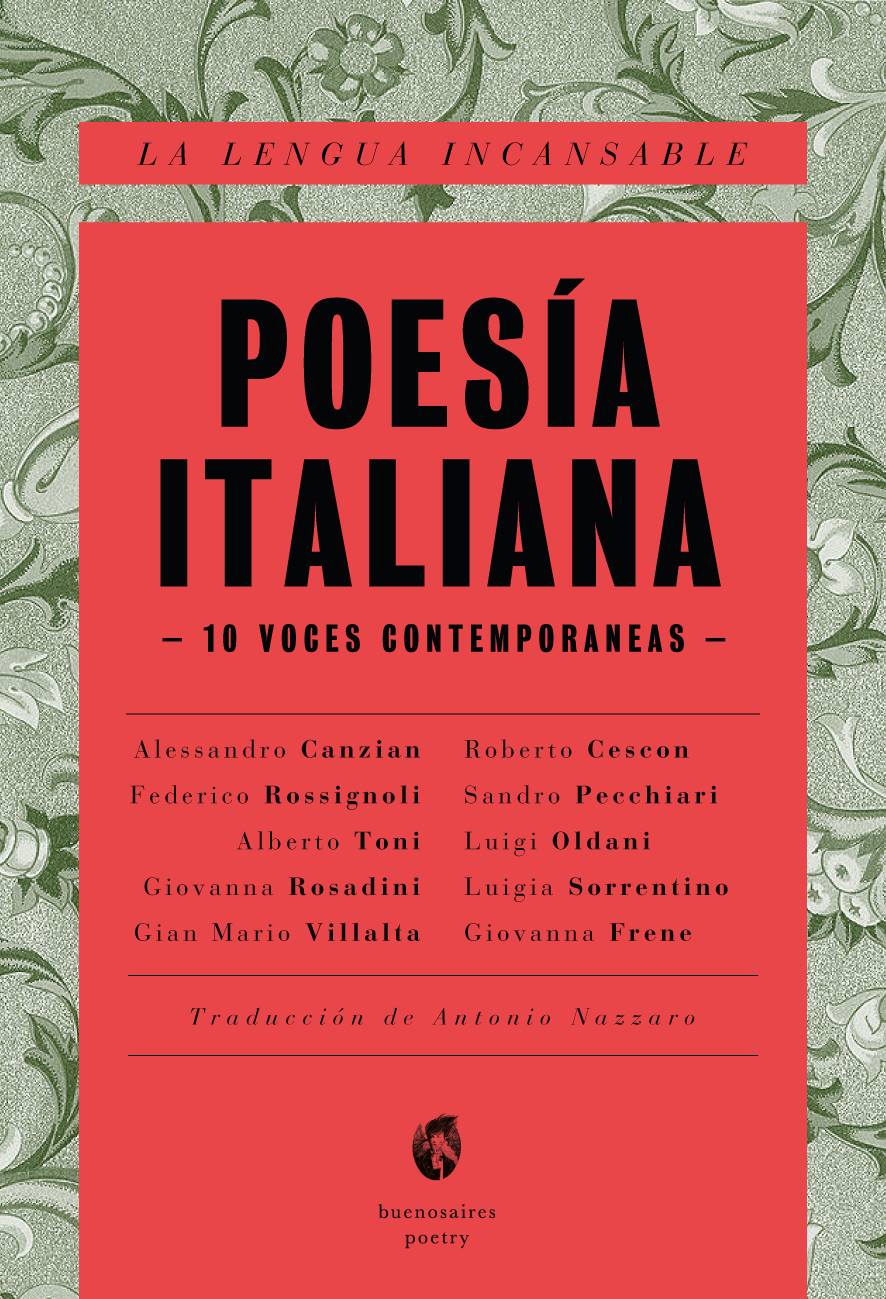Andrea Zanzotto
In questi giorni abbiamo celebrato il centenario della nascita e il decennale della morte di Andrea Zanzotto, il poeta di Pieve di Soligo Versato nel 2000 del quale ci hanno parlato Andrea Cortellessa con la sua monografia, Zanzotto. Il canto nella terra (Editori Laterza, 2021), Alberto Russo Previtali con Le estreme tracce del sublime. Studi sull’ultimo Zanzotto (Mimesis, 2021) e Pasolini e Zanzotto. Due poeti per il terzo millennio (Franco Cesati Editore, 2021) con saggi di Giorgia Bongiorno, Matteo Giancotti, Massimo Natale, Jean Nimis, Giuliana Nuvoli, Alberto Russo Previtali, Luca Stefanelli, Luigi Tassoni, dei quali libri hanno scritto su questo blog, Giovanna Frene e Chiara Fattorini. Non poteva mancare l’appuntamento in memoria di uno dei maggiori poeti del Secondo Novecento, la Laudatio funebris che Stefano Dal Bianco ha tenuto nel giorno del funerale di Zanzotto nel Duomo di Pieve di Soligo, il 21 ottobre 2011.
(Luigia Sorrentino)
DI STEFANO DAL BIANCO
Andrea Zanzotto era uno che ti metteva di fronte al fatto evidente, incontrovertibile, che noi non siamo tutti uguali. Non siamo uguali nella vita, perché ognuno ha ricevuto i suoi talenti specifici, in quantità e in qualità, e non lo siamo davanti alla morte, perché qualcuno si è impegnato più di altri per farli fruttare, i suoi talenti. A fronte di un corredo straordinario di talenti, Andrea Zanzotto si era assunto in pieno la responsabilità di farlo fruttare, questo corredo. Ed è evidente che la sua non è stata una passeggiata, e quanto abbia dovuto pagare quotidianamente il suo impegno in questo senso.
Non era uno che si assecondava. Non era uno che si dava credito. Era uno che in tutti i giorni della sua vita – in quello che ha fatto, in quello che ha detto, in quello che ha scritto – si è posto sempre, prima di tutto, contro se stesso.
Non so se sia mai esistito un grande poeta che non abbia questa disposizione come fondamento della sua grandezza.
Ci chiediamo tutti dove possa essere Andrea Zanzotto in questo momento, e la risposta forse non è tanto complicata: credo che sia dove è sempre stato, e cioè un po’ qui e un po’ non qui.
Quelli che l’hanno conosciuto, o anche solo incontrato una volta, sanno bene a che cosa mi riferisco: Andrea è sempre stato un po’ «non qui». Non potevi mai averlo «tutto per te», né lui né la sua poesia. Era impossibile. Perché lui, come la sua poesia, doveva fare i conti con tutto, doveva inglobare tutto, doveva costantemente misurarsi con le cause prime. E il messaggio che ti mandava, il messaggio che emanava dalla sua persona era sempre qualcosa come: «Ricorda che chi non ha capito tutto non ha capito niente».
Che cosa aveva capito, Andrea Zanzotto. Lui che fino agli ultimi giorni insisteva nell’annettersi alla schiera di coloro che non hanno capito niente, come tutti noi.
Negli ultimi dieci anni aveva trovato una sua serenità di fondo, e negli ultimi due libri che ha scritto (Sovrimpressioni e Conglomerati) questo si vede bene perché lui passa di là, passa dall’altra parte. Dà del tu agli dèi che sono nel paesaggio. Parla dell’esistenza di un’altra razionalità, parla di «altre ragioni» in seno alla Natura.
A un certo punto, nelle poesie (siamo nel 2001), il suo ‘personaggio’ si dà per morto, assieme alla Natura. Cioè: il soggetto che scrive e la Natura si trovano assunti in una stessa morte reciproca.
Poi – in Conglomerati – qualcun altro si trova a girare per i versi e in una Natura ormai del tutto plastificata.
Questo personaggio si presenta come il Doppio di se stesso redivivo, come un perispirito, come un corpo lunare, o anche come un «povero cristo» risorto e plastificato a sua volta.
Poi, sempre in Conglomerati, ancora succede che questo Doppio muore di nuovo, incontra il suo Inferno specifico. Ma comunque continua a esistere: come dice lui stesso: si mette «tre volte invano sul chi vive». Attraversa anche il Purgatorio nelle sue fasi, il Paradiso Terrestre, il Paradiso con tutti i cieli ed esce fuori. Esce fuori dal Paradiso: quindi è al cospetto di Dio – del Dio dei poeti, che è lo stesso Dio degli scienziati – e gli dice: «Ci siamo ehi! pari pari».
È così che si apre l’ultima sezione di Conglomerati, che si intitola Versi casalinghi.
Cioè: questo uscire fuori, dopo tutte queste avventure trascendenti, questo trovarsi al cospetto di Dio, è chiamato casa. E infatti questo uscire fuori non è altro che trovarsi a passeggiare nel solito sentiero di Solighetto. È un essere qui, fra di noi, come non mai. È anche finalmente quindi un abitare la Terra… Continua a leggere



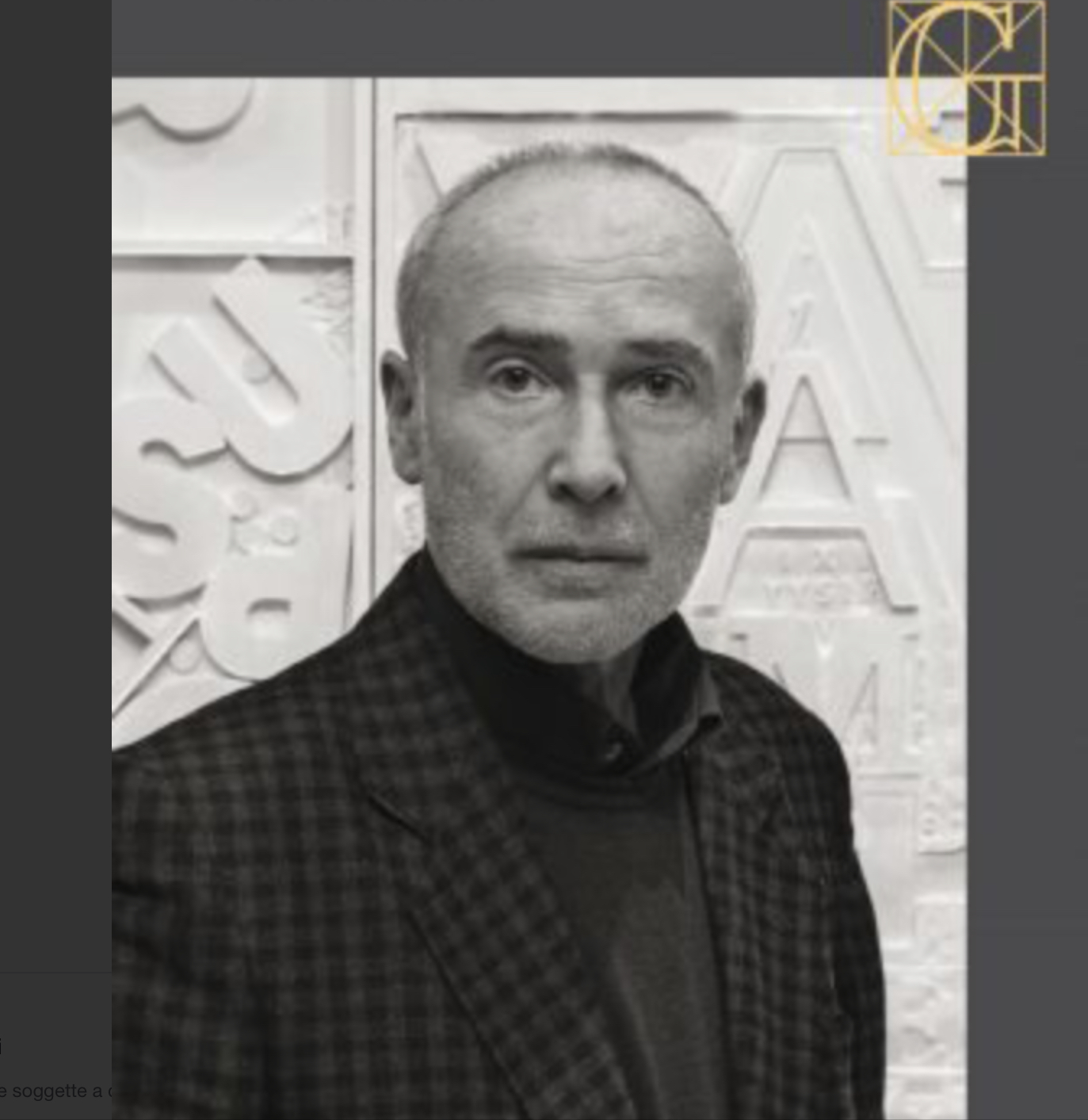 Appunti sul paesaggio in Andrea Zanzotto e Mario Benedetti
Appunti sul paesaggio in Andrea Zanzotto e Mario Benedetti A TRIESTE E DUINO GIOVANI POETI DA TUTTO IL MONDO PER UNDICI GIORNATE DEDICATE ALLE CULTURE DEL NOSTRO PIANETA
A TRIESTE E DUINO GIOVANI POETI DA TUTTO IL MONDO PER UNDICI GIORNATE DEDICATE ALLE CULTURE DEL NOSTRO PIANETA