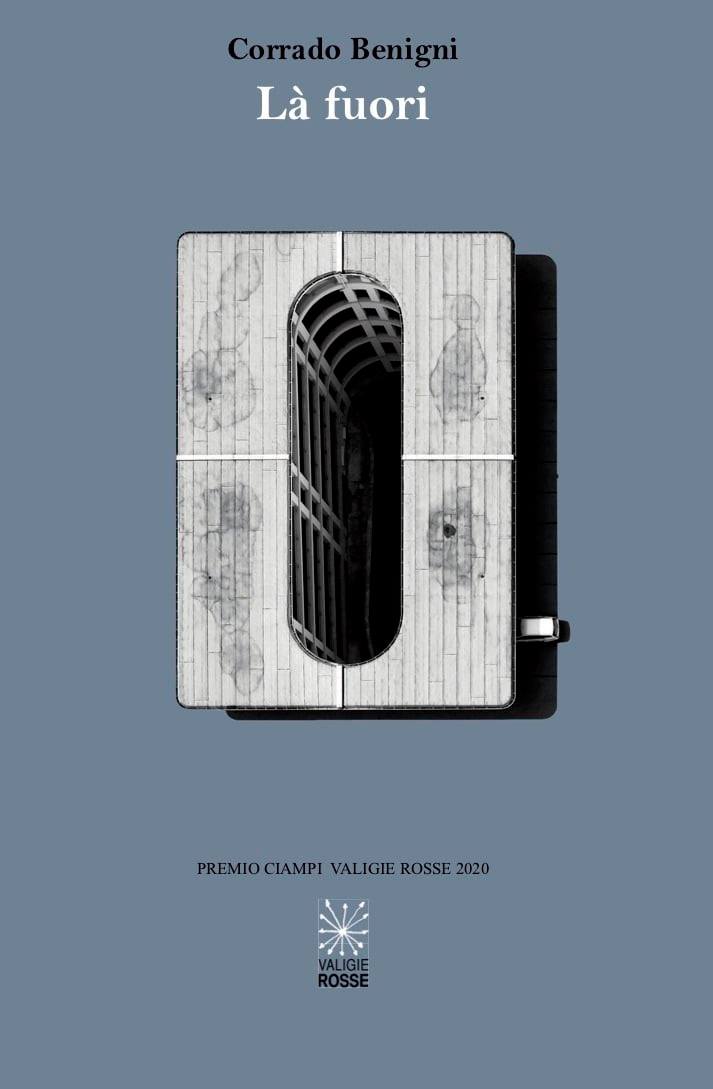NOTA DI LUIGIA SORRENTINO
Lunedi 23 agosto 2021 la notizia della morte a Strasburgo a 81 anni di Jean-Luc Nancy, il grande filosofo francese discepolo di Jacques Derrida.
Jean-Luc Nancy ha scritto opere indimenticabili tradotte In molti paesi del mondo.
Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Essere singolare plurale, (Einaudi, 2001); La creazione del mondo (Einaudi, 2003); i due volumi di Decostruzione del cristianesimo (Cronopio, 2007-2012), Sull’amore (Bollati Boringhieri, 2009); Politica e essere con. Saggi, conferenze, conversazioni (Mimesis, 2013); Prendere la parola (Moretti&Vitali, 2013) e Noli me tangere (Centro ediotoriale Dedhoniano, 2015).
Con Nancy, uno dei maggiori protagonisti della discussione filosofica contemporanea, avevamo cominciato a scriverci con una certa regolarità da febbraio 2020, fino all’ aprile di quest’anno, e cioè da quando, in piena pandemia, avevo dato vita, sul blog, al progetto Catena Umana/Human Chain, un dialogo a più voci fra diverse discipline umanistiche nel tempo del Coronavirus. A prendere la parola sulla “crisi globale” innescata dal Covid 19, il 29 maggio 2020, era stato proprio Jean-Luc Nancy, con un’intervista a me rilasciata pochi giorni prima.
Quest’anno, in una fredda mattina di gennaio, Nancy mi inviò per email un suo testo inedito scritto a dicembre 2020, Hymne Stomique, che qui pubblico integralmente per la prima volta e in lingua originale.
E’ un testo di rara bellezza. Custodisce un mistero che ognuno potrà fare suo.
Unica indicazione per lettore che vorrà cimentarsi nella traduzione nei commenti del blog: la parola “stoma” deriva dal greco e significa “bocca”, qui da intendersi come “figlia del respiro“. La bocca per Nancy è il luogo dell’accadere, è l’esperienza del toccare, del toccarsi, è la nudità del mondo che non ha origine né fine.
HYMNE STOMIQUE
Jean-Luc Nancy, décembre 2020
Chant premier
Fille du Souffle et de la Chère,
père exhalé, mère absorbée
en toi par toi dans ta trouée
comme le veut l’ordre des choses
mâle aspiré dans les nuées,
femelle sucée avalée,
toi passage dedans dehors
en haut en bas et leurs mêlées,
leur brassage leur masticage
– Mastax fut de ta parenté –
toi la mêleuse la brouilleuse
souveraine des amalgames
amal al-djam’a al-modjam’a
ou malagma du malaxer
toujours l’un qui dans l’autre passe
en transmutation d’alchymie
toi la parleuse la mangeuse
la discoureuse la buveuse
la clameuse la dévoreuse
salut, Stoma commissures humides
rejointes disjointes
viande en logos, mythos en bave
salut, toi seule véritable
seule réelle dialectique ! Continua a leggere


 Florenskij insegna che esistono due prospettive, la lineare e la rovesciata. La lineare è quella introdotta dal Rinascimento fiorentino: il punto di fuga che ordina la scena sfonda il quadro nella direzione che va dall’occhio alla rappresentazione. La prospettiva lineare è l’effetto di uno sguardo che si inabissa in un infinito che è sua proiezione.
Florenskij insegna che esistono due prospettive, la lineare e la rovesciata. La lineare è quella introdotta dal Rinascimento fiorentino: il punto di fuga che ordina la scena sfonda il quadro nella direzione che va dall’occhio alla rappresentazione. La prospettiva lineare è l’effetto di uno sguardo che si inabissa in un infinito che è sua proiezione.