 di LORENZO CHIUCHIU’
di LORENZO CHIUCHIU’
Il testo proposto è parte di una conferenza che Camus tenne ad Atene nel 1955. La traduzione integrale è uscita su Davar III (Reggio Emilia 2006) e su “La Repubblica” del 18/11/2006.
Il tragico e la sua «immobilità forsennata», le «duplici maschere del bene e del male»; il «tutto è bene» simile all’attuale «andrà tutto bene»; la responsabilità del singolo di fronte alla dismisura della storia (per Camus la guerra fredda, per noi la globalizzazione) e delle potenze che la attraversano (la tecnica, le guerre convenzionali e quelle economiche, la peste che colpisce i corpi e quella che svuota il senso delle parole); il teatro di propaganda che somiglia alle retoriche politiche di oggi.
Camus, come tutti classici, precorre i tempi o li dissolve, fa impallidire cronaca e sociologia: a volte la storia assume il volto del destino e l’ultima parola spetta alle esistenze libere, inquiete e in rivolta.
Sull’avvenire della tragedia
di Albert Camus
Un saggio orientale nelle sue preghiere chiedeva alla divinità di risparmiargli di vivere in un’epoca interessante. E la nostra epoca è interessante, vale a dire tragica. Per purificarci dai nostri mali, abbiamo almeno il teatro della nostra epoca o possiamo sperare di averlo? In altre parole, è possibile la tragedia moderna? È questa la domanda che vorrei porre oggi. Ma questa domanda è ragionevole? O piuttosto è del tipo: «avremo un buon governo?» o «i nostri scrittori diverranno modesti?» o ancora «i ricchi spartiranno presto la loro fortuna con i poveri?», domande interessanti, ma che danno più da sognare che da pensare.
Credo di no. Credo invece che per due ragioni ci si possa interrogare legittimamente sulla tragedia moderna. La prima è che i grandi periodi dell’arte tragica si collocano, nella storia, in secoli di transizione, in momenti in cui la vita dei popoli è ad un tempo carico di gloria e di minacce. Dopo tutto Eschilo combatte due guerre e Shakespeare è contemporaneo di una bella serie di orrori. Inoltre entrambi si trovano in una sorta di pericolosa svolta nella storia della loro civiltà.
Si può rilevare che nei trenta secoli della storia occidentale, dai Dori fino alla bomba atomica, non ci sono che due periodi dell’arte tragica, entrambi circoscritti nello spazio e nel tempo. Il primo è il greco, presenta una grande unitarietà e dura un secolo, da Eschilo a Euripide. Il secondo dura poco più e fiorisce nei paesi limitrofi ai confini dell’Europa occidentale. In effetti, non si è sottolineato a sufficienza che la magnifica esplosione del teatro elisabettiano, il teatro spagnolo del secolo d’oro e la tragedia francese del XVII secolo sono pressoché contemporanei. Quando Shakespeare muore, Lope De Vega ha cinquantaquattro anni e ha già fatto rappresentare la gran parte delle sue pièces; Calderón e Corneille sono vivi. L’intervallo di tempo fra Shakespeare e Racine non è più lungo di quello fra Eschilo e Euripide. Almeno storicamente possiamo considerare che si tratta, con estetiche differenti, di una sola e magnifica fioritura, quella del Rinascimento, che nasce nel disordine ispirato al palcoscenico elisabettiano e raggiunge la perfezione formale nella tragedia francese. Continua a leggere

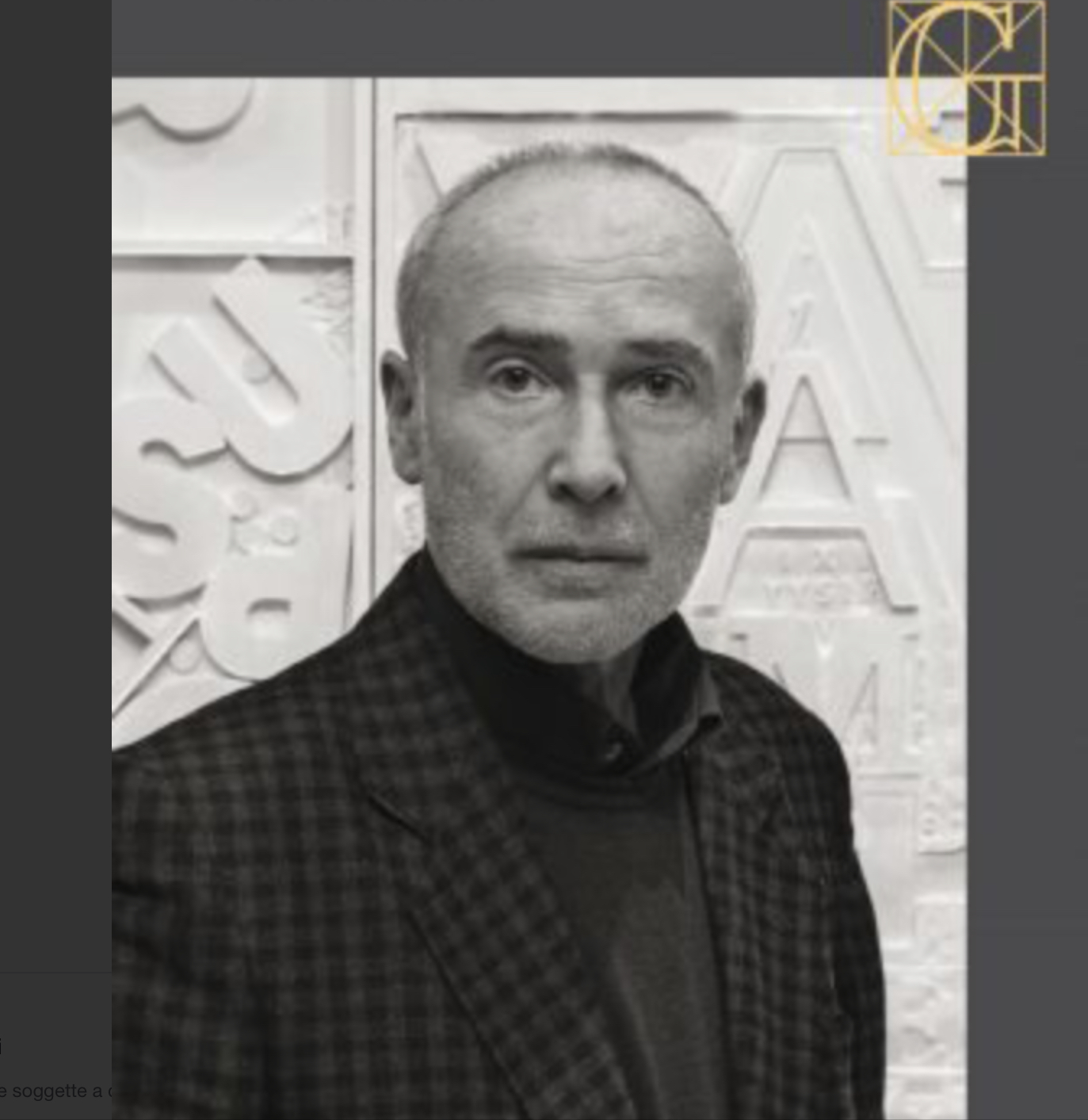 di Lorenzo Chiuchiù
di Lorenzo Chiuchiù In occasione della imminente presentazione a Pordenonelegge (giovedì 19 settembre) della nuova edizione di
In occasione della imminente presentazione a Pordenonelegge (giovedì 19 settembre) della nuova edizione di 