
E’ morto il filosofo Emanuele Severino. E’ scomparso a Brescia lo scorso 17 gennaio ma si è saputo soltanto oggi, per sua volontà.
Il filosofo, che avrebbe compiuto 91 anni il 26 febbraio, è stato già cremato. Severino è stato uno dei più grandi filosofi, scrittori e intellettuali viventi.
“Avvicinarsi alla morte è avvicinarsi alla gioia, ma alludo al superamento di ogni contraddizione che attraversa la nostra vita perchè siamo costantemente nello squilibrio e nell’instabilità: non ci attende la reincarnazione o la resurrezione, ma qualcosa di infinitamente di più”.
Così scriveva e ripeteva spesso, nelle sue lectio e nei suoi incontri, Emanuele Severino, morto il 17 gennaio a Brescia, che aveva compiuto 90 anni il 26 febbraio 2019. Un pensiero radicale, il suo, che per la negazione del ‘divenire’ lo ha portato ad un conflitto con la chiesa cattolica al punto che nel 1968, 4 anni dopo aver pubblicato ‘Ritornare a Parmenide’, su sua richiesta venne istruito un processo dall’ex Sant’Uffizio, che dichiarò la sua filosofia incompatibile con il cristianesimo. Un pensiero che Severino, considerato uno dei più grandi filosofi, scrittori e intellettuali del Novecento, ha coltivato facendo riferimento, oltre che a Parmenide, ad Aristotele, Eraclito, Hegel, Nietzsche, Leopardi. Continua a leggere

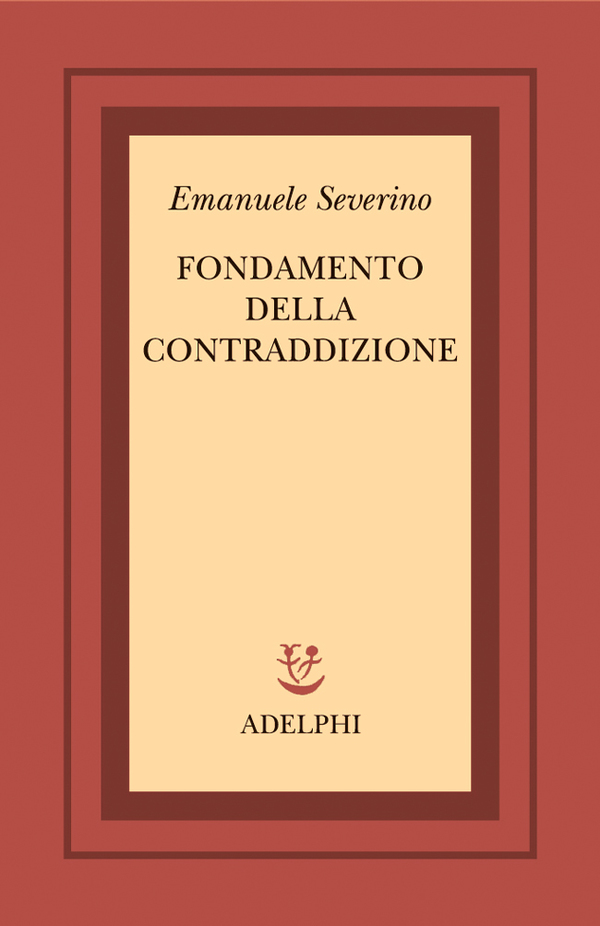
 Nota di Luigia Sorrentino
Nota di Luigia Sorrentino
 E’ nelle librerie italiane l’ultima opera di uno dei più importanti filosofi viventi, Emanuele Severino,DIKE, Biblioteca Filosofica Adelphi, (luglio 2015).
E’ nelle librerie italiane l’ultima opera di uno dei più importanti filosofi viventi, Emanuele Severino,DIKE, Biblioteca Filosofica Adelphi, (luglio 2015).