
ANTEPRIMA EDITORIALE
In occasione del centenario della nascita di Andrea Zanzotto si propone l’introduzione di Alberto Russo Previtali al volume Pasolini e Zanzotto: due poeti per il terzo millennio, Franco Cesati Editore, 2021.
PASOLINI E ZANZOTTO NEL TEMPO DELL’ANTROPOCENE
di Alberto Russo Previtali
«I poeti, che non sanno quel che dicono, è ben noto, dicono però sempre le cose prima degli altri»[1] . Questo aforisma di Jacques Lacan potrebbe essere eletto a criterio supremo per stabilire chi può essere definito “poeta”. Se pensiamo a Pasolini e Zanzotto in base ad esso, non possiamo che vedere in loro dei poeti nel senso più profondo della parola. La loro fedeltà radicata ai valori più propri della poesia, al suo «fertilissimo stupore»[2], alla vocazione della sua parola sorgiva, ha permesso a questi poeti di sentire in anticipo gli aspetti negativi dei cambiamenti irrevocabili avvenuti nel dopoguerra, denunciandoli, e producendo su di essi una conoscenza poetica singolare e insostituibile. Zanzotto è nato il 10 ottobre 1921, Pasolini il 5 marzo 1922: a un secolo dalla loro nascita sono incontestabilmente due delle figure maggiori della letteratura italiana del secondo Novecento. La loro influenza letteraria e artistica è crescente, così come l’interesse che i critici e gli studiosi di altre discipline portano sulle loro opere. È dunque doveroso chiedersi, oggi, cogliendo il tempo propizio delle ricorrenze e delle date: a che cosa è dovuta la prossimità particolare di questi poeti con noi, lettori del XXI secolo? Che cosa rende così essenziale, così intima, la loro presenza? Le risposte potrebbero essere molte, e di diverse appartenenze prospettiche. Ma ce n’è una che, probabilmente, è all’origine di tutte le possibilità interpretative: Pasolini e Zanzotto sono stati i testimoni poetici di un’epoca di profondissimi cambiamenti culturali, quelli determinati dalla trasformazione dell’Italia in un paese industriale con una moderna società dei consumi.
Gli intellettuali italiani nati nei primi decenni del Novecento si sono ritrovati negli anni della maturità a vivere i rivolgimenti rutilanti del miracolo economico. Come Pasolini ha ripetuto più volte, la radicalità delle mutazioni della società, il passaggio folgorante da un’economia prevalentemente agricola a un’economia industriale, fanno dell’Italia un caso esemplare di questa fase storica. Ed è proprio la velocità bruciante del cambiamento ad avere moltiplicato gli effetti negativi e traumatici dell’avvento della modernità, che si sono imposti come oggetto delle opere di numerosi scrittori, poeti, cineasti e artisti appartenenti a quella che Alfonso Berardinelli ha chiamato «l’ultima generazione cresciuta in un’Italia ancora premoderna», ovvero l’ultima generazione «che abbia vissuto nella sua maturità, fra i trenta e i quarant’anni, il trauma di un mondo noto e amato che si trasformava fino a scomparire»[3] . A partire dagli anni Sessanta, anche Pasolini e Zanzotto si confrontano apertamente nelle loro opere con il cambiamento in atto. Le mutazioni degli elementi essenziali del loro rapporto artistico con la realtà sono vissute come dei traumi che determinano delle rotture nei loro percorsi poetici e letterari. Si tratta di cambiamenti di direzione irreversibili, che saranno esplorati fino alla fine dei loro itinerari. In queste dinamiche, le esperienze di questi due poeti appaiono oggi più che mai caratterizzate da numerosi e rilevantissimi punti in comune, che trovano riscontro negli interventi critici che si sono dedicati l’un l’altro nel corso dei decenni. Esplorare e ricostruire i rapporti tra le opere di Pasolini e Zanzotto è quindi certamente il primo fine del presente saggio, che si propone di offrire un ritratto critico “allo specchio” dei due poeti: per ricostruire le loro convergenze, ma anche per dare risalto ai rispettivi tratti singolari. La conferma più densa del buon orientamento di questo progetto ci viene da una poesia in dialetto di Zanzotto, Ti tu magnéa la tó ciòpa de pan, scritta in memoria di Pasolini e inserita nella raccolta Idioma del 1986:
Ti tu magnéa la tó ciòpa de pan
sul treno par andar a scola
a Sazhil e Conejan;
mi ere póch lontan, ma a quei tènp là
diese chilometri i era ’na imensità.
Cussita é stat che ’lora
do tosatéi no i se à mai cognossést.
[…]
Se se à parlà, pi avanti, se se à ledést;
zherte òlte ’von tasést o se a sticà,
la vita ne à parà sote straségne
e ciapà-dentro par tamài diversi,
mi fermo, inpetolà ’nte i versi
ti dapartut co la tó passion de tut;
ma pur ghe n’era ’n fil che ’l ne tegnéa:
de quel che val se ’véa l’istessa idea.
[Tu mangiavi il tuo pane
sul treno per andare a scuola
tra Sacile e Conegliano;
io ero poco lontano, ma a quei tempi
dieci chilometri erano un’immensità.
Così avvenne che allora
due ragazzetti non si sono conosciuti.
[…]
Più avanti, ci siamo parlati, ci siamo letti;
certe volte abbiamo taciuto o abbiamo litigato,
la vita ci ha spinti sotto sgocciolamenti di acqua fredda (colpi)
e presi in trappole diverse,
io fermo, impiastricciato nei versi,
tu dappertutto con la tua passione di tutto;
ma pur c’era un filo che sempre ci legava:
di ciò che vale avevamo la stessa idea][4]
Questa poesia ricorda in apertura la condivisione di una vicinanza geografica, che l’uso del dialetto rafforza e inserisce in un orizzonte più vasto e profondo, quello a cui si fa allusione nei due versi finali della seconda strofa, in uno dei punti più intensi del componimento: «ma pur c’era un filo che sempre ci legava / di ciò che vale avevamo la stessa idea». Dedicheremo nella seconda parte del volume un’attenzione specifica alla comprensione del filo comune tra Pasolini e Zanzotto, a questo «ciò che vale» in cui sembra essere racchiuso il segreto ultimo delle loro esperienze. Ma questi versi, scritti poco tempo dopo la morte di Pasolini, si pongono fin d’ora come la stella da seguire per orientare la nostra esplorazione. Poiché è in nome della «stessa idea» di questo «ciò che vale» che Pasolini e Zanzotto ci appaiono uniti nelle loro testimonianze poetiche di fronte agli «stravolgimenti dell’umano»[5] . Il senso di queste testimonianze, così legate al contesto particolare dell’Italia, assume oggi una rilevanza che ne oltrepassa le frontiere. Il valore delle loro opere, da un lato, e, dall’altro, l’esemplarità dello sviluppo economico italiano, hanno reso le loro esperienze altamente significative in una prospettiva europea e mondiale. È dunque possibile guardare oggi a Zanzotto e Pasolini come a due testimoni altissimi di quel fenomeno globale che alcuni storici e climatologi hanno ribattezzato, a posteriori, «Grande accelerazione»:
La progressiva crescita a cui si è assistito dal 1945 è stata tanto rapida da prendere il nome di Grande accelerazione. L’accumulo di anidride carbonica nell’atmosfera dovuto ad attività umane si è verificato per tre quarti della sua entità nel corso delle ultime tre generazioni. Il numero di veicoli a motore presenti sulla Terra è cresciuto da 40 milioni a 850 milioni. Gli abitanti del pianeta sono triplicati e il numero di quanti vivono in città è passato da circa 700 milioni a 3,7 miliardi. Nel 1950 la produzione mondiale di plastica ammontava all’incirca a un milione di tonnellate, ma nel 2015 si è arrivati a 300 milioni. Nello stesso arco temporale la quantità di azoto sintetizzato (principalmente per ottenere fertilizzanti) è passata da meno di 4 milioni di tonnellate a più di 85. La Grande accelerazione è ancora tale sotto alcuni aspetti, mentre altri – raccolta ittica marina, costruzione di maxi dighe e rarefazione dello strato di ozono – hanno cominciato a rallentare[6]. Continua a leggere





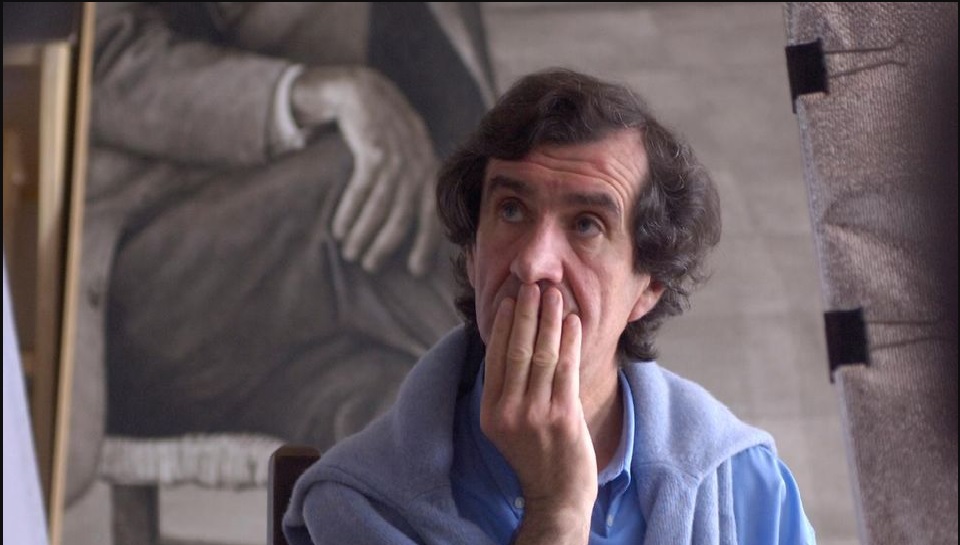 Ottave Scelte
Ottave Scelte

